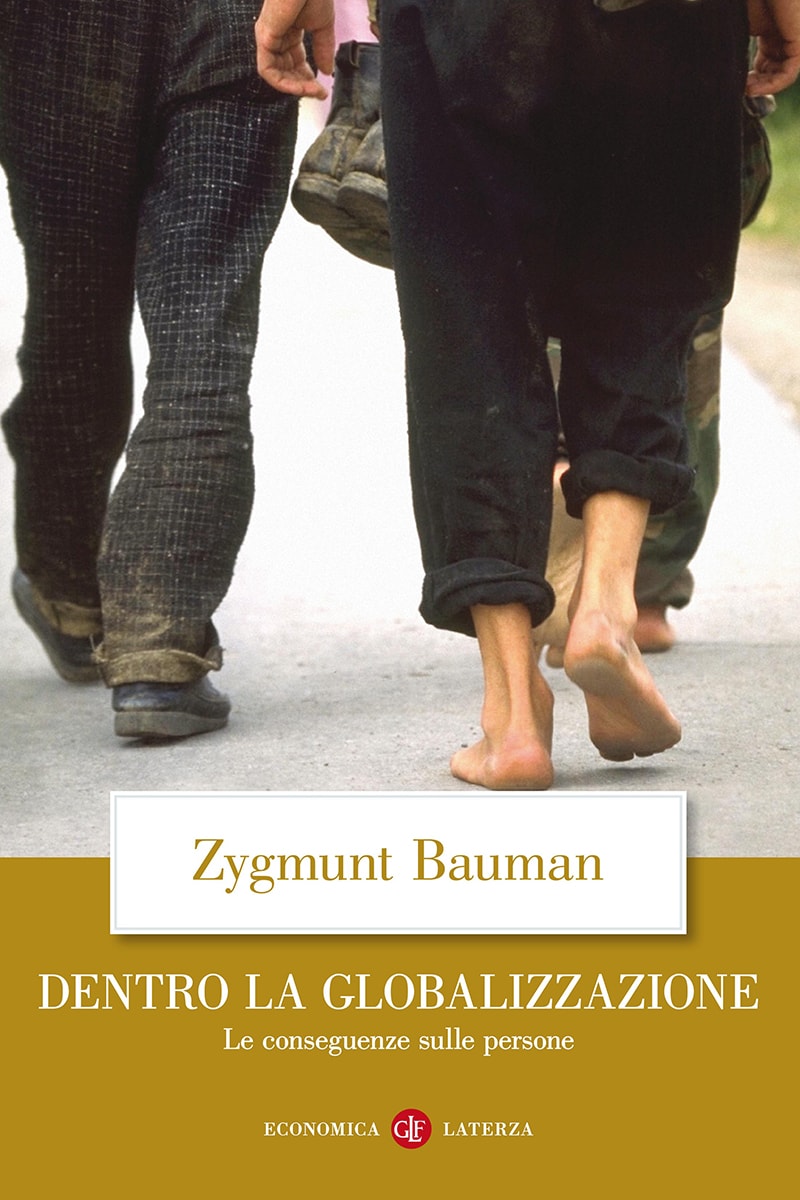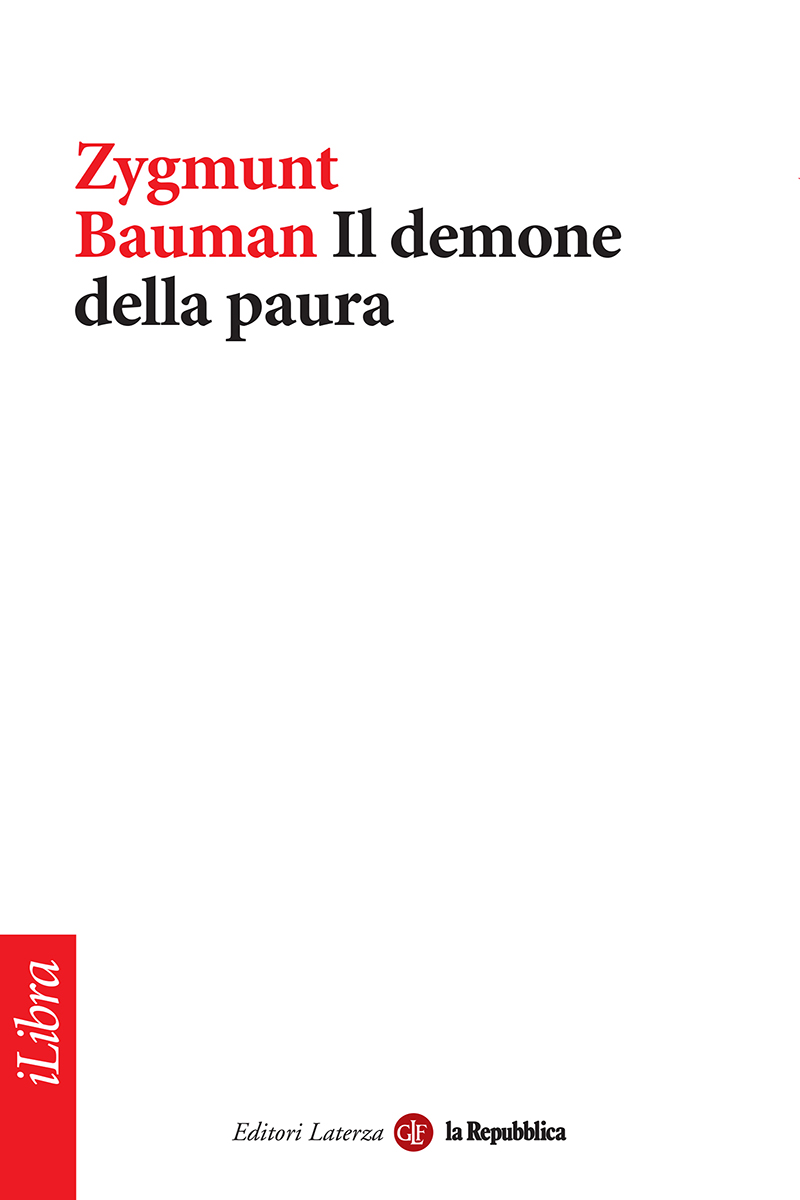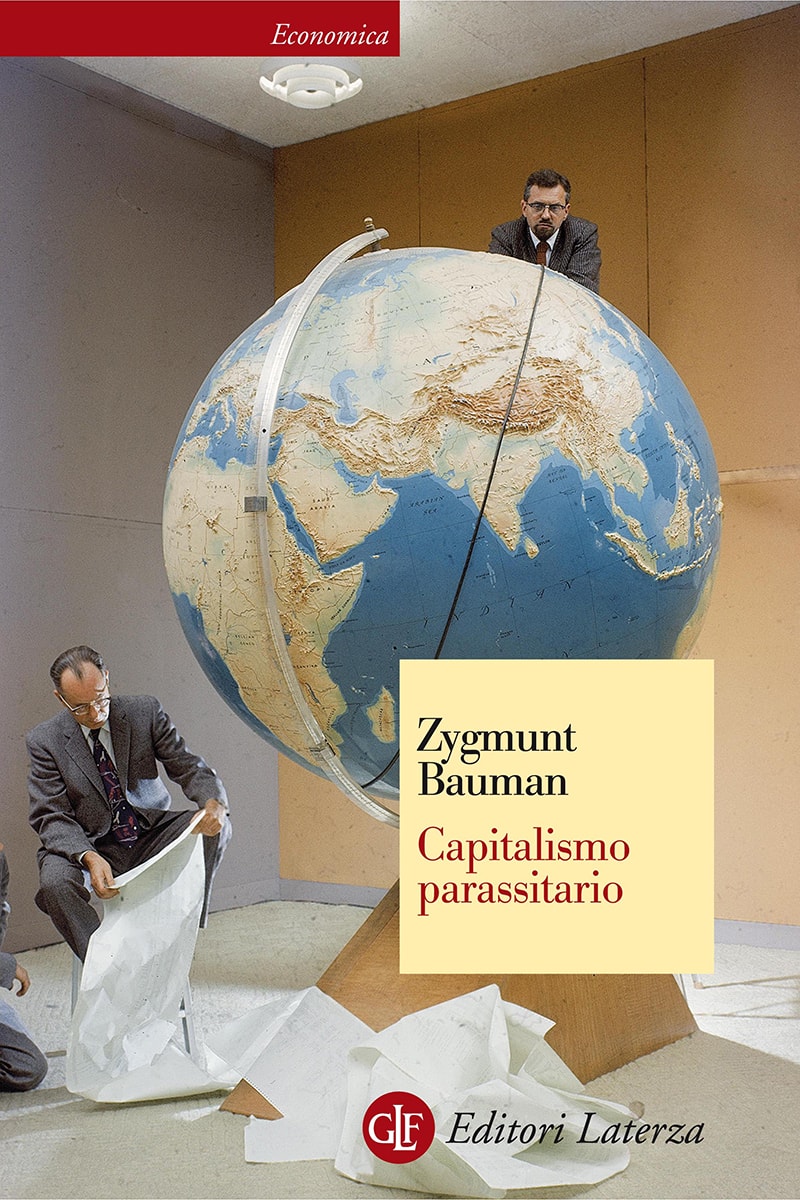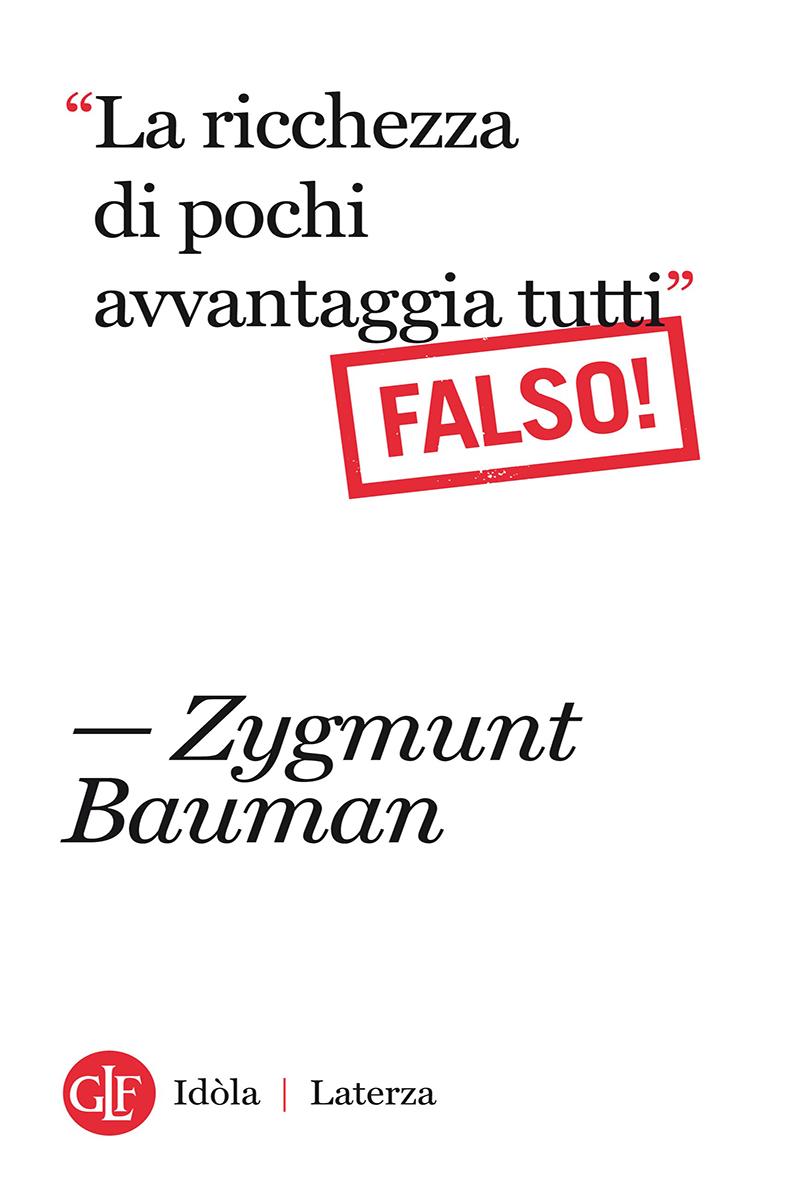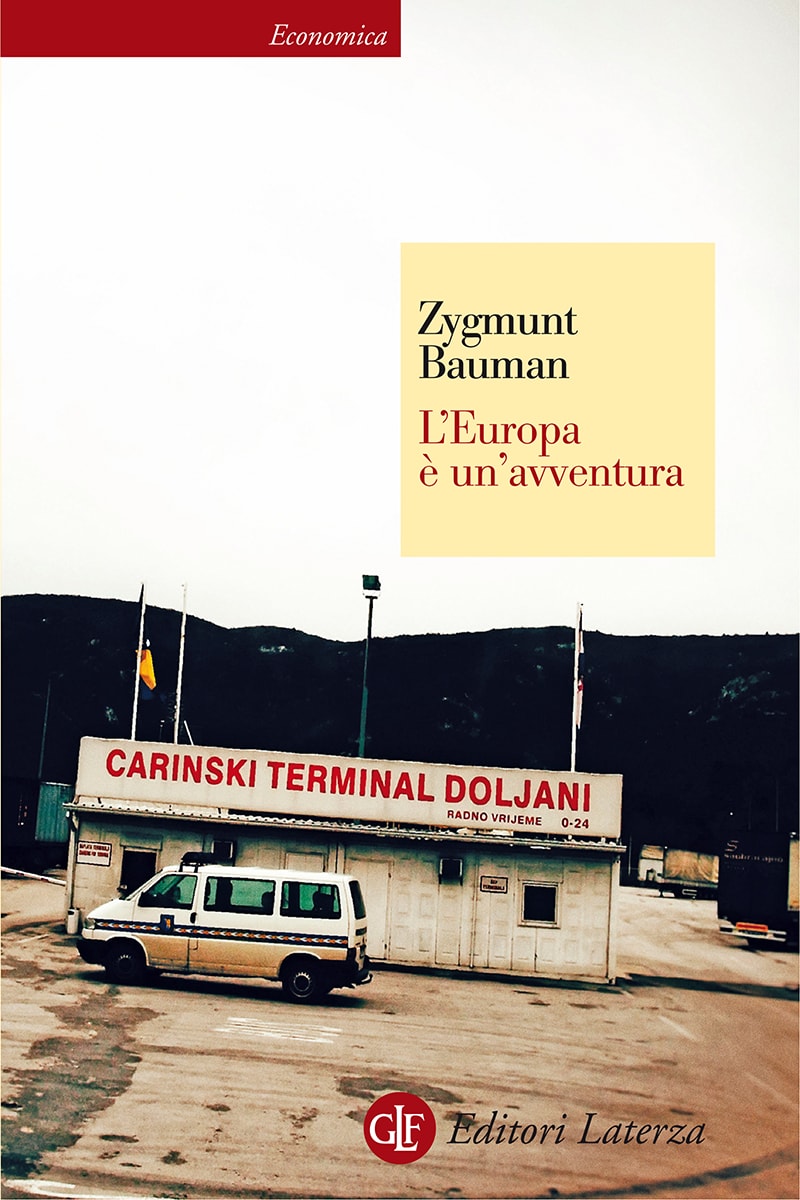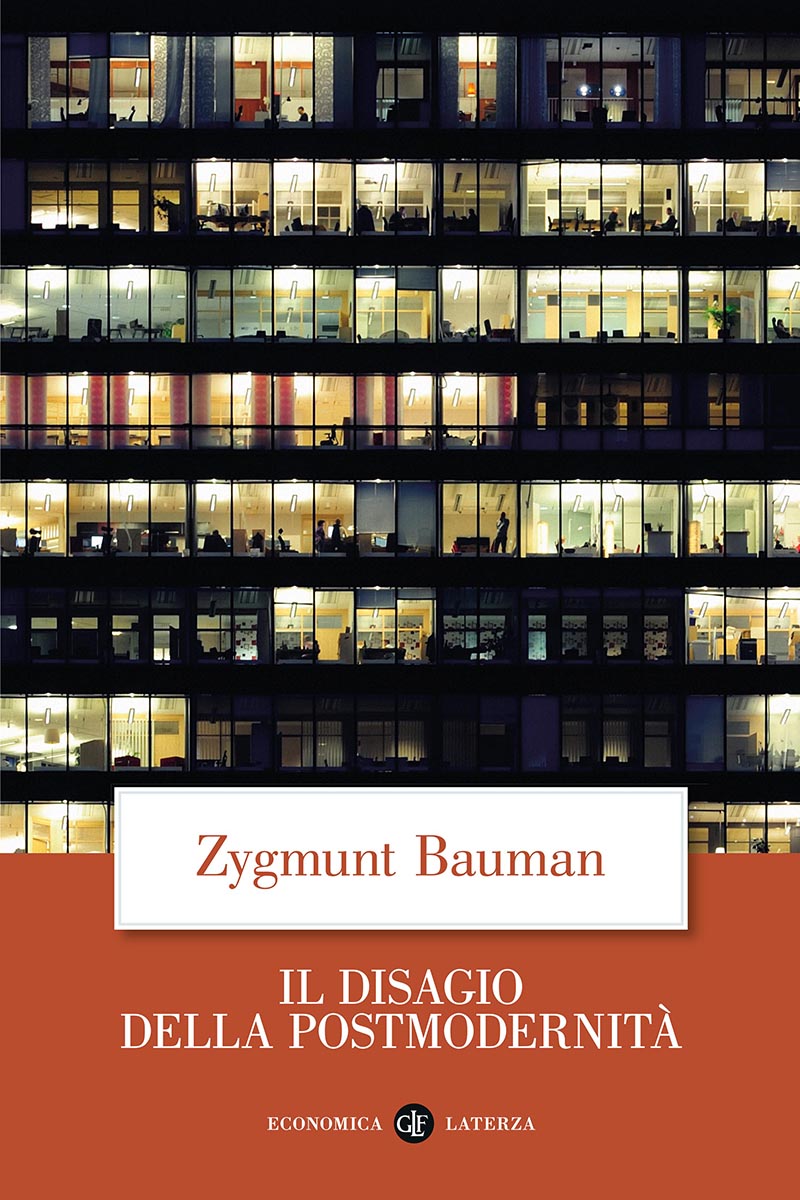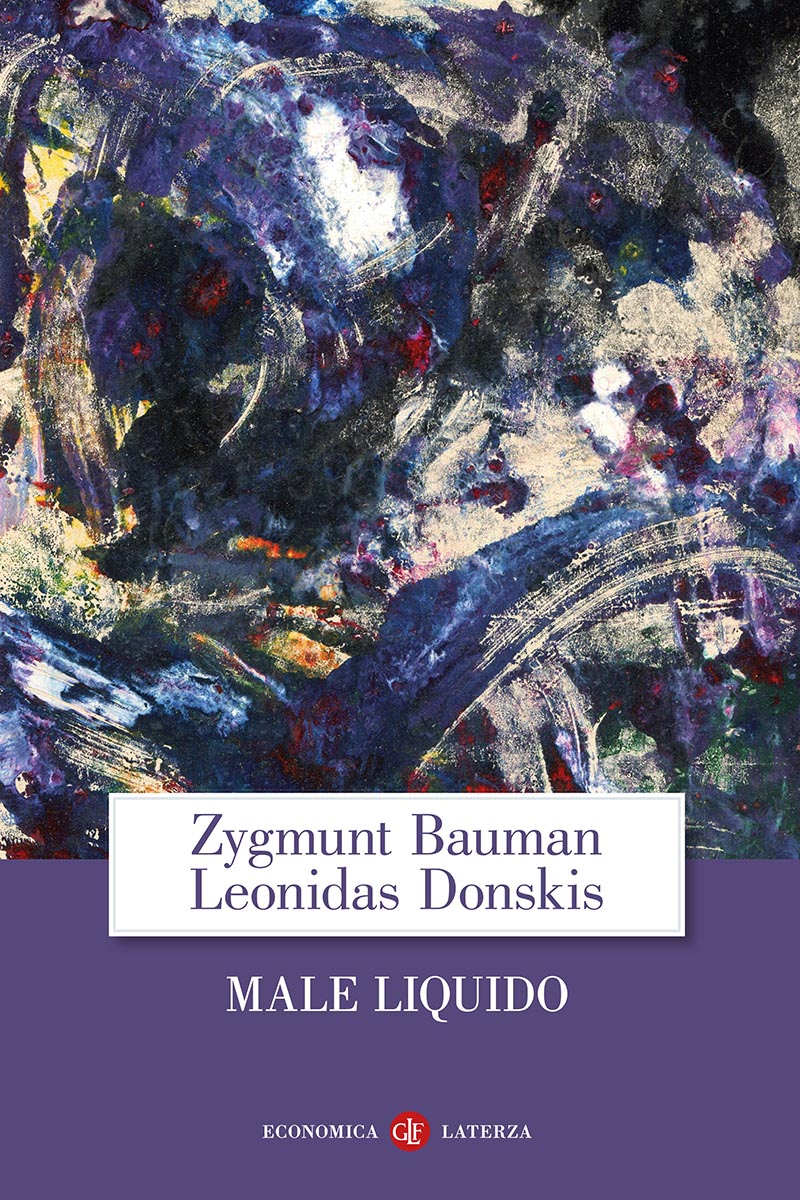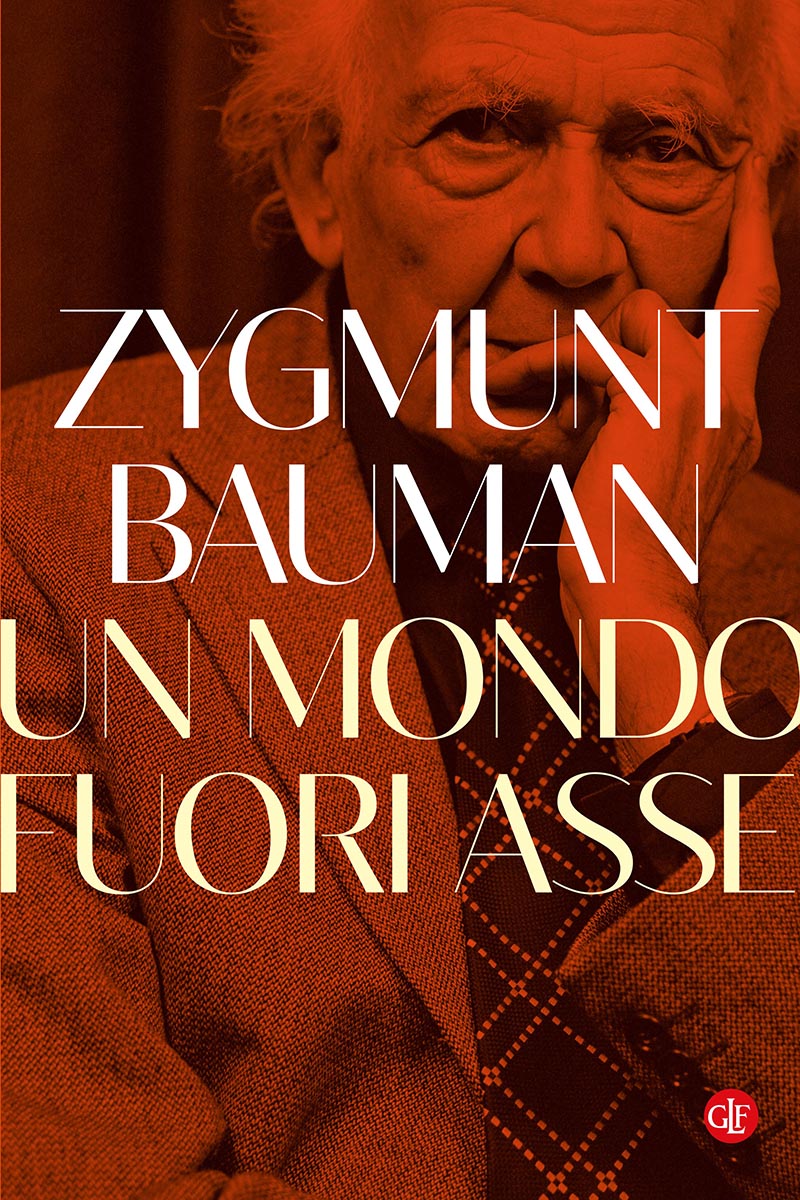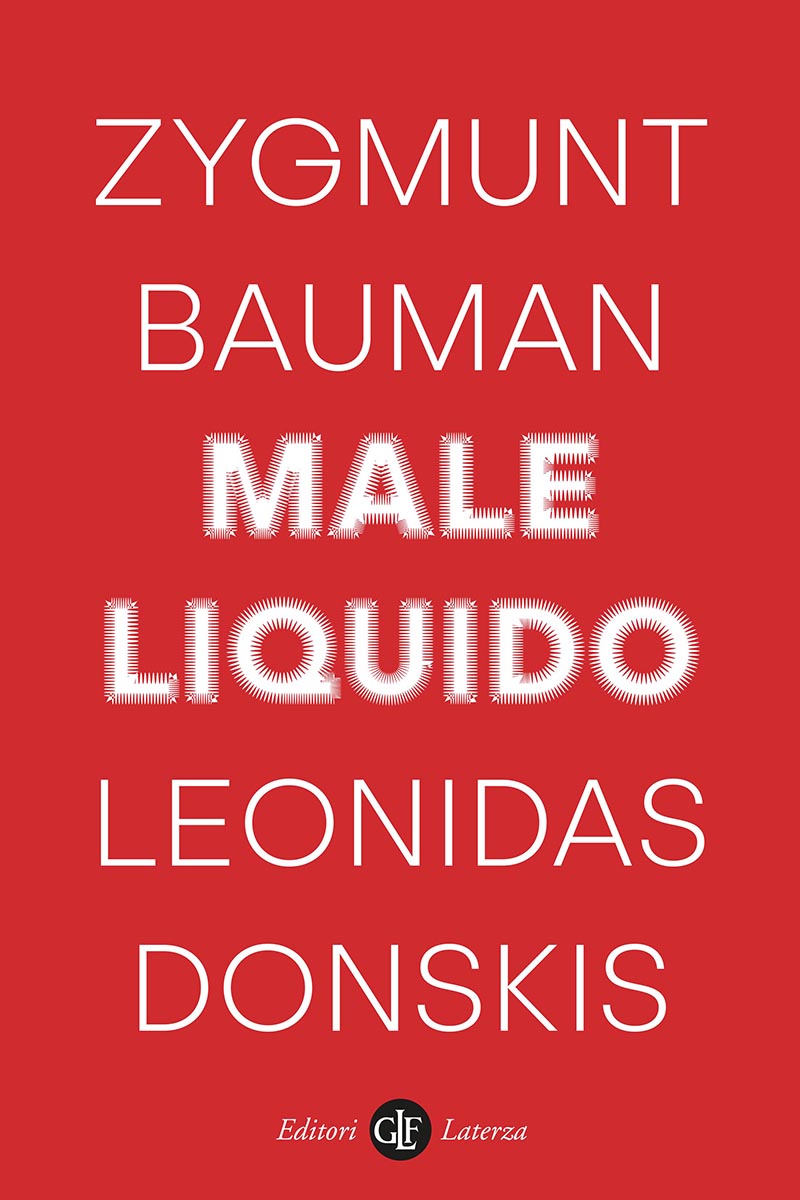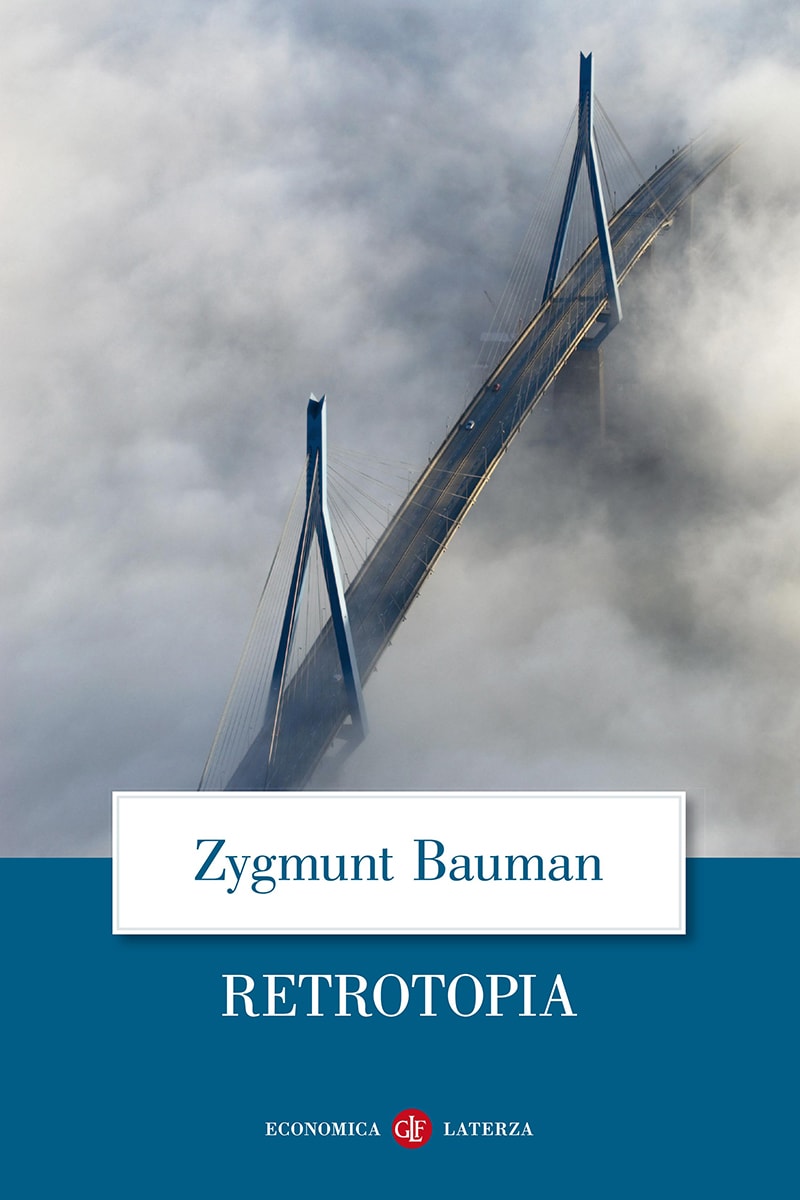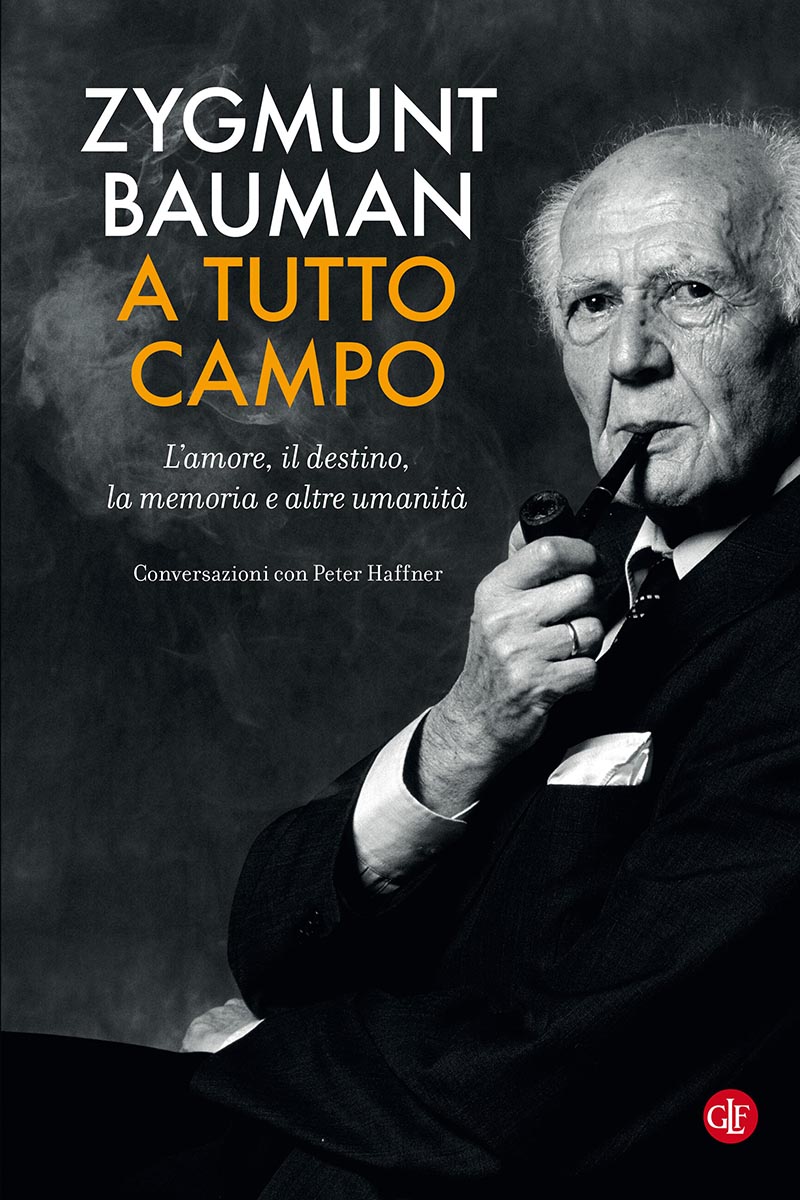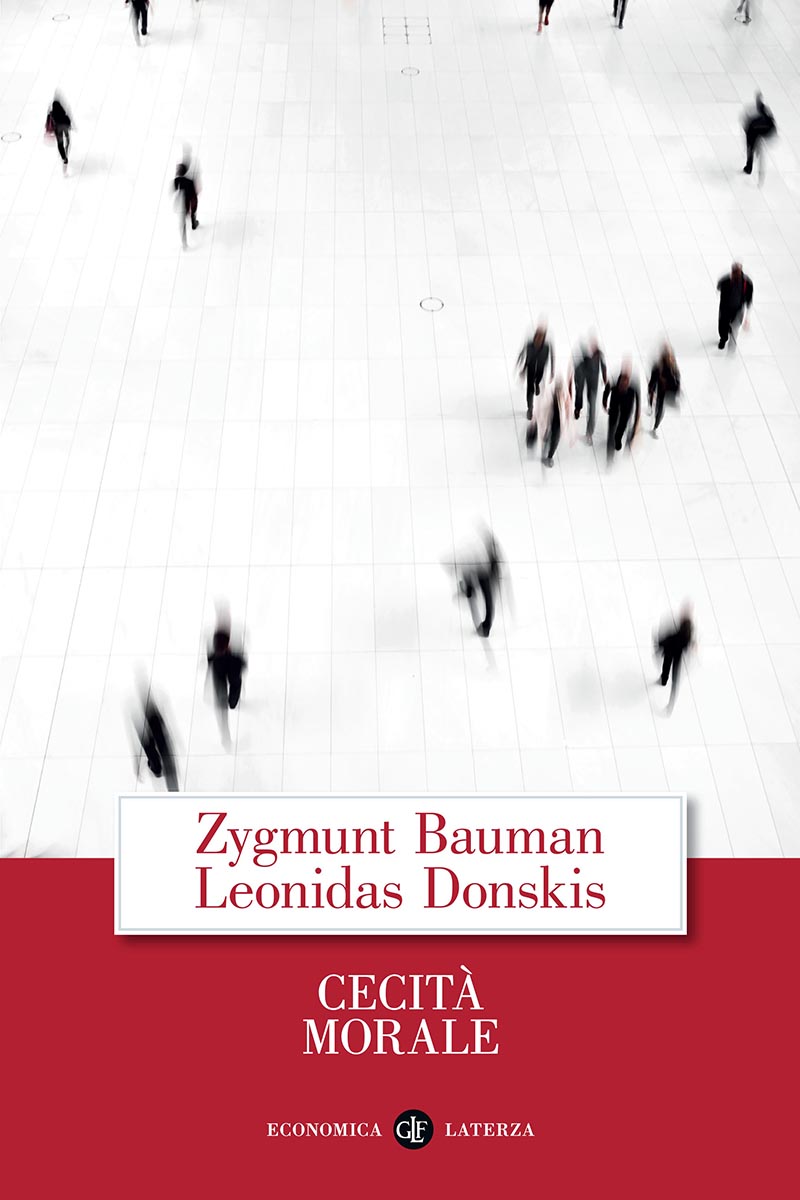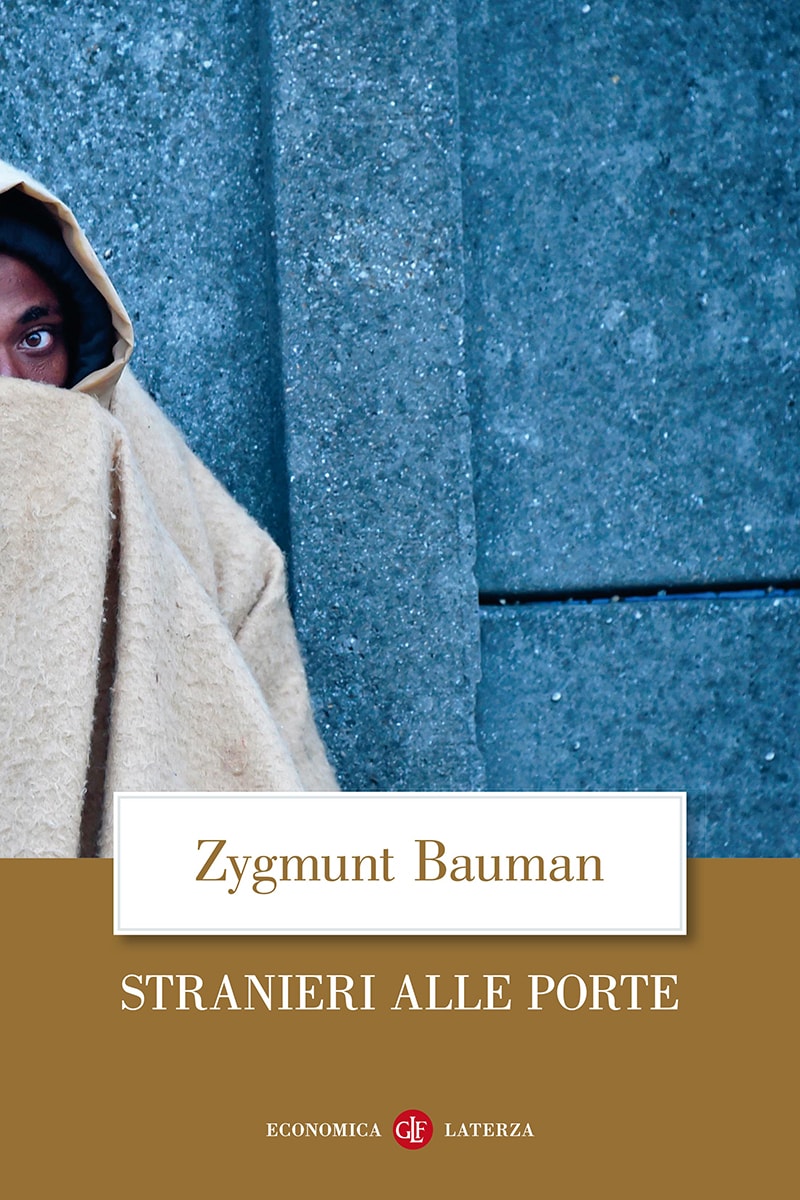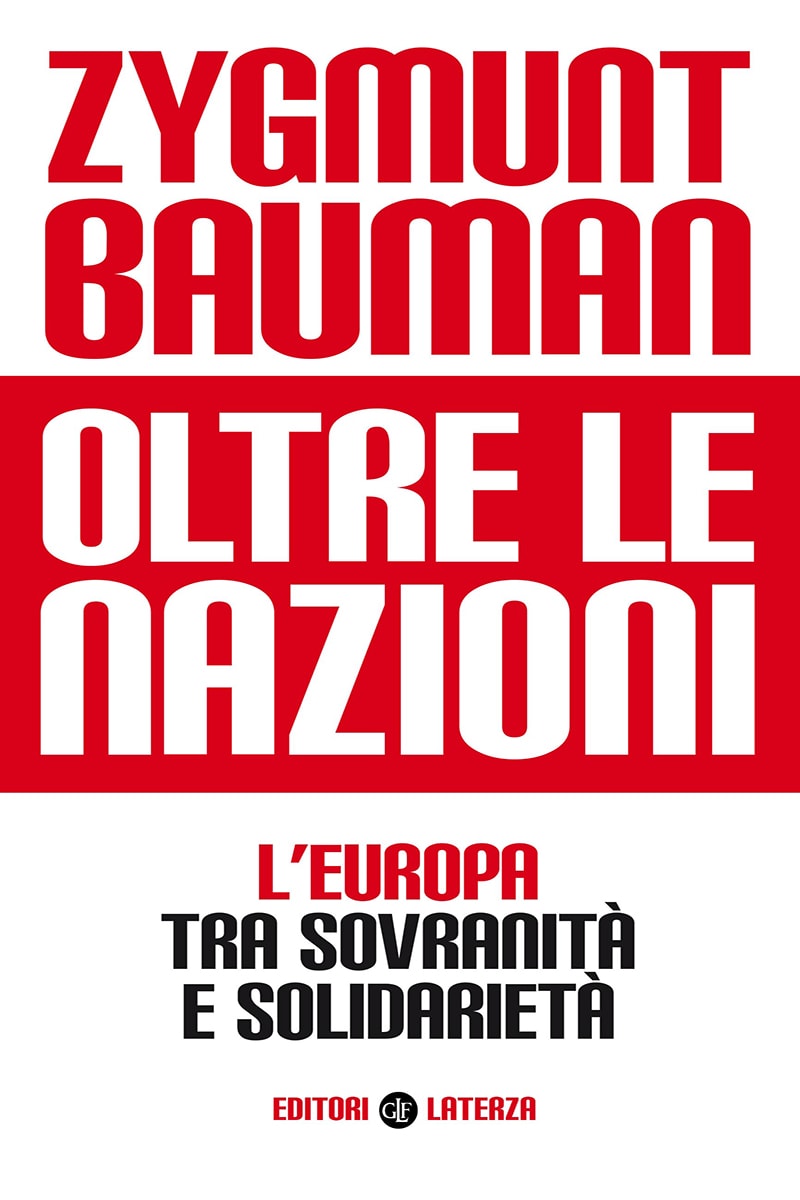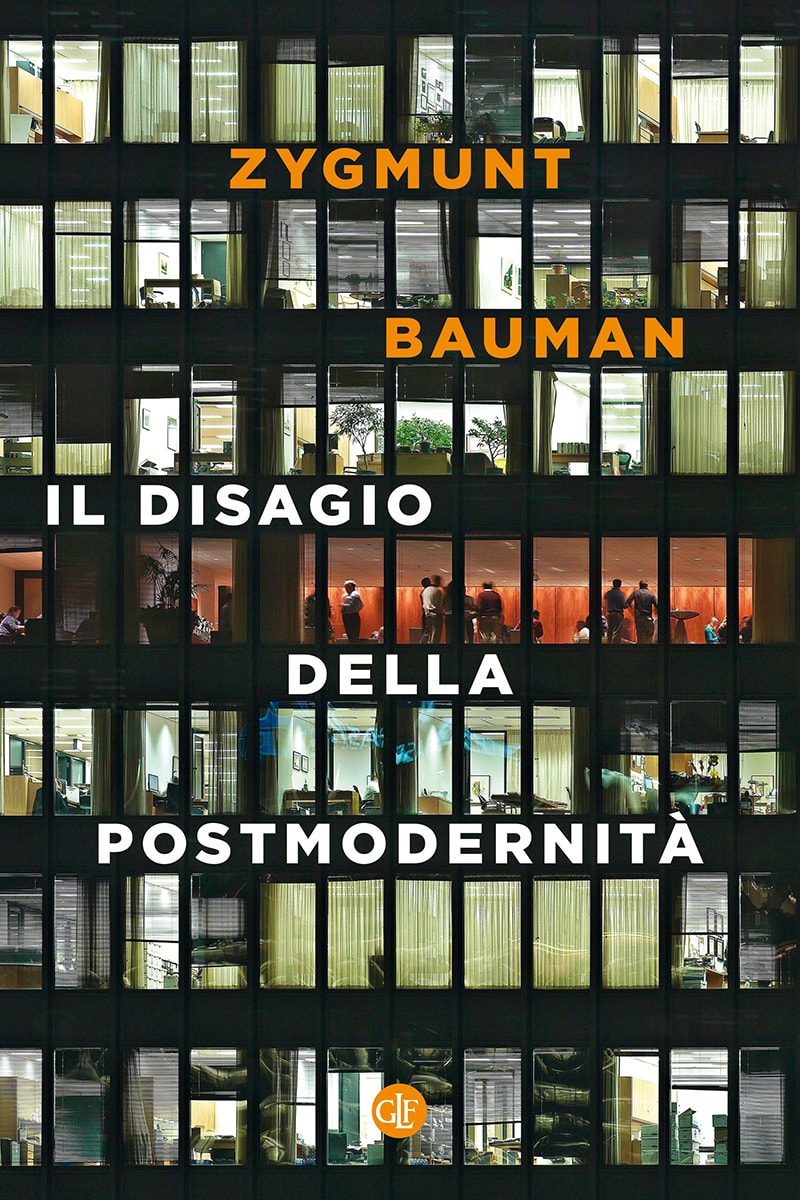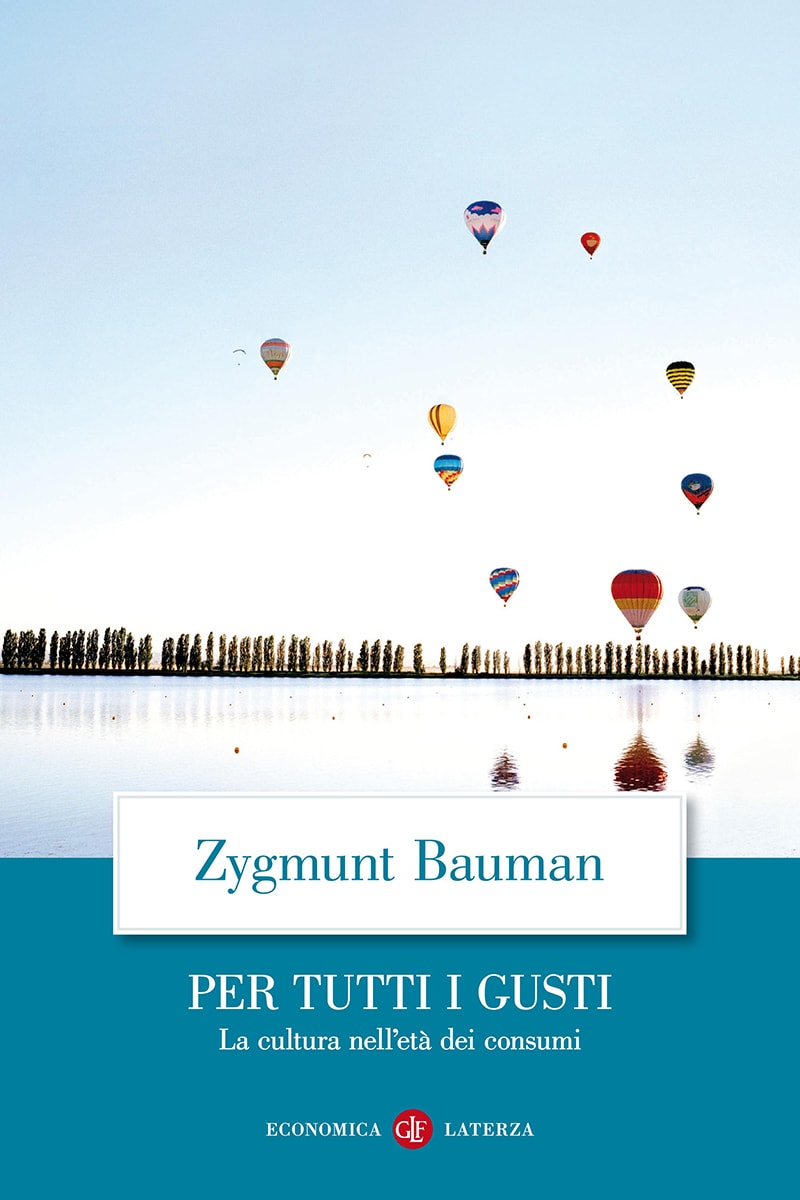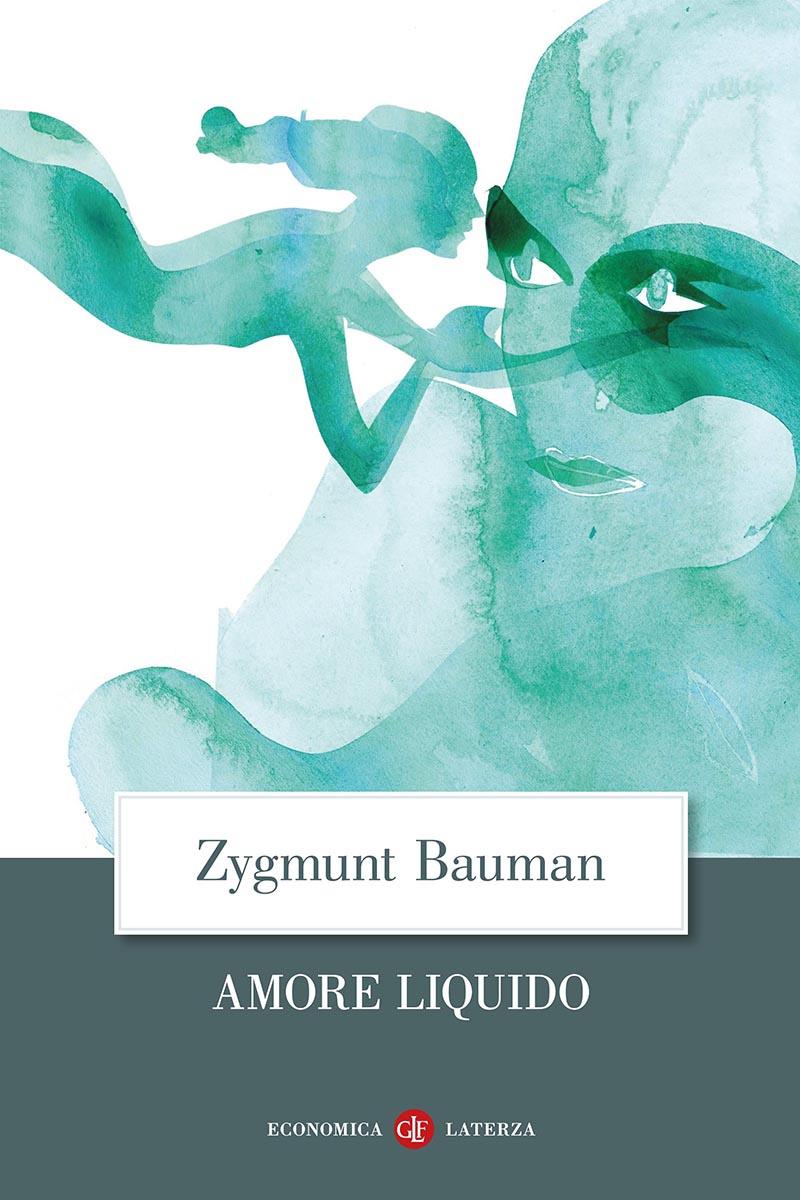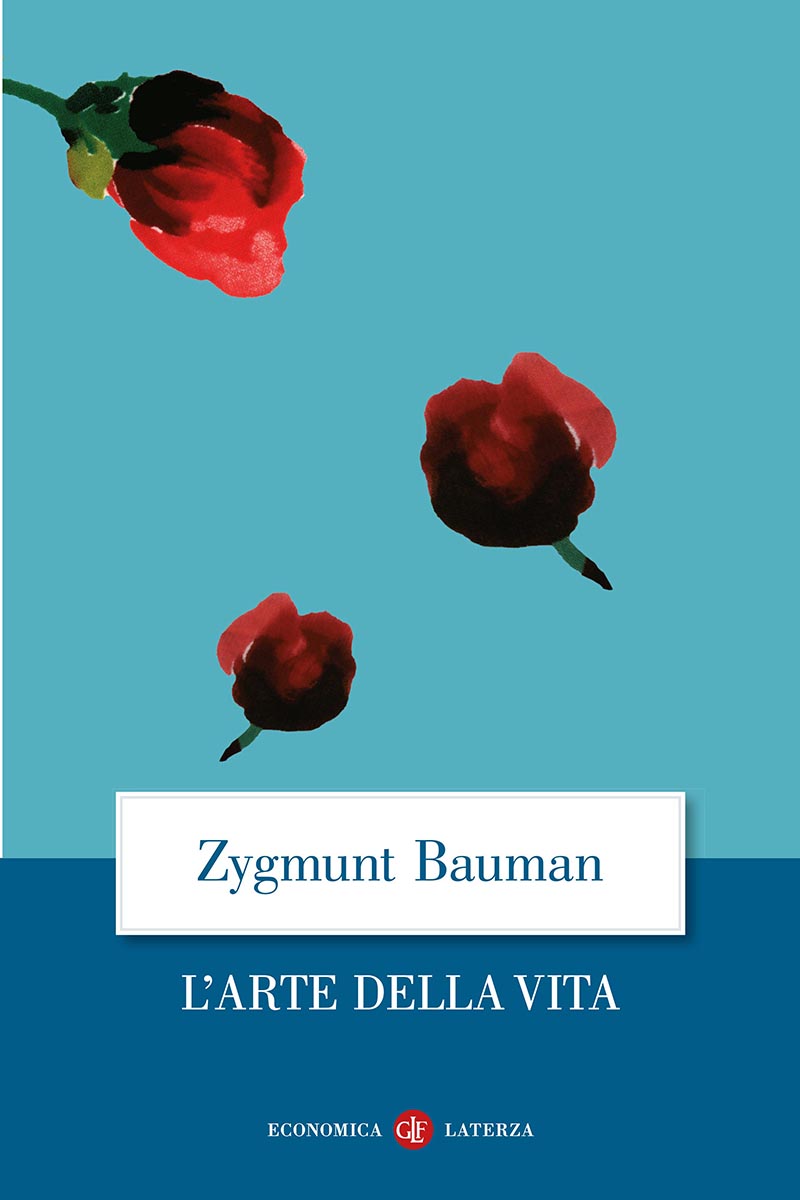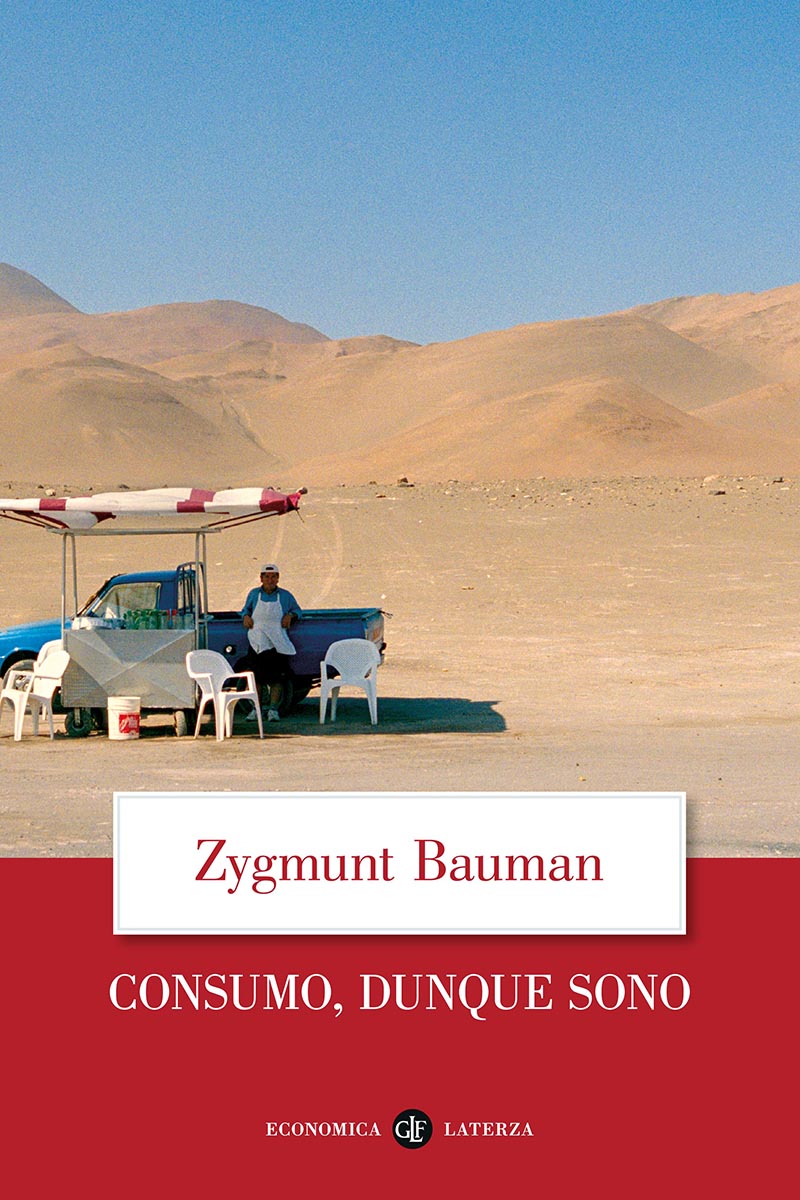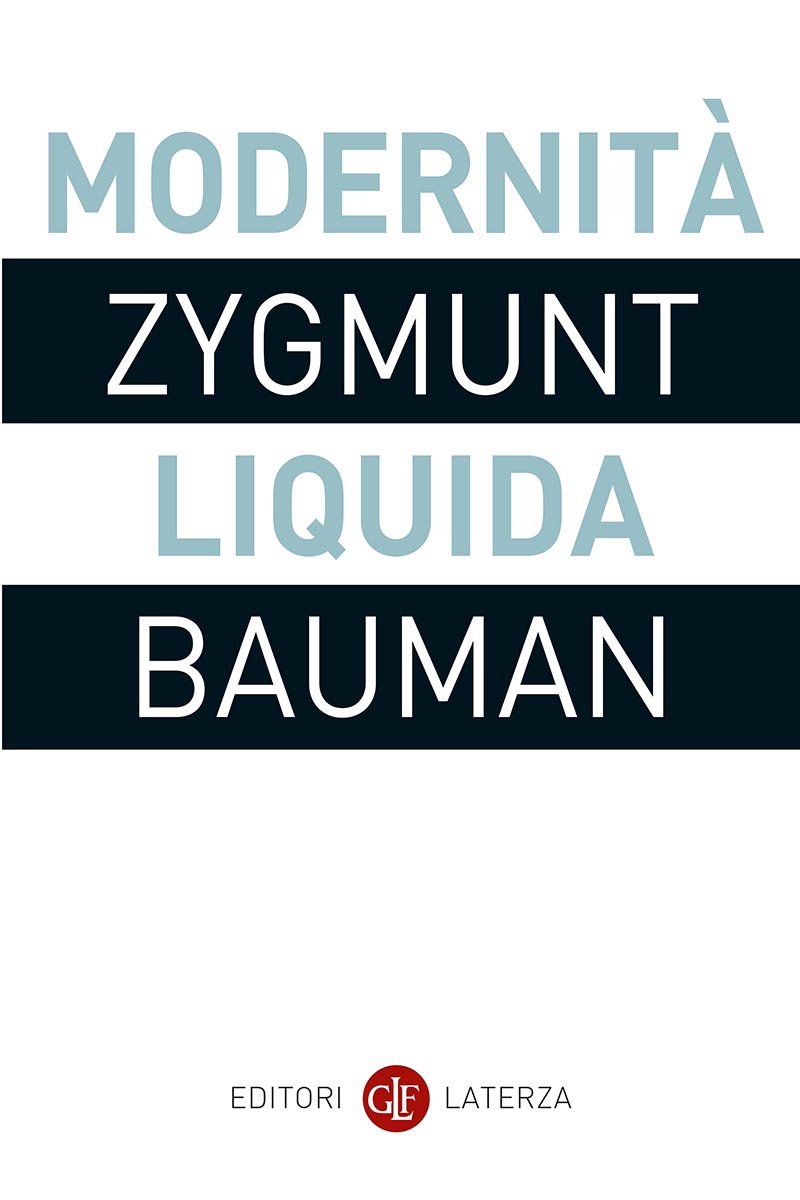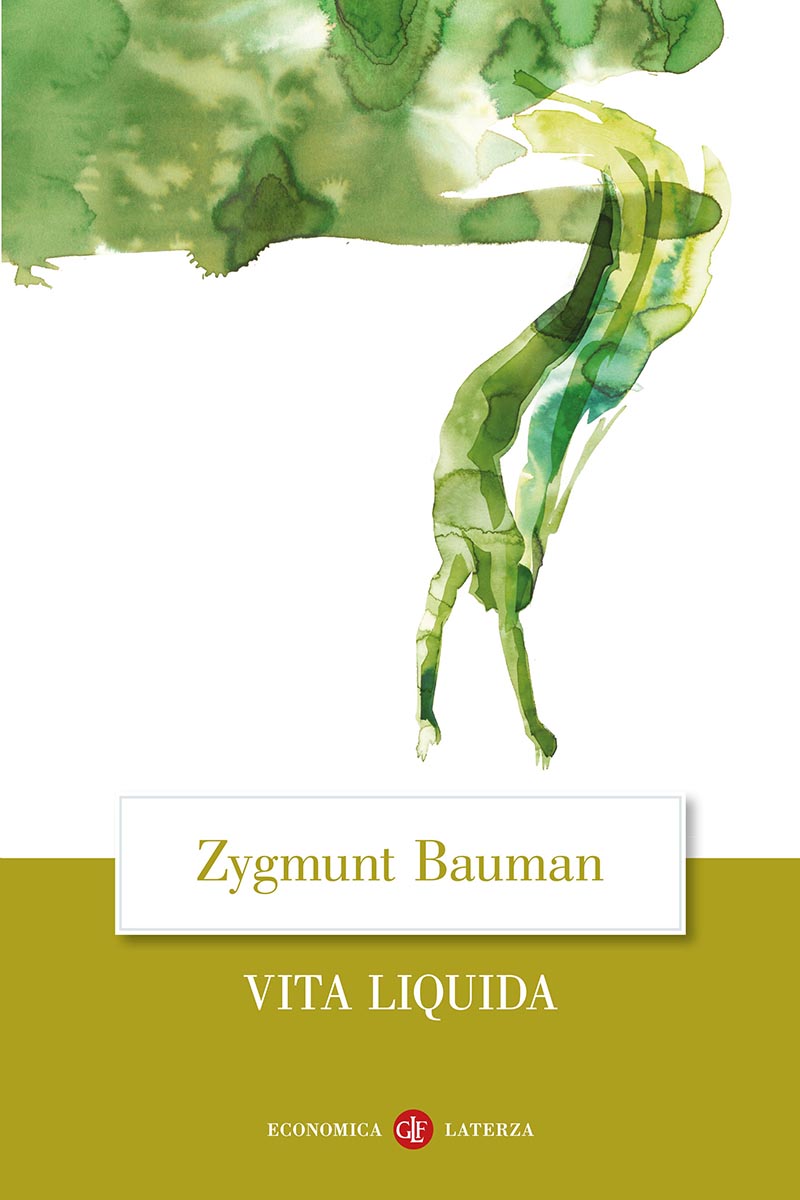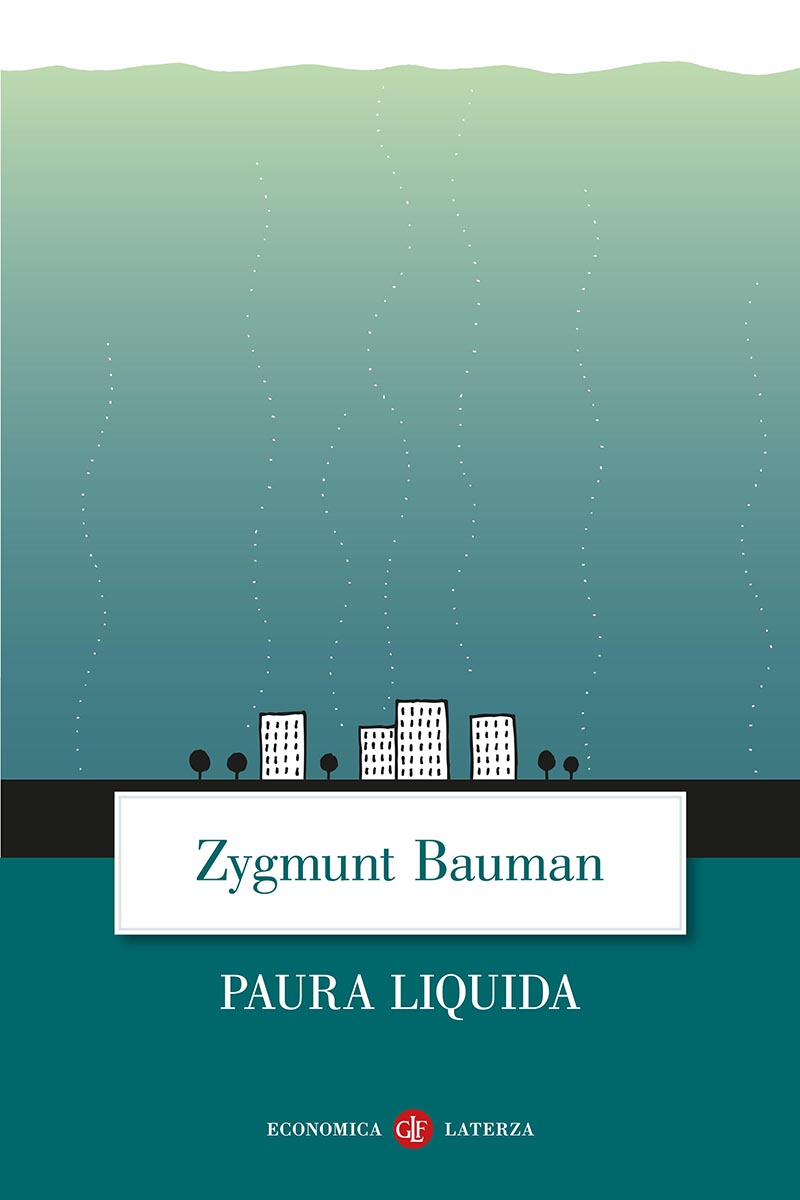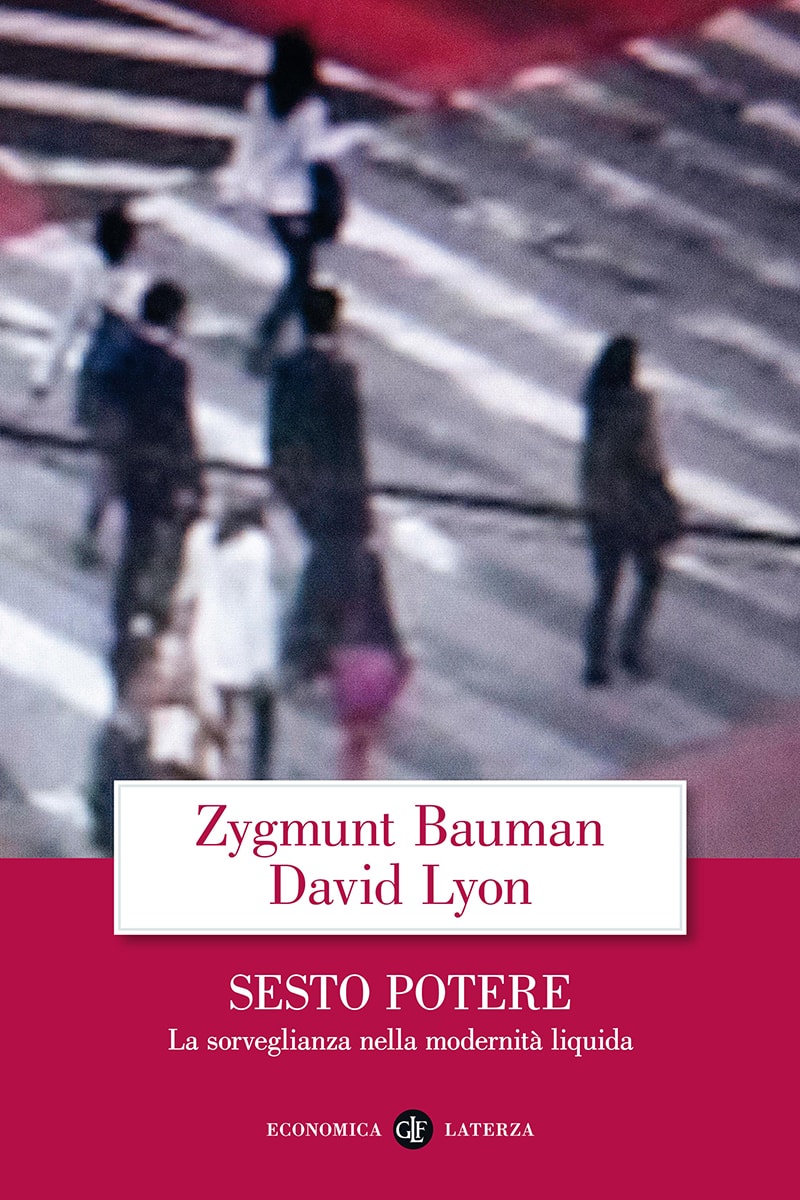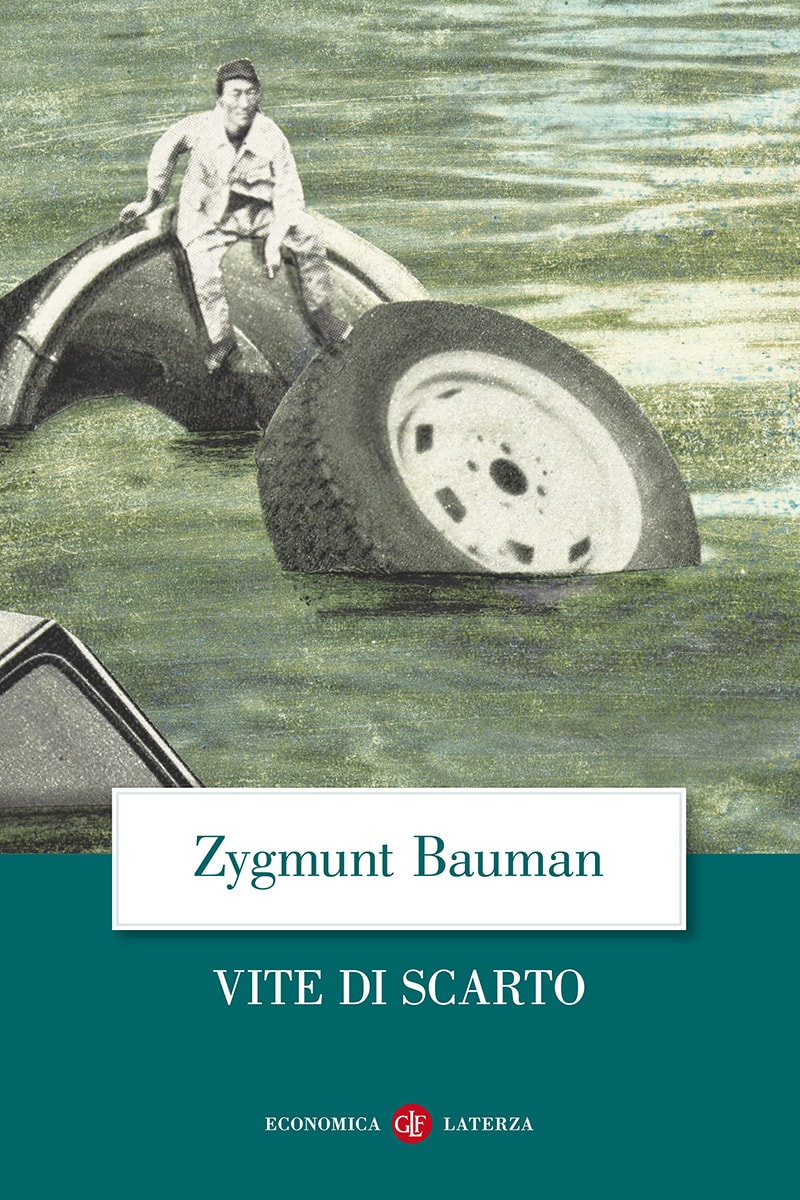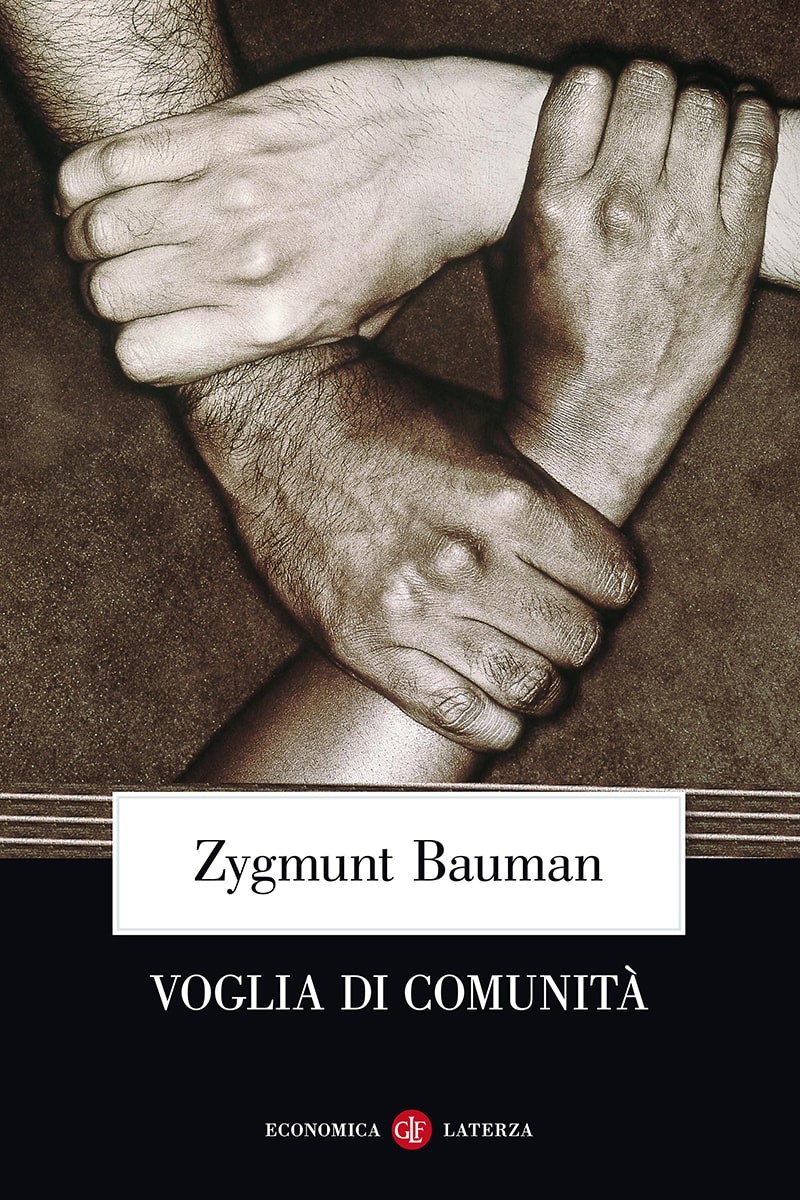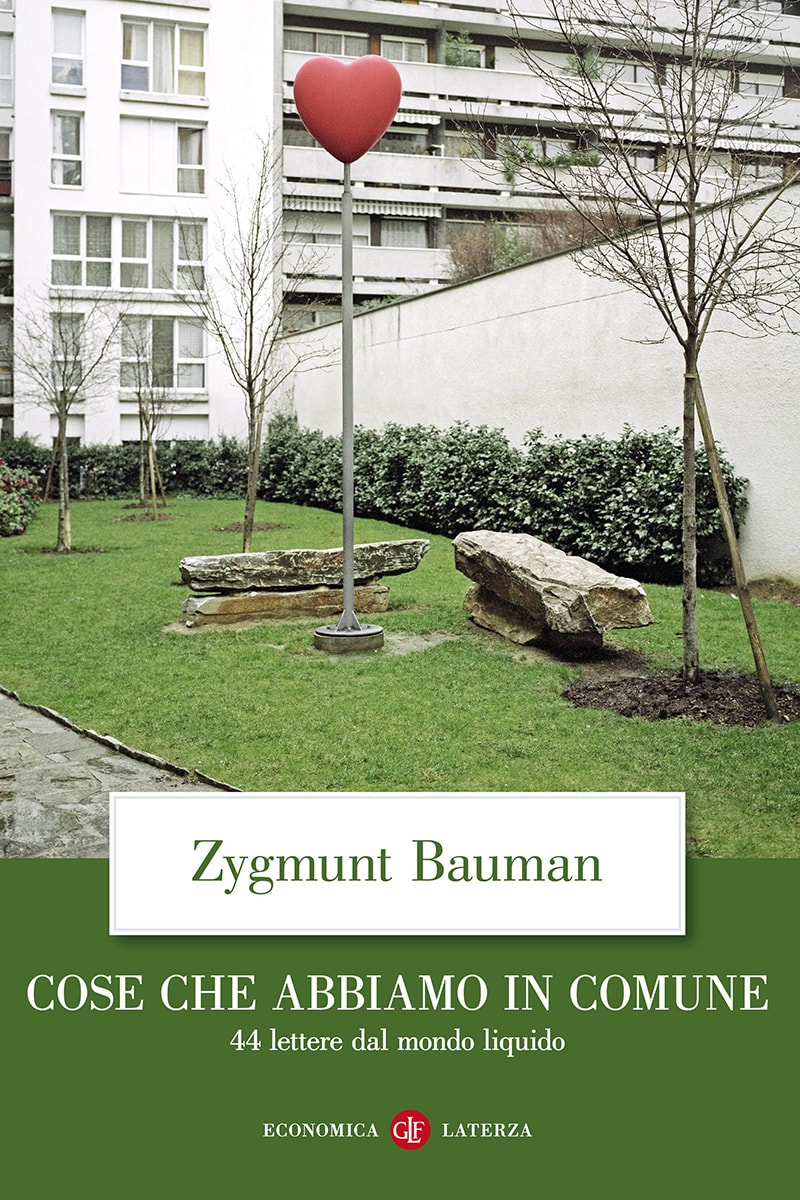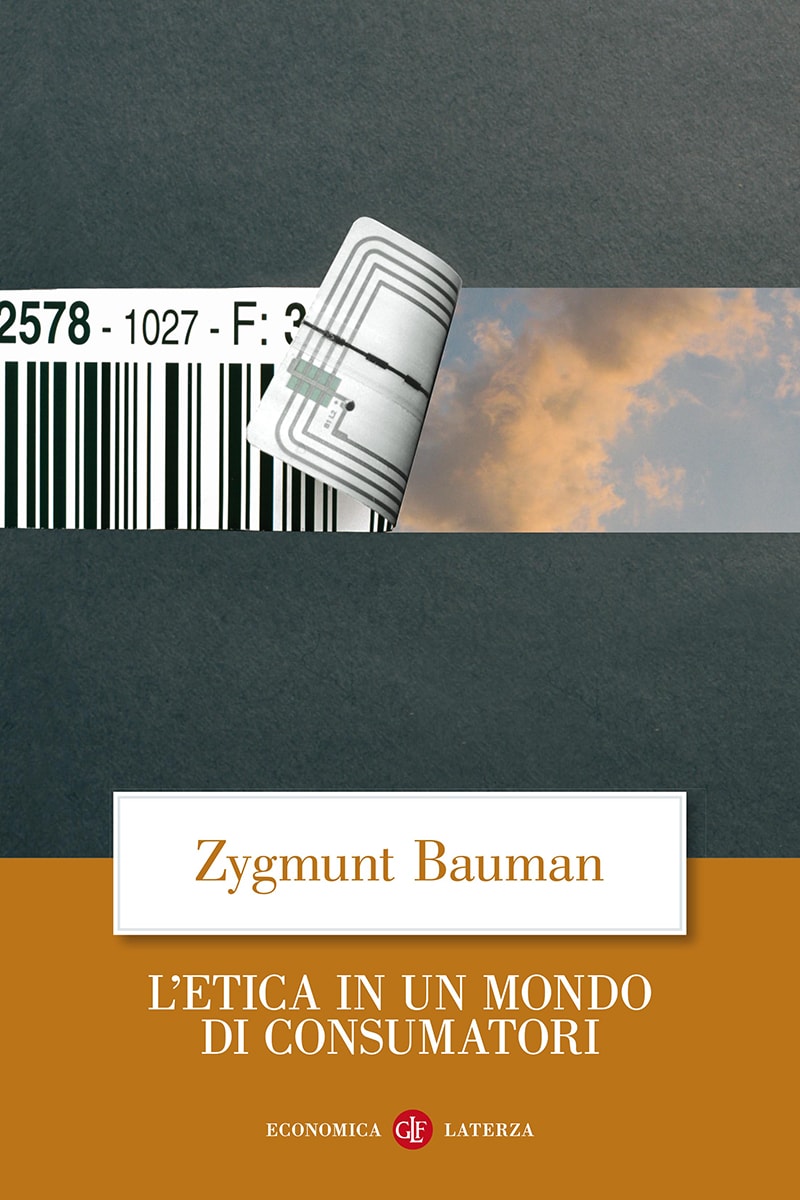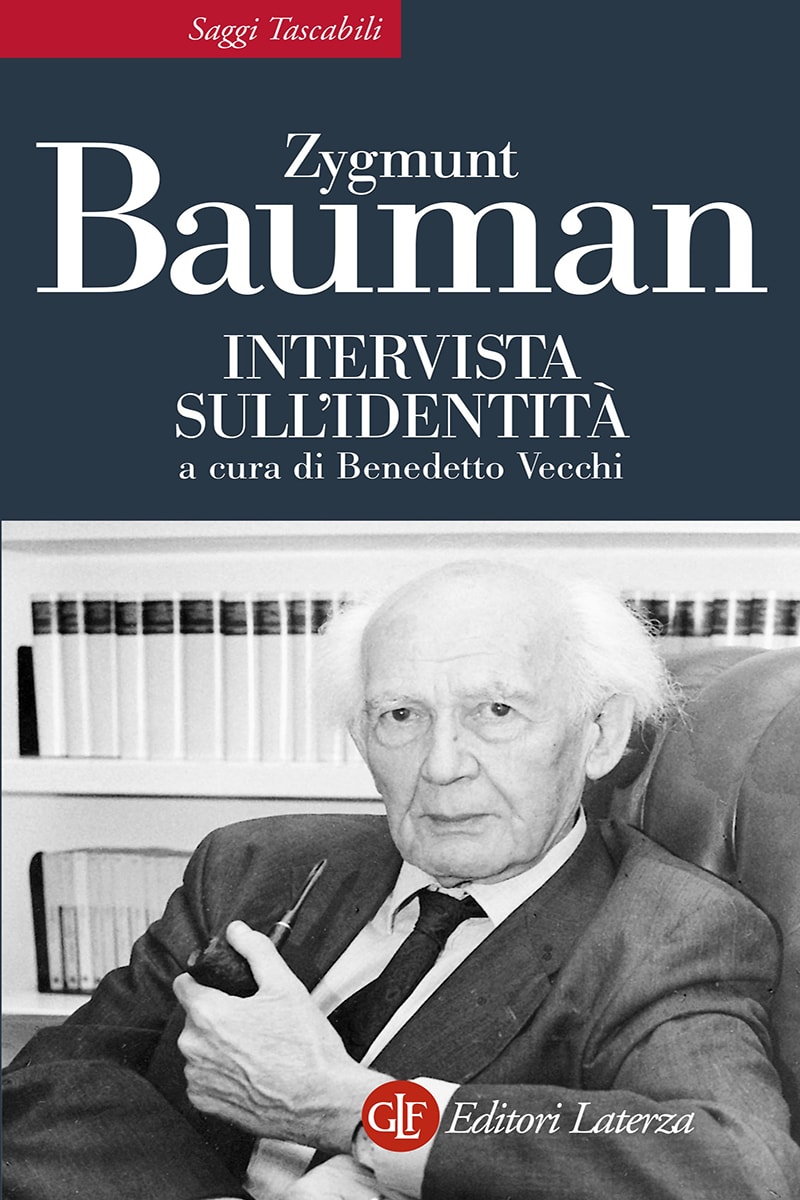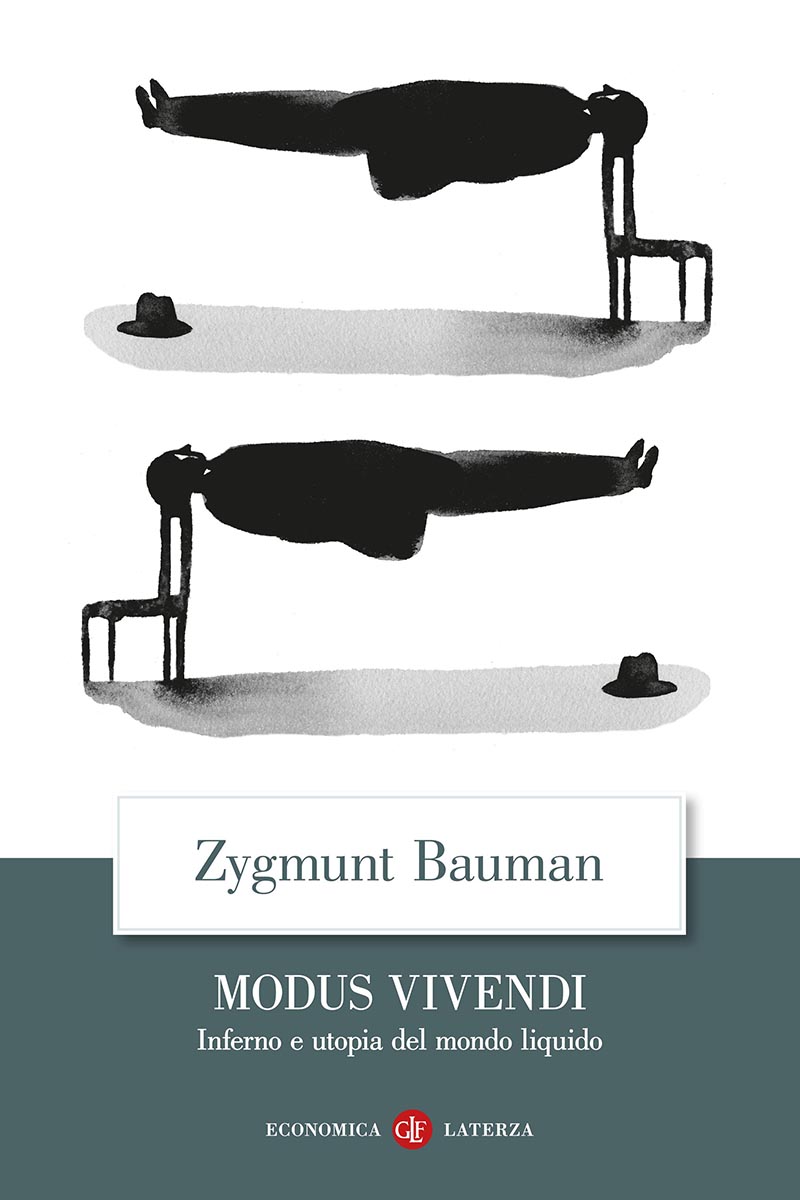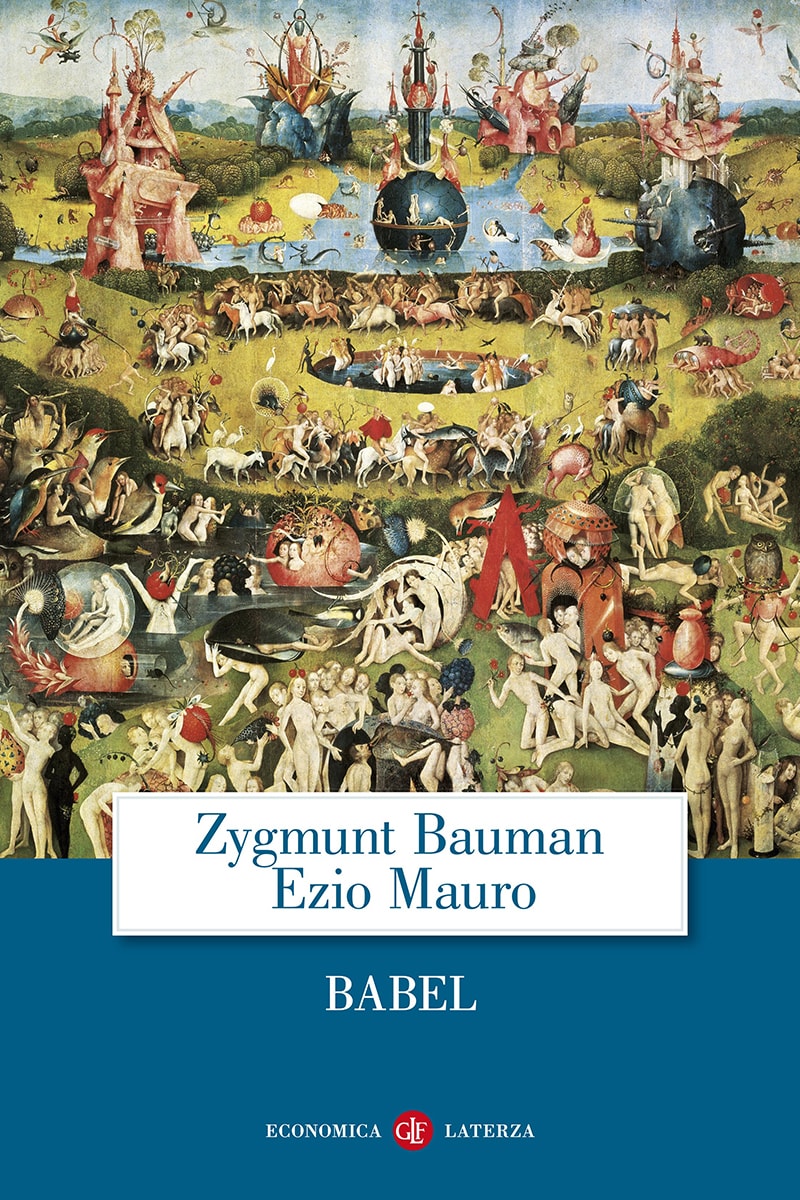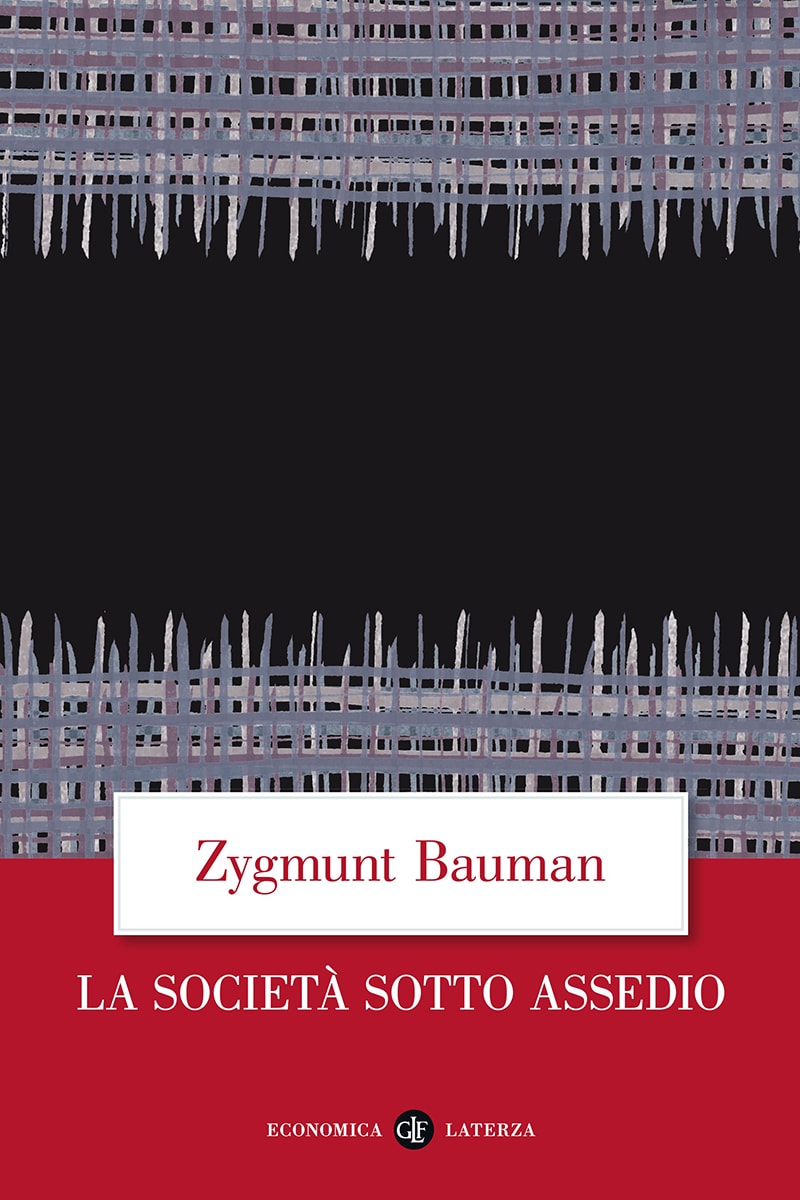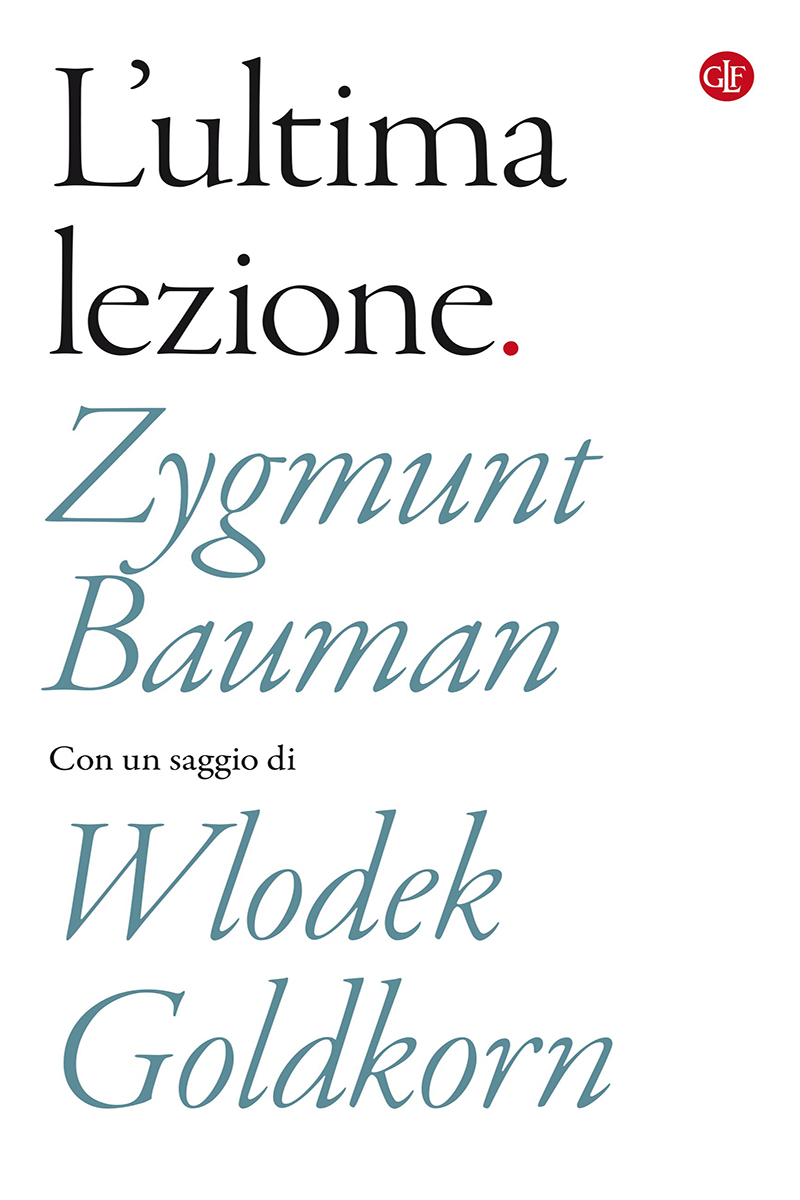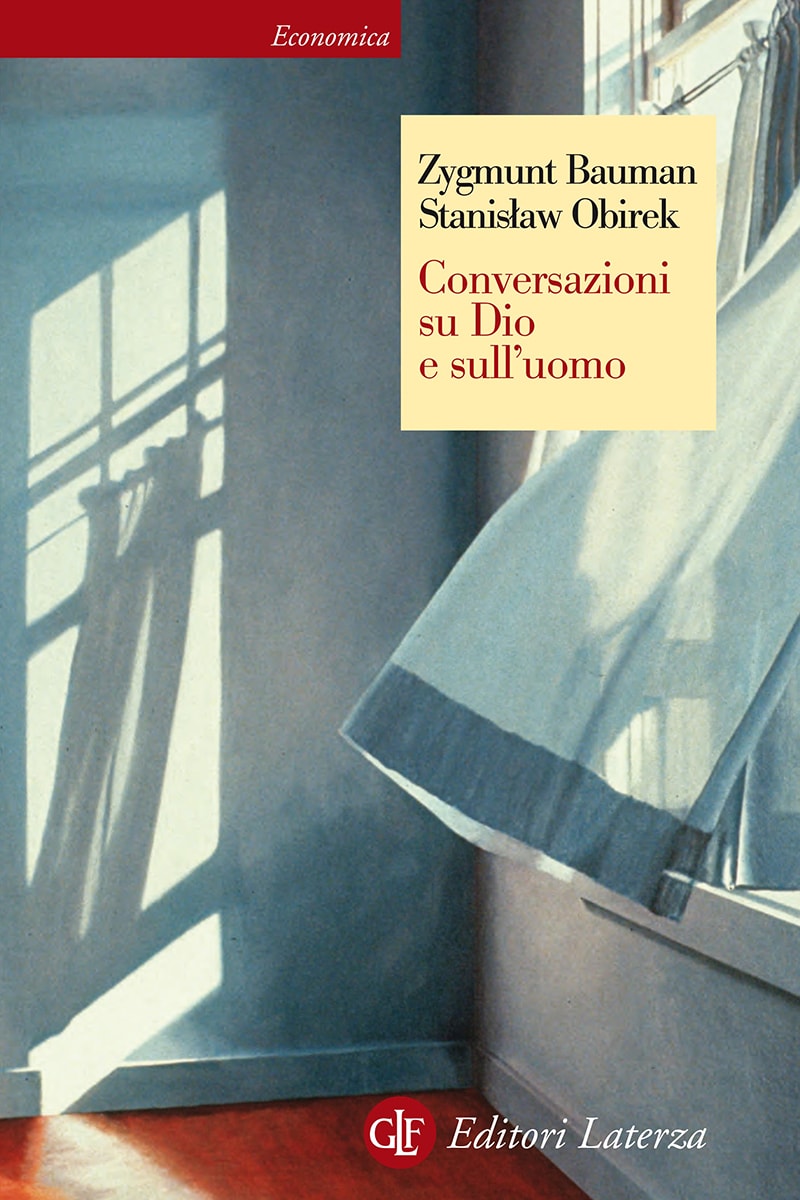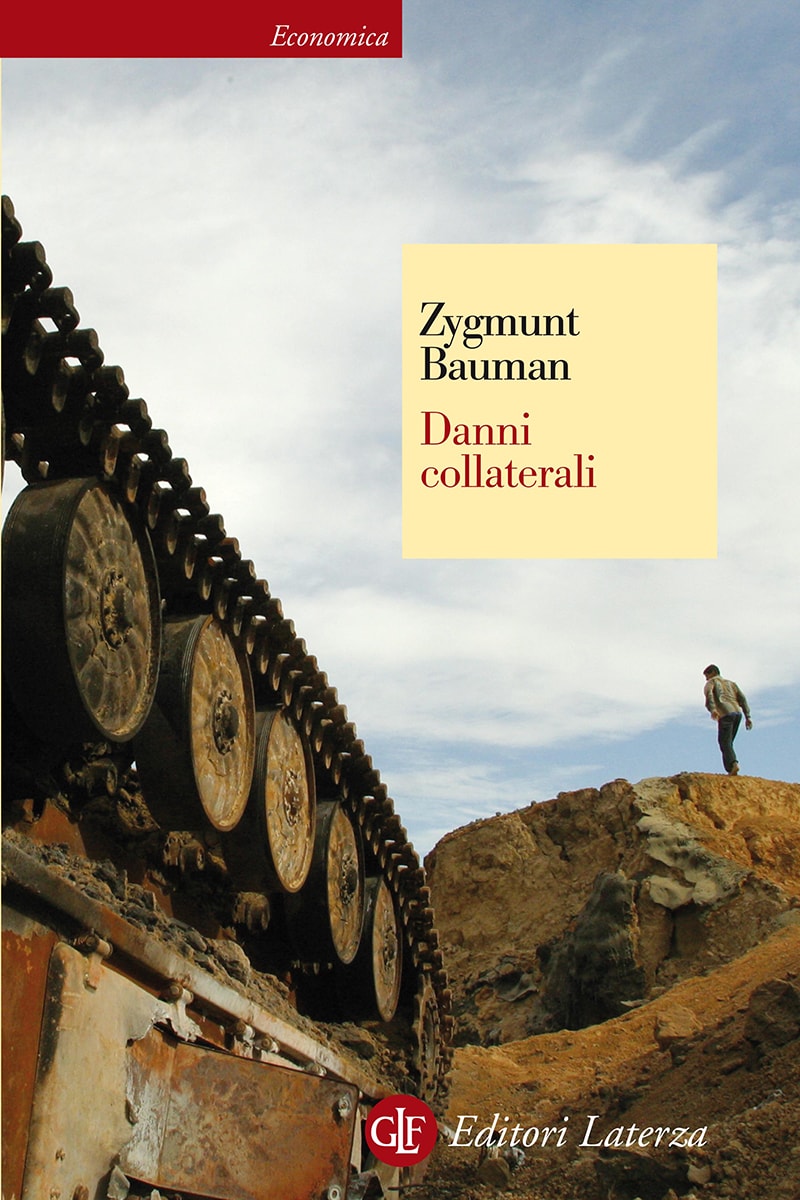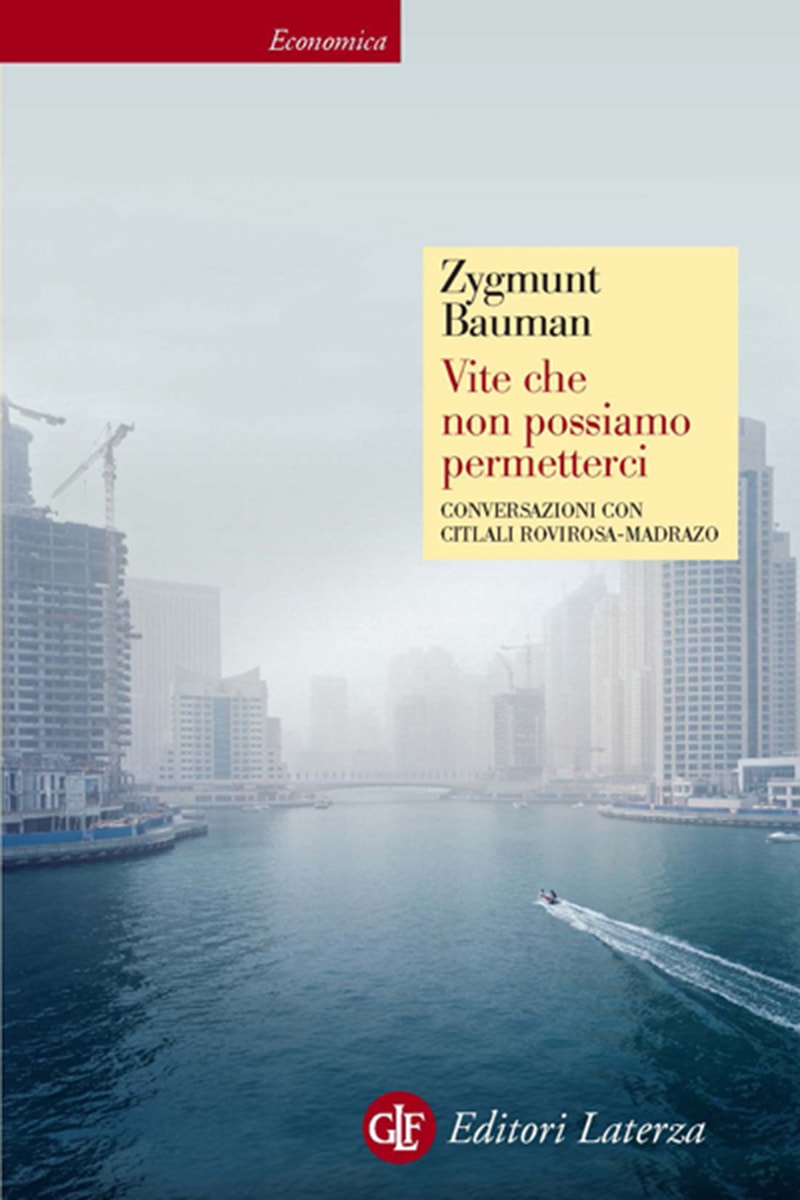Introduzione
La parola «globalizzazione» è sulla bocca di tutti; è un mito, un’idea fascinosa,
una sorta di chiave con la quale si vogliono aprire i misteri del presente e del futuro;
pronunciarla è diventato di gran moda. Per alcuni, «globalizzazione» vuol dire tutto
ciò che siamo costretti a fare per ottenere la felicità; per altri, la globalizzazione
è la causa stessa della nostra infelicità. Per tutti, comunque, la «globalizzazione»
significa l’ineluttabile destino del mondo, un processo irreversibile, e che, inoltre,
ci coinvolge tutti alla stessa misura e allo stesso modo. Viviamo tutti all’interno
della «globalizzazione», ed essere «globalizzati» vuol dire per ciascuno di noi, più
o meno, la stessa cosa.
Tutte le parole in voga hanno un destino comune: quante più esperienze pretendono
di chiarire, tanto più esse stesse diventano oscure. Quanto più numerose sono le verità
ortodosse che esse negano e soppiantano, tanto più rapidamente si trasformano in norme
che non si discutono. Spariscono le varie pratiche umane che il concetto tentava all’inizio
di mettere in luce, e ora il termine sembra «individuare alla perfezione» «i fatti»,
o la qualità «del mondo reale», con l’ulteriore pretesa di immunizzarsi da qualsiasi
critica. Il termine «globalizzazione» non fa eccezione alla regola.
Questo volume prova a dimostrare che il fenomeno della globalizzazione presenta molti
più aspetti di quanto comunemente non si pensi; ne mette in luce le varie radici e
le varie conseguenze di ordine sociale, per tentare così di diradare parte della nebbia
che avvolge un termine che pretende di fare chiarezza sulla condizione umana dei nostri
giorni.
Nella frase «compressione dello spazio e del tempo» racchiudiamo le multiformi trasformazioni
che stanno investendo la condizione dell’uomo d’oggi. Quando saremo andati a guardare
le cause di tale compressione e le conseguenze che esercita nella società, apparirà
evidente che i processi di globalizzazione non presentano quella unicità di effetti
generalmente attribuita loro. Gli usi del tempo e dello spazio sono non solo nettamente
differenziati, ma inducono essi stessi differenze tra le persone. La globalizzazione
divide tanto quanto unisce; divide mentre unisce, e le cause della divisione sono
le stesse che, dall’altro lato, promuovono l’uniformità del globo. In parallelo al
processo emergente di una scala planetaria per l’economia, la finanza, il commercio
e l’informazione, viene messo in moto un altro processo, che impone dei vincoli spaziali,
quello che chiamiamo «localizzazione». La complessa e stretta interconnessione dei
due processi comporta che si vadano differenziando in maniera drastica le condizioni
in cui vivono intere popolazioni e vari segmenti all’interno delle singole popolazioni.
Ciò che appare come conquista di globalizzazione per alcuni, rappresenta una riduzione
alla dimensione locale per altri; dove per alcuni la globalizzazione segnala nuove
libertà, per molti altri discende come un destino non voluto e crudele. La mobilità
assurge al rango più elevato tra i valori che danno prestigio e la stessa libertà
di movimento, da sempre una merce scarsa e distribuita in maniera ineguale, diventa
rapidamente il principale fattore di stratificazione sociale dei nostri tempi, che
possiamo definire tardomoderni o postmoderni.
In movimento siamo un po’ tutti, che lo si voglia o no, perché lo abbiamo deciso o
perché ci viene imposto. Siamo in movimento anche se, fisicamente, stiamo fermi; l’immobilità
non è un’opzione realistica in un mondo in perpetuo mutamento. Eppure gli effetti
indotti dalla nuova condizione creano radicali diseguaglianze. Alcuni di noi divengono
«globali» nel senso pieno e vero del termine; altri sono inchiodati alla propria «località»
– una condizione per nulla piacevole né sopportabile in un mondo nel quale i «globali»
danno il là e fissano le regole del gioco della vita.
Insomma, essere «locali» in un mondo globalizzato è un segno di inferiorità e di degradazione
sociale. Il peso di un’esistenza limitata a un luogo è aggravato oltre misura da una
circostanza: oggi che gli spazi di interesse pubblico sfuggono all’ambito della vita
per così dire «localizzata», gli stessi luoghi stanno perdendo la loro capacità di
generare e di imporre significati all’esistenza; e dipendono in misura crescente dai
significati che vengono loro attribuiti e da interpretazioni che non possono in alcun
modo controllare – quali che siano le opinioni espresse in merito dagli intellettuali
globalizzati, venditori di sogni comunitari che servono solo a consolare.
La crescente segregazione, separazione ed esclusione nello spazio è parte integrante
dei processi di globalizzazione. Le tendenze al neotribalismo e al fondamentalismo,
riflesso delle esperienze delle persone che si trovano sul versante per così dire
passivo della globalizzazione, discendono anch’esse da questa: una derivazione legittima
quanto lo è l’osannata «ibridazione» della cultura dominante, la cultura cioè dei
vertici globalizzati. Genera inoltre gravi preoccupazioni il progressivo sfilacciarsi
delle comunicazioni tra le élites, sempre più globali ed extraterritoriali, e gli altri, sempre più «localizzati».
I centri nei quali vengono prodotti i significati e i valori sono oggi extraterritoriali
e avulsi da vincoli locali – mentre non lo è la stessa condizione umana che a tali
valori e significati deve dar forma e senso.
Una volta che lo imperniamo sulla libertà di movimento, l’attuale processo di polarizzazione
acquista molte dimensioni; il nuovo centro attribuisce sfaccettature diverse alle
antiche distinzioni tra ricchi e poveri, nomadi e stanziali, «normali» e anormali
o criminali. Sicché, un altro tra i complessi problemi che questo volume cerca di
illustrare attiene ai modi in cui i vari aspetti della polarizzazione si intrecciano
e si influenzano reciprocamente.
Il primo capitolo esamina il legame che intercorre tra il mutamento, nella storia,
della natura del tempo e dello spazio e la struttura e le dimensioni delle organizzazioni
sociali, in particolare gli effetti che la compressione attuale dello spazio e del
tempo esercita sulla strutturazione delle società e delle comunità planetarie e territoriali.
Una delle conseguenze esaminate è la nuova veste che sta assumendo il «dominio sul
territorio esercitato in absentia»: e cioè l’indipendenza che le élites globali hanno da poco acquisito da quei poteri politici e culturali che sono vincolati
e limitati al territorio, e la conseguente «perdita di potere» di questi ultimi. L’impatto
che esercita la separazione tra le due sfere nelle quali il «vertice» e la «base»
della nuova gerarchia sono rispettivamente dislocati, viene ricondotto e spiegato
alla luce dei mutamenti nell’organizzazione dello spazio e al significato stesso che
il termine «vicinato» assume nella metropoli contemporanea.
Nel successivo capitolo si prendono in esame gli stadi successivi delle guerre che
nella modernità gli uomini hanno ingaggiato per conquistare il diritto di definire
e far rispettare uno spazio che fosse condiviso. Vengono analizzate in questa luce
le trascorse avventure della pianificazione della città totale, nonché le tendenze
contemporanee a frammentare lo spazio e a costruire edifici destinati a segregare
gli uomini. Viene infine esaminato il destino storico del Panopticon. Questa struttura
veniva un tempo ritenuta la più idonea alle moderne forme di controllo sociale, ma
l’idea stessa, rivelatasi oggi inattuale, è stata gradualmente abbandonata.
Argomento del terzo capitolo è il futuro della sovranità, in particolare delle forme
di costituzione e autogoverno che le comunità nazionali, e più in generale territoriali,
sanno darsi in un quadro di globalizzazione dell’economia, della finanza e dell’informazione.
L’attenzione cade in particolare sulla crescente differenza di scala tra lo spazio
nel quale vengono assunte e istituzionalizzate le decisioni e quello che è l’universo
in cui sono prodotte, distribuite, accumulate e messe in campo le risorse necessarie
ad assumere e realizzare le decisioni stesse; e in particolare si focalizzano gli
effetti inibenti che il processo di globalizzazione esercita sulle capacità stesse
di decidere da parte delle autorità statali – la cui attività di governo rimane, se
guardiamo a gran parte della storia contemporanea, il principale e per ora insostituito
fulcro di un’efficace gestione della società.
Il quarto capitolo affronta le conseguenze che le trasformazioni in corso hanno sulla
cultura. Il loro effetto complessivo, si postula, è una divaricazione e polarizzazione
delle esperienze umane, che, per quanto diverse, condividono comunque alcuni tratti
culturali. «Muoversi» ha significati radicalmente opposti per quanti sono al vertice
e quanti si trovano al fondo della nuova gerarchia, mentre il grosso della popolazione,
la «nuova classe media», oscilla tra i due estremi, e si accolla il carico di tale
contrapposizione soffrendo di conseguenza di acute incertezze, ansietà e paure esistenziali.
Nel capitolo si sostiene come l’esigenza di mitigare tali paure e di neutralizzare
la carica di scontento che esse comportano generi a sua volta un’ulteriore poderosa
divaricazione tra i due significati della mobilità.
L’ultimo capitolo esplora quali sono le espressioni estreme della polarizzazione:
l’attuale tendenza a criminalizzare i casi che si pongono al di sotto delle norme
idealizzate e il ruolo che gioca il processo di criminalizzazione nel controbilanciare
gli aspetti negativi della «vita in movimento»: esso serve a rendere ancora più odiose
e repellenti la rappresentazione e la realtà di una vita alternativa, una vita di
immobilità. Il complesso problema della insicurezza esistenziale che il processo di
globalizzazione comporta, alla fine sembra ridursi a quello, apparentemente semplice,
«della legge e dell’ordine». In questo processo, le preoccupazioni per le condizioni
di «sicurezza», preoccupazioni che si limitano nella maggior parte dei casi alla sicurezza
della propria persona e dei propri beni, vengono «sovraccaricate» delle ansietà generate
da altri, e cruciali, aspetti della vita attuale: l’insicurezza e l’incertezza.
Le tesi di questo libro non rappresentano un manifesto politico. Si tratta, nelle
intenzioni del suo autore, di temi di discussione. Sono più numerosi i quesiti per
i quali si cerca una risposta di quelli che la trovano, né siamo in grado di prevedere
quali potrebbero essere secondo logica le future conseguenze dei fenomeni in atto.
Tuttavia, per dirla con Cornelius Castoriadis, il vero problema dell’attuale stato
della nostra civiltà è che abbiamo smesso di farci delle domande. Astenerci dal porre
certi problemi è molto più grave di non riuscire a rispondere alle questioni già ufficialmente
sul tappeto; mentre porsi domande sbagliate troppo spesso ci impedisce di guardare
ai problemi davvero importanti. Il prezzo del silenzio viene pagato con la dura moneta
delle umane sofferenze. Porsi le questioni giuste è ciò che, dopo tutto, fa la differenza
tra l’affidarsi al fato e perseguire una destinazione, tra la deriva e il viaggio.
Mettere in discussione le premesse apparentemente indiscutibili del nostro modo di
vivere può essere considerato il più urgente dei servizi che dobbiamo svolgere per
noi stessi e per gli altri. Questo volume è perciò, in primo luogo e soprattutto,
un volersi cimentare nel porre domande, e richiedere che vengano rivolte, senza la
pretesa di aver posto le domande giuste, tutte le domande giuste, e, a maggior ragione,
tutte quelle che vanno poste.
1. Tempo e classe
«L’impresa appartiene alle persone che investono in essa, non ai dipendenti, ai fornitori,
e neanche al luogo in cui è situata»1. È Albert J. Dunlap, il famoso «razionalizzatore» dell’impresa moderna – un dépeceur, cioè un «tagliatore di teste», uno che fa a pezzi, che smembra le imprese, per dirla
con la succosa ma precisa definizione coniata dal sociologo del Cnrs, Denis Duclos2 –, a sintetizzare in questa frase le proprie idee. L’abbiamo tratta dalla compiaciuta
relazione sulle sue attività che la casa editrice Time Books ha pubblicato per orientare
e formare quanti mirano al progresso economico.
Dunlap, naturalmente, non pensava alla semplice «appartenenza» nella pura accezione
giuridica che diamo alla parola «proprietà» – una questione che ormai non si pone
più e non ha certo bisogno di nuove spiegazioni, tanto più se così enfatiche –. Dunlap
pensava, soprattutto, a quello che il resto della frase significa, e cioè che i dipendenti,
i fornitori e gli esponenti di una località non hanno voce alcuna nelle decisioni
che gli investitori possono prendere; che a questi spetta il vero potere di decidere,
così come il diritto di respingere, di non tenere in alcun conto e non accettare qualsiasi
commento o richiesta gli altri possano avanzare sul modo in cui essi gestiscono l’impresa.
Con questo messaggio – è bene notarlo – Dunlap non fa una dichiarazione d’intenti,
ma constata dei fatti. Egli enuncia un principio che, a suo parere, ha superato tutte
le prove cui possono averlo sottoposto le diverse realtà dei nostri giorni, economiche,
politiche, sociali e altre ancora. Quel principio sarebbe ormai entrato a far parte
delle verità di per sé evidenti: servono a spiegare il mondo, ma non hanno alcun bisogno
di essere spiegate; consentono di formulare pensieri basilari sul mondo, ma non vengono
più considerate proposizioni, enunciati che, in quanto tali, debbano essere discussi
o confutati.
Ci sono stati tempi («non lontani», aggiungeremmo, se non fosse che la gente è sempre
meno attenta, e anche una settimana appare un periodo lungo non solo nella politica,
ma persino nella memoria dell’uomo) in cui i proclami di Dunlap non sarebbero apparsi
scontati ai più; tempi in cui sarebbero risuonati piuttosto come grida di battaglia
o cronache di guerra. Nei primi anni della guerra di annientamento che Margaret Thatcher
sferrò contro le autonomie locali, gli uomini d’affari, l’uno dopo l’altro, sentirono
il bisogno di salire sul podio del congresso annuale del Partito conservatore per
lanciare più volte un messaggio che essi rimarcavano perché suonava inusitato e bizzarro
per orecchie che non si fossero ancora assuefatte ad esso: le imprese, dicevano, avrebbero
pagato volentieri le imposte locali per contribuire alla costruzione di strade, o
alla manutenzione di discariche, di cui avevano bisogno, ma non pensavano proprio
di dover contribuire al sussidio dei disoccupati locali, o al sostegno degli invalidi
e di altri rifiuti umani, del cui destino non ritenevano di doversi assumere né responsabilità
né oneri. Erano quelli gli esordi di una guerra che, solo un paio di dozzine di anni
dopo, è stata vinta, o quasi, sicché Dunlap può oggi dettare il suo credo, e aspettarsi
– a giusta ragione – che tutti gli ascoltatori lo condividano.
Non è molto importante chiederci: questa guerra è stata programmata, in forme malevoli
e pretestuose, nelle asettiche sale dei consigli d’amministrazione di imprese in cui
è vietato fumare? oppure l’hanno imposta, a industriali riluttanti e amanti della
pace, i mutamenti determinati dalla miscela di forze misteriose della nuova tecnologia
e della nuova competitività globale? Ancora, non è importante discutere: questa guerra
è stata pianificata in anticipo, debitamente dichiarata e ha obiettivi chiari e definiti?
oppure è consistita in una serie di semplici episodi sporadici e imprevedibili, ciascuno
imposto da motivazioni proprie? Quale che sia, delle due, l’ipotesi più attendibile,
possiamo darle entrambe per buone, e pensare anche che siano due fenomeni solo in
apparenza diversi. Ma quel che più importa, comunque, è che l’ultimo quarto del nostro
secolo passerà alla storia come la Grande guerra di indipendenza dallo spazio. Una
guerra durante la quale i centri decisionali, insieme alle motivazioni stesse che
determinano le decisioni, gli uni e le altre ormai liberi da legami territoriali,
hanno preso a distaccarsi, in forma continua e inesorabile, dai vincoli imposti dai
processi di localizzazione.
Esaminiamo con più attenzione il principio di Dunlap. I dipendenti sono reclutati
tra la popolazione locale e, per i probabili legami imposti dalla famiglia, dalla
proprietà di un’abitazione e da fattori simili, non possono facilmente seguire l’impresa
quando questa decida di trasferirsi. I fornitori devono fornire merci, e tra essi
quelli locali sono avvantaggiati dai bassi costi di trasporto, un vantaggio che però
svanisce se l’impresa si trasferisce. Quanto alla «località» stessa, è persino ovvio
che rimarrà dov’è e non si può certo spostare, quale che sia il nuovo indirizzo dell’impresa.
Tra tutti quelli che hanno qualcosa da dire sulla gestione della impresa, solo gli
«investitori» – gli azionisti – non sono allora in alcun modo legati allo spazio;
possono comprare qualsiasi azione, in qualsiasi Borsa e per il tramite di qualsiasi
agente e, nella decisione di comprare o vendere, la vicinanza o lontananza geografiche
saranno, con ogni probabilità, la considerazione meno importante.
In teoria, nei processi di dispersione dell’azionariato non c’è nulla che possa essere
definito e delimitato nello spazio. Gli investitori rappresentano il solo fattore
veramente libero dai vincoli relativi allo spazio. Ad essi, e solo ad essi, «appartiene»
l’impresa. Sta a loro quindi dislocarla nei luoghi in cui possono vedere o anticipare
la possibilità di dividendi più elevati, lasciando agli altri – a quelli che restano
legati al territorio – il compito di leccarsi le ferite, di minimizzare i danni e
fare pulizia. L’impresa è libera di muoversi; ma le conseguenze del suo trasferimento
sono destinate a permanere nel tempo. Chi può abbandonare i luoghi è anche libero
di non preoccuparsi delle conseguenze. Sono queste le spoglie più importanti della
vittoria conseguita nella guerra per lo spazio.
I proprietari assenti: la versione dei nostri giorni
All’indomani di questa guerra, la mobilità è diventata il più poderoso e apprezzato
fattore di stratificazione sociale; il materiale con il quale ogni giorno si costruiscono
e si ricostruiscono, sempre di più su scala mondiale, le nuove gerarchie sociali,
politiche, economiche e culturali. Per chi si trova al vertice del nuovo ordine, i
vantaggi derivanti dalla libertà di movimento vanno ben oltre le formulazioni di Dunlap.
Il quale prende in considerazione, promuove o degrada solo quelli che, nella competizione,
sono capaci di farsi sentire, di dar voce alle proprie lamentele e avanzare pretese
– e che probabilmente, quindi, così faranno –. Ma di quelli che, anch’essi legati
al territorio, vengono isolati e «seminati», senza collegamenti, Dunlap tace addirittura,
perché è improbabile che possano farsi sentire.
La mobilità acquisita dagli investitori – coloro che cioè dispongono di capitali,
del denaro per investire – è emblematica della nuova divaricazione tra potere e obblighi
sociali, una cesura senza precedenti nella storia perché i potenti si sottraggono
radicalmente a ogni vincolo: sono svaniti i doveri nei confronti non solo dei dipendenti,
ma dei giovani e dei più deboli, delle generazioni che verranno e delle condizioni
stesse che assicurano la vita di tutti noi; per dirla in breve, tutto ciò significa
libertà dal dovere di contribuire alla vita quotidiana e al perpetuarsi della comunità
civile. Sta così emergendo una nuova asimmetria tra la natura extraterritoriale del
potere e la permanenza dei vincoli territoriali in quella che è «la totalità della
vita», una asimmetria che il nuovo potere, libero com’è da legami e in grado di muoversi
in tempi brevissimi e senza preavviso, può sfruttare senza preoccuparsi delle conseguenze.
Liberarsi proprio di quest’ultima responsabilità è il vantaggio più evidente e apprezzato
che il nuovo fattore della mobilità attribuisce al capitale fluttuante, non legato
a un luogo. I costi derivanti dalla necessità di fronteggiare le conseguenze, quindi,
non vanno più presi in considerazione nel valutare quanto sia efficace l’investimento.
La nuova libertà del capitale ricorda quella del proprietario terriero di un tempo,
che era odiato – si sa – per il suo disprezzo dei bisogni delle popolazioni che lo
nutrivano. «Scremare» le eccedenze di prodotto era l’unico interesse che i proprietari
assenteisti nutrivano per le terre in loro possesso. Nelle due situazioni storiche
possiamo rilevare delle analogie, ma il raffronto non mette nel giusto rilievo le
diversità: quella libertà dalle preoccupazioni e dalle responsabilità che il capitale
mobile del XX secolo ha acquisito ma che i proprietari assenteisti non ebbero mai.
Una proprietà agricola non poteva essere oggetto di scambio, perciò i proprietari
restavano legati – anche se con fili sottili – alla località dalla quale traevano
la propria linfa vitale; le circostanze stesse imponevano loro un limite pratico alle
possibilità di sfruttare le terre, che in teoria e per via giuridica erano illimitate,
perché non volevano rischiare di affievolire nel futuro i flussi di reddito, o inaridirli
del tutto. È vero, anche, che i limiti reali tendevano a essere, nel complesso, più
rigidi di quanto essi stessi riuscivano a percepire, e che le loro stesse percezioni,
a loro volta, erano assai spesso più severe di quanto suggeriva la pratica: accadeva
così che i proprietari terrieri assenteisti finivano col compromettere in modo irreparabile
la fertilità del suolo e la produzione agricola in generale, rendendo estremamente
precarie anche le loro fortune, che declinavano di generazione in generazione. E tuttavia
quei limiti, che pure erano effettivi, si riproponevano con tanta maggiore crudezza
quanto più non li si percepiva e non li si affrontava in modo corretto. Limite, secondo
Alberto Melucci, «vuol dire confine, frontiera, separazione; e perciò vuol dire anche
riconoscimento dell’altro, del diverso, dell’irriducibile. L’incontro con ‘l’alterità’
è un’esperienza che ci mette alla prova: da essa nasce la tentazione di eliminare
le differenze usando la forza, mentre da essa può anche generarsi la sfida della comunicazione,
come sforzo che si rinnova costantemente»3.
Diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei
tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità
delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente
reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.
Potrebbero farsi sentire e rispettare solo quei limiti che vengono imposti, per via
amministrativa, alla libertà di movimento dei capitali e del denaro. Tali limiti,
però, sono pochi e rari, e ci sono enormi pressioni per attenuare sempre più o, addirittura,
spazzare via quelli residui. Dopo di che, ci sarebbero poche occasioni per quegli
«incontri con l’alterità», con ciò che «è altro», di cui parla Melucci. E se anche
fosse l’altra parte a imporli, se pure fosse «l’alterità» a mostrare i muscoli e a
far sentire la propria forza, il capitale avrebbe poche difficoltà a fare i bagagli
e a cercare un ambiente più ospitale, o che non opponga resistenze, che sia malleabile,
soffice. E ci sarebbero, quindi, meno occasioni per scatenare ulteriori tentativi
di «eliminare le differenze con la forza» o per indurre ad accettare la «sfida della
comunicazione».
Entrambi questi atteggiamenti vorrebbero riconoscere che la diversità è qualcosa di
irriducibile ma, perché sia considerata tale, l’alterità deve prima trasformarsi in
una sostanza che abbia alcune qualità: sia cioè resistente, inflessibile, letteralmente
«avvincente». Una possibilità, questa, che si va rapidamente restringendo. Per poter
acquisire una capacità naturale e genuina di farsi entità capace di resistenza c’è
bisogno che l’aggressore sia persistente ed efficace. Invece, accade che, per gli
effetti complessivi della nuova mobilità, al capitale e alla finanza non si pone quasi
mai l’esigenza di piegare l’inflessibile, di superare gli ostacoli e di vincerne o
attenuarne la resistenza; ovvero, anche quando questa si manifesta, la si può tranquillamente
spazzar via in favore di opzioni più morbide. Insomma, il capitale può sempre imboccare
la strada di trasferirsi in siti più tranquilli se lo scontro con l’«alterità» richiede
un costoso impiego di risorse o negoziati defatiganti. Perché scontrarsi, se basta
disimpegnarsi?
Libertà di movimento e «costituzione» delle società civili
Se rivolgiamo lo sguardo al passato, possiamo chiederci fino a che punto i fattori
geofisici, i confini naturali e artificiali delle unità territoriali, le diverse identità
dei vari popoli e le Kulturkreise, come anche le distinzioni tra «dentro» e «fuori» – tutti gli specifici oggetti della
scienza della geografia – non fossero essenzialmente che delle semplici costruzioni
mentali, o dei sedimenti/artifizi materiali discendenti dai «limiti di velocità»,
o, più in generale, dai vincoli di tempo e di costo cui la libertà di movimento era
soggetta.
Paul Virilio ha di recente suggerito che si può con sempre maggiore sicurezza parlare
della «fine della geografia», laddove appare decisamente prematura la tesi di Francis
Fukuyama sulla «fine della storia»4. Le distanze non hanno più importanza, mentre l’idea di confine geografico è sempre
più difficile da sostenere nel «mondo reale». Tutt’a un tratto appare chiaro che i
continenti ed il mondo, visto nella sua globalità, erano divisi in funzione di distanze
un tempo estremamente reali, in virtù e della natura primitiva dei trasporti e della
difficoltà di viaggiare.
In effetti, lungi dall’essere un «dato» obiettivo, impersonale, fisico, la «distanza»
è un prodotto della società; la lunghezza stessa di una distanza varia a seconda della
velocità con cui la si può superare (e, in un’economia monetaria, dei costi connessi
a ottenere quella data velocità). Tutti gli altri fattori che la società inventa nel
costituire, separare e conservare identità collettive – come i confini tra stati o
le barriere culturali – appaiono, a posteriori, semplici effetti secondari di quella
velocità.
Sembra questa la ragione – è il caso di notarlo – per cui un tempo la «realtà dei
confini» era, nella maggior parte dei casi, un fenomeno che riguardava la stratificazione
delle classi: in passato, come oggi, le élites dei ricchi e dei potenti erano, dal punto di vista politico, sempre più aperte su
scala planetaria che non il resto della popolazione delle terre dove abitavano, e
tendevano a crearsi una cultura propria, poco attenta ai confini, che rimanevano invece
un fattore di rigidità per la gente da meno; e avevano molte più cose in comune con
le élites d’oltre confine che non con il resto della popolazione interna. Sembra questa anche
la ragione per cui Bill Clinton, il rappresentante della élite più potente del mondo attuale, ha potuto dichiarare di recente che, per la prima
volta, non c’è differenza alcuna tra politica interna e politica estera. In effetti,
nella vita dell’élite la differenza tra «qui» e «là», «dentro» e «fuori», «vicino» e «lontano» implica
ormai assai poco. Con l’implosione del tempo necessario a comunicare, un tempo che
si va restringendo alla «misura zero» dell’istante, lo spazio e i fattori spaziali
non contano più, almeno per coloro che possono agire con la velocità dei messaggi
elettronici.
Le opposizioni concettuali «dentro/fuori», «qui/là», «vicino/lontano» hanno scandito
la gradualità e la misura con cui i vari frammenti del mondo che ci circonda, umani
e non umani, sono stati addomesticati, hanno visto scomparire le differenze, sono
divenuti familiari.
Vicino, a tiro, è in primo luogo quanto è usuale, familiare e noto, quasi ovvio; qualcuno
o qualcosa che si vede, con cui ci si incontra, si tratta, s’interagisce nel quotidiano,
qualcosa o qualcuno cui ci legano la routine e le attività di ogni giorno. «Vicino»
è lo spazio all’interno del quale ci si può sentire a casa propria, uno spazio nel
quale di rado, se non quasi mai, ci si trova sperduti, a corto di parole o incerti
sul da farsi. «Molto lontano», invece, è lo spazio nel quale si entra assai di rado,
se non mai, nel quale accadono cose imprevedibili o incomprensibili, alle quali non
si sa come reagire; uno spazio che racchiude cose sconosciute, dalle quali non sappiamo
cosa aspettarci e per le quali non sentiamo il dovere di preoccuparci. Trovarsi in
uno spazio «molto lontano» è un’esperienza difficile; avventurarsi in esso vuol dire
travalicare il proprio habitat, il proprio elemento, stare fuori posto, dove si temono
difficoltà, problemi, danni.
Dati tutti questi elementi, l’opposizione «vicino/lontano» è caratterizzata da un’ulteriore
dimensione, cruciale: quella tra certezza e incertezza, consapevolezza e titubanza.
Essere «molto lontano» vuol dire trovarsi nei guai, e quindi richiede capacità, intelligenza,
astuzia o coraggio, significa dover apprendere regole che ci sono estranee e delle
quali altrove si potrebbe fare a meno, e che si fanno proprie solo affrontando prove
pericolose e spesso commettendo errori gravi. L’idea di «vicino», d’altro canto, si
riferisce a quanto non comporta problemi; abitudini acquisite senza difficoltà permetteranno
di farcela, perché le abitudini non hanno un peso e non richiedono sforzi, e quindi
non ci danno esitazioni né ansietà. Quanto racchiudiamo nel termine «comunità locale»
viene a definirsi proprio dalla opposizione tra «qui» e «là», «vicino» e «molto lontano».
La storia moderna è stata segnata dal progresso costante dei mezzi di trasporto. Trasporti
e viaggi sono stati caratterizzati da innovazioni particolarmente radicali e rapide;
in questo campo il progresso, come Schumpeter ha notato molto tempo fa, non è stato
il risultato della crescita del numero delle carrozze, ma dell’invenzione e della
produzione di massa di mezzi di trasporto completamente nuovi, quali treni, automobili
e aeroplani. Proprio la disponibilità nuova di mezzi di trasporto rapidi ha avviato
il processo, tipico della modernità, che avrebbe eroso e messo in crisi tutte quelle
«totalità» sociali e culturali che si erano arroccate e radicate in un luogo, un processo
che Tönnies ha per la prima volta racchiuso nella nota definizione della modernità
come passaggio dalla Gemeinschaft alla Gesellschaft, dalla comunità alla società.
Tra i fattori tecnici che hanno determinato la mobilità, un ruolo particolarmente
rilevante ha giocato il trasporto dell’informazione; genere di comunicazione che non
comporta affatto, o comporta solo in maniera secondaria e marginale, un movimento
di corpi e cose. Costante e rilevante è stato anche lo sviluppo di mezzi tecnici che
hanno consentito all’informazione di viaggiare separata e indipendente da vettori
corporei, e anche dagli oggetti sui quali essa informava: mezzi che liberavano i «significanti»
dal vincolo delle cose e degli eventi «significati». La separazione tra i flussi dell’informazione
e i movimenti dei suoi vettori e dei suoi oggetti ha consentito a sua volta di differenziare
le loro velocità; le informazioni hanno viaggiato a una velocità più rapida di quella
che i corpi, o le variazioni di situazioni su cui si informava, sono state in grado
di raggiungere. Alla fine, l’avvento della World Wide Web, la nuova rete mondiale
di computer, ha messo fine – per quanto riguarda l’informazione – alla nozione stessa
di «viaggio» (e di «distanza» da coprire) e fa sì che l’informazione, in teoria ma
anche in pratica, sia oggi disponibile all’istante in tutto il globo.
Sono enormi i risultati complessivi di questi recenti sviluppi. I loro effetti sull’interazione
di fenomeni come l’aggregazione e la divisione sociale sono stati ampiamente notati
e descritti nei minimi dettagli. Un po’ come notiamo «a che serve il martello» solo
quando l’attrezzo si è rotto, ora noi ci accorgiamo, con più chiarezza, del ruolo
che il tempo, lo spazio – e i mezzi per affrontarli – hanno giocato nel formare prima,
poi nel rendere stabili e flessibili, infine nel far crollare le totalità socio-culturali
e politiche. Le cosiddette «comunità ristrette» di un tempo sono state determinate
e tenute in vita, come possiamo ormai vedere, dalla discrasia tra i modi del comunicare
immediato all’interno delle piccole comunità – la loro misura era data dalle qualità innate e dai limiti
stessi delle facoltà naturali dell’uomo, vista, udito e capacità di mandare a memoria
– e gli enormi tempi e costi necessari a veicolare le informazioni tra più località. D’altro canto, la fragilità attuale e la breve vita delle comunità appaiono
essere in primo luogo il risultato proprio del restringersi o, addirittura, del venir
meno di tali diversità: se l’una e l’altra sono istantanee, le comunicazioni all’interno della comunità non godono più di alcun vantaggio rispetto a quelle tra comunità.
Michael Benedikt riassume il senso di questa nostra scoperta attinente al passato
e la nuova consapevolezza della profonda connessione che intercorre tra velocità del
viaggio e coesione della società:
Il tipo di unità che viene reso possibile, nella comunità di piccole dimensioni, dalla
natura quasi simultanea e dal costo vicino a zero delle comunicazioni basate sulla
parola detta, sui manifesti e sui ciclostilati, non tiene quando ci muoviamo su larga
scala. La coesione di una società, su qualsiasi scala, si realizza in funzione di
un consenso, di conoscenze condivise e, dove non esiste un costante aggiornamento
e una continua interazione, tale coesione dipende essenzialmente da una precoce, e
rigida, educazione all’interno di una data cultura e dalla capacità di tramandare
la memoria di tale cultura. La flessibilità sociale, invece, dipende dalla capacità
di dimenticare e da comunicazioni a basso costo5.
Aggiungiamo che la congiunzione e, nell’ultima frase citata, è superflua; la facilità di dimenticare e il basso costo
(e la rapidità estrema) delle comunicazioni sono semplicemente due aspetti della stessa
situazione, ed è difficile pensarli separatamente. Saper comunicare a basso costo
vuol dire che ci si deve sterilizzare e liberare in fretta di un eccesso di informazioni
ricevute, così come significa che non fanno che arrivare, velocemente, notizie e notizie
ancora, immediate. Poiché le capacità dei nostri sensi e del nostro cervello sono
rimaste in larga parte le stesse fin dal Paleolitico, le comunicazioni a basso costo
soffocano e intasano la memoria, piuttosto che nutrirla e rafforzarla. Si potrebbe
sostenere che lo sviluppo più fecondo, tra quelli recenti, consiste nel fatto che
sono venute meno le differenze di costo tra la trasmissione delle informazioni su
scala locale e quella su scala globale (dovunque si invii un messaggio via Internet,
il costo è quello di una «chiamata locale», fattore di enorme importanza sul piano
culturale oltre che su quello economico); ciò però vuol dire che l’informazione che
alla fine arriva e reclama l’attenzione dell’uditorio – e pretende di entrare e permanere
(sia pur brevemente) nella memoria – per lo più ha origine nei siti più diversi e
indipendenti l’uno dell’altro e quindi, probabilmente, fornisce messaggi incompatibili
l’uno con l’altro o che tendono a cancellarsi reciprocamente – in netto contrasto
con i messaggi che circolano all’interno di comunità prive di hardware e di software e che si basano solo su «programmi» sensoriali; ossia con i messaggi che tendono a
reiterarsi e a rafforzarsi a vicenda, alimentando un processo di memorizzazione selettiva.
Come dice Timothy W. Luke, «la spazialità delle società tradizionali è organizzata
attorno alle più immediate capacità del normale corpo umano»:
Nella tradizione le attività venivano viste facendo ricorso a metafore tratte dalla
vita organica: i conflitti si svolgevano faccia a faccia; le battaglie si combattevano
a viso aperto. La giustizia voleva l’occhio per occhio, dente per dente. La discussione
era accorata. La solidarietà si faceva spalla a spalla. Il senso della collettività
si manifestava mettendosi a braccetto, l’amicizia mano nella mano. E le innovazioni
venivano introdotte un passo alla volta.
Questa situazione è mutata radicalmente quando sono stati introdotti e sviluppati
mezzi grazie ai quali i conflitti, la solidarietà, il dibattito o l’amministrazione
della giustizia sono andati ben al di là di quanto non potessero fare l’occhio e il
braccio. Lo spazio è stato lavorato, accentrato, organizzato, normalizzato e, soprattutto,
emancipato dai formali limiti del corpo umano. Sono state quindi le capacità della
tecnica, la rapidità dei suoi sviluppi e il costo del suo utilizzo che, da quel momento,
hanno «organizzato lo spazio». «Lo spazio che la tecnica progetta è radicalmente diverso:
artificiale, non naturale; mediato da una strumentazione, non immediato; razionalizzato,
non reso comunitario; nazionale, non locale»6.
Lo spazio moderno, trasformato dalle opere d’ingegneria, doveva essere un organismo
duro, solido, permanente e impenetrabile. Cemento e acciaio dovevano essere la sua
carne, la rete di rotaie e autostrade le sue vene. Gli scrittori che hanno inventato
le utopie moderne non distinguevano tra ordine sociale e architettonico, tra unità
e divisioni sociali e territoriali; per essi – e per i responsabili dell’ordine sociale
a loro contemporanei – nell’organizzazione dello spazio bisognava cercare la chiave
dell’ordine di una società. La totalità sociale doveva essere intesa come una gerarchia
di località sempre più ampie e pervasive, con l’autorità sovra-locale dello stato
arrampicata in cima a sorvegliare il tutto, mentre esso stesso era esente da una vigilanza
quotidiana.
Al di sopra di questo spazio territoriale-urbanistico-architettonico trasformato dall’ingegneria,
con l’avvento della rete globale dell’informazione è stata imposta una terza dimensione
del mondo umano, lo spazio cibernetico, o ciberspazio. Gli elementi di questo spazio, secondo Paul Virilio, sono «privi di dimensioni spaziali,
ma iscritti nella singolare temporalità di una diffusione istantanea. Da ora in poi,
ostacoli fisici o distanze temporali non potranno più separare la gente. Con l’interazione
fra i terminali dei computer e i video, la distinzione tra ‘qui’ e ‘là’ non significa
più nulla»7.
Come per lo più non siamo corretti quando, parlando della condizione «umana», ci esprimiamo
in termini di unicità (la nostra vicenda è una e una sola per tutti), così non è del
tutto corretta quest’ultima recisa affermazione di Virilio. «L’interagire di terminali»
ha avuto effetti diversificati sulla sorte di tipi diversi di persone. Alcune – in
realtà davvero molte – possono ancora, come prima, essere tenute «separate da ostacoli
fisici e da distanze temporali»; anzi, questa separazione è oggi ancor più spietata,
e ha effetti psicologici più profondi, di quanto non si sia mai verificato in passato.
Nuova velocità, nuova polarizzazione
In poche parole: piuttosto che rendere omogenea la condizione umana, l’annullamento tecnologico delle
distanze spazio-temporali tende a polarizzarla. Emancipa alcuni dai vincoli territoriali e fa sì che certi fattori generino comunità
extraterritoriali, mentre priva il territorio, in cui altri continuano a essere relegati,
del suo significato e della sua capacità di attribuire un’identità. Per alcuni, ancora,
quell’azzeramento delle distanze di spazio e tempo promette una libertà senza precedenti
dagli ostacoli di carattere fisico e una capacità inaudita di muoversi e di agire
a distanza. Per altri, invece, presagisce l’impossibilità di appropriarsi della località
– dalla quale pure hanno scarse possibilità di liberarsi per muoversi altrove – e
di renderla accogliente e vivibile. Quando le «distanze non significano più niente»,
le località, separate da distanze, perdono anch’esse il loro significato. Questo fenomeno,
tuttavia, attribuisce ad alcuni una libertà di creare significati, dove per altri
è la condanna a essere relegati nella insignificanza. Oggi accade così che alcuni
possano liberamente uscire dalla località – da qualsiasi località –. Mentre altri
guardano invece disperati al fatto che l’unica località che gli appartiene e abitano
gli sta sparendo da sotto i piedi.
Le informazioni viaggiano ormai indipende
...