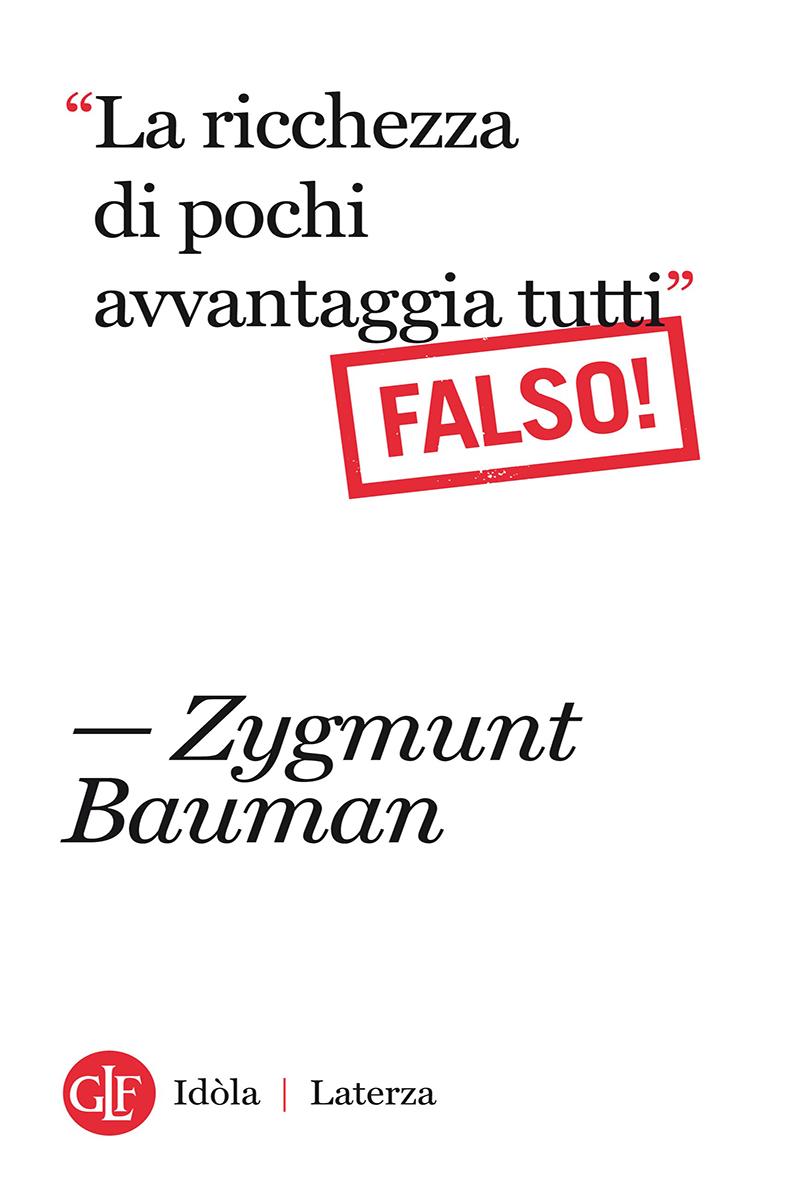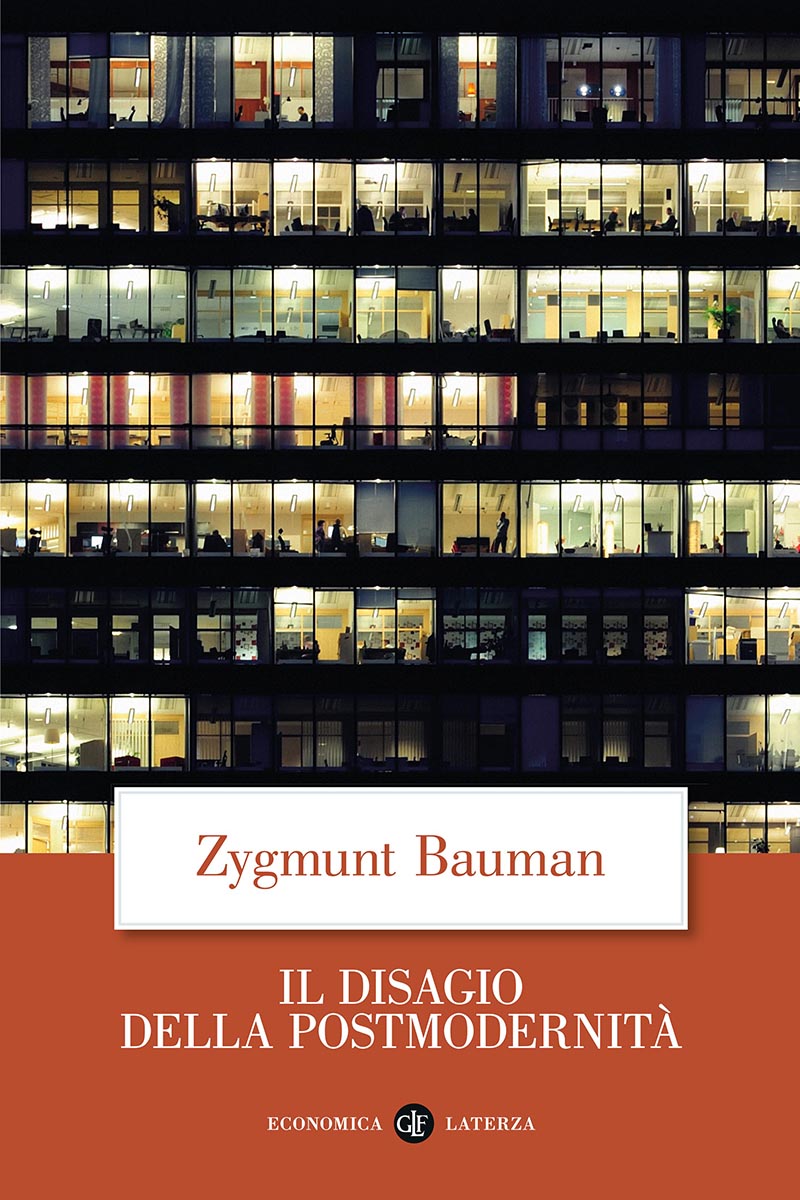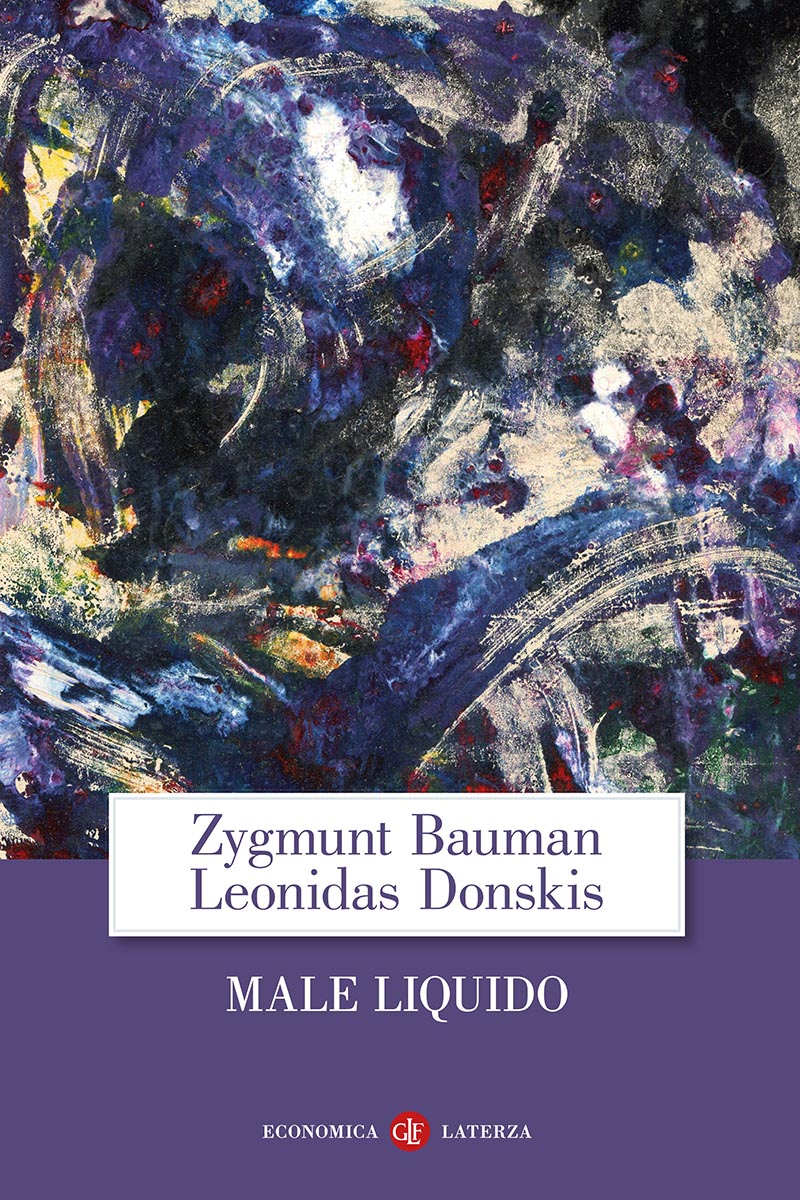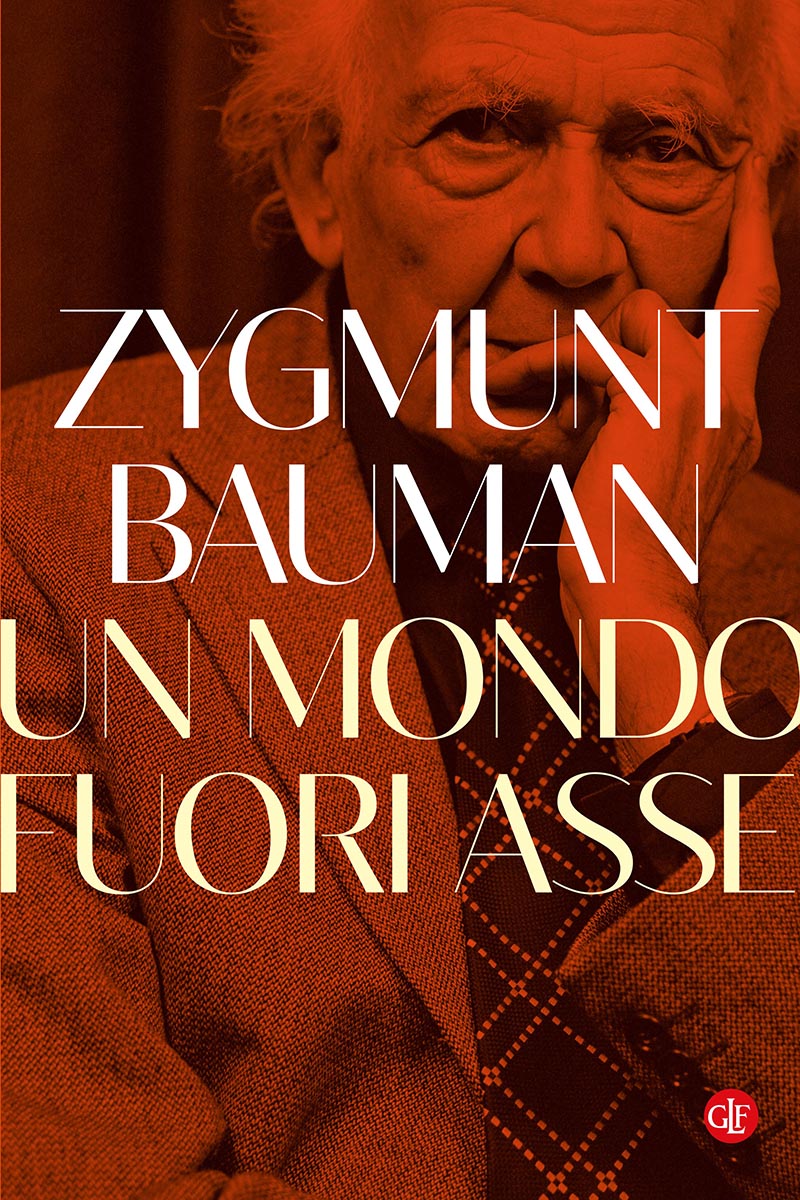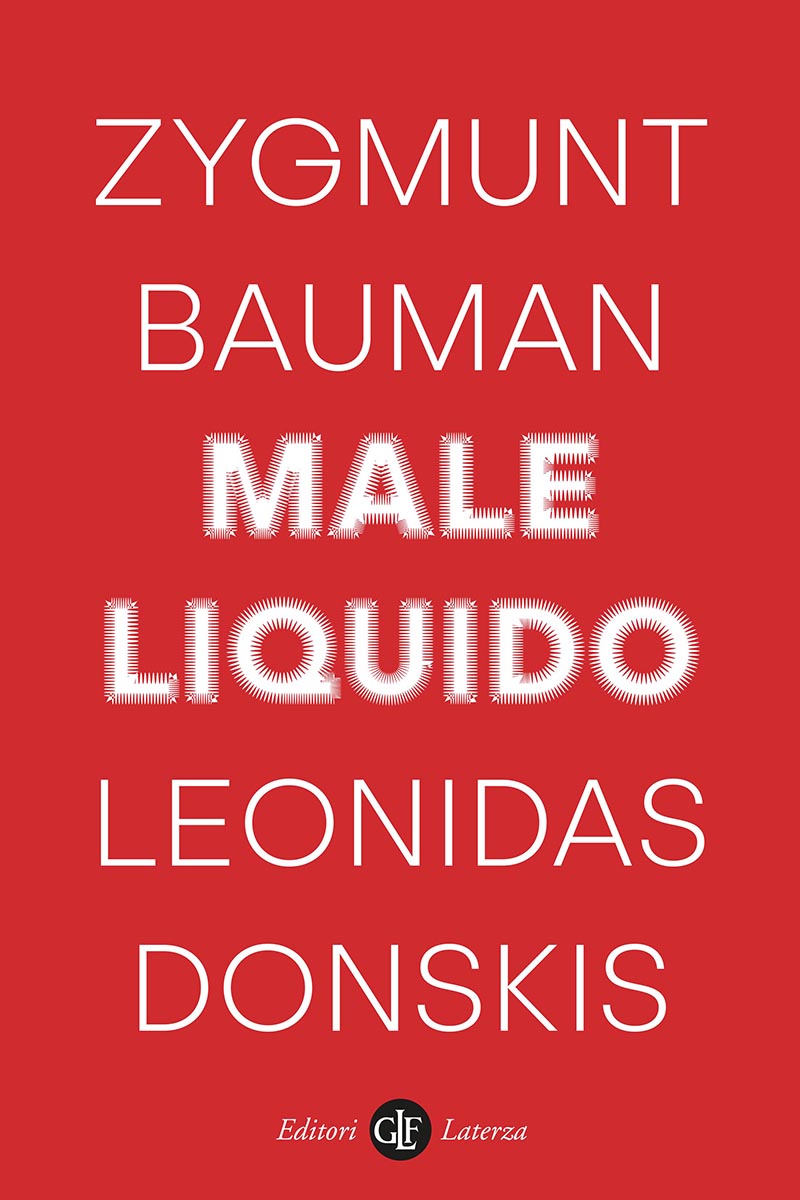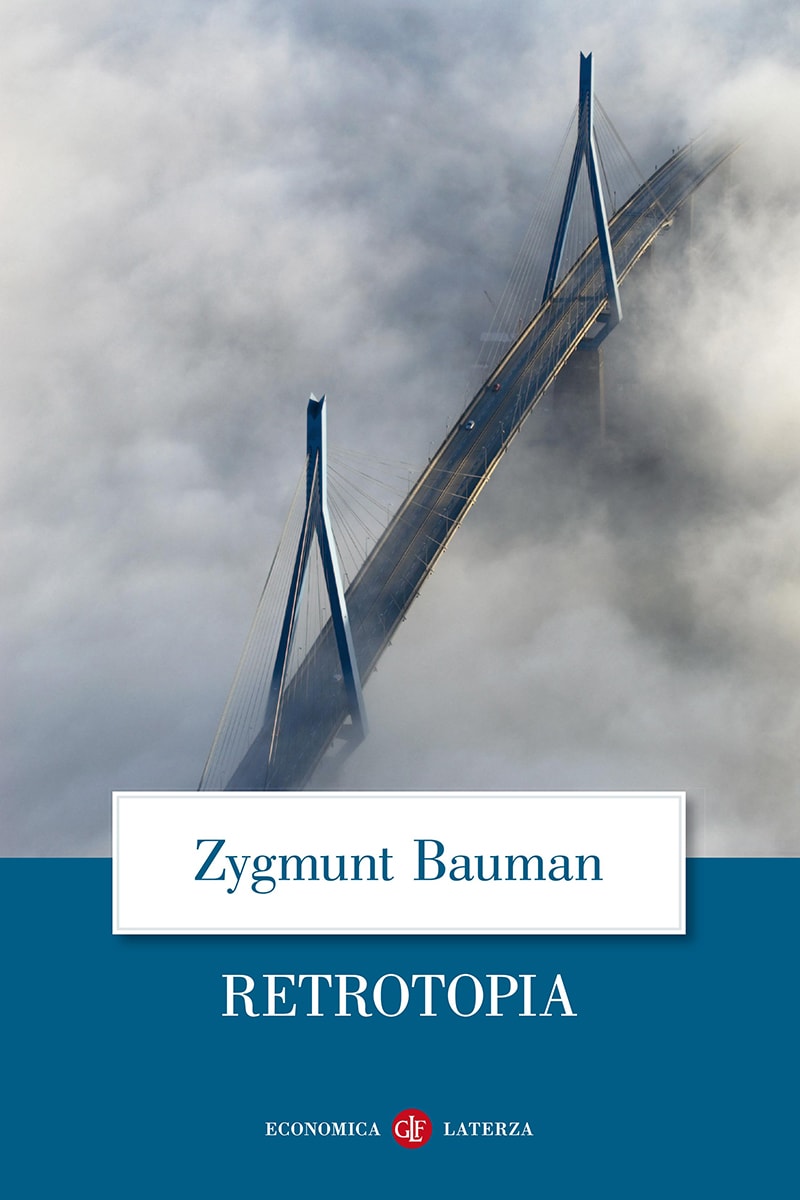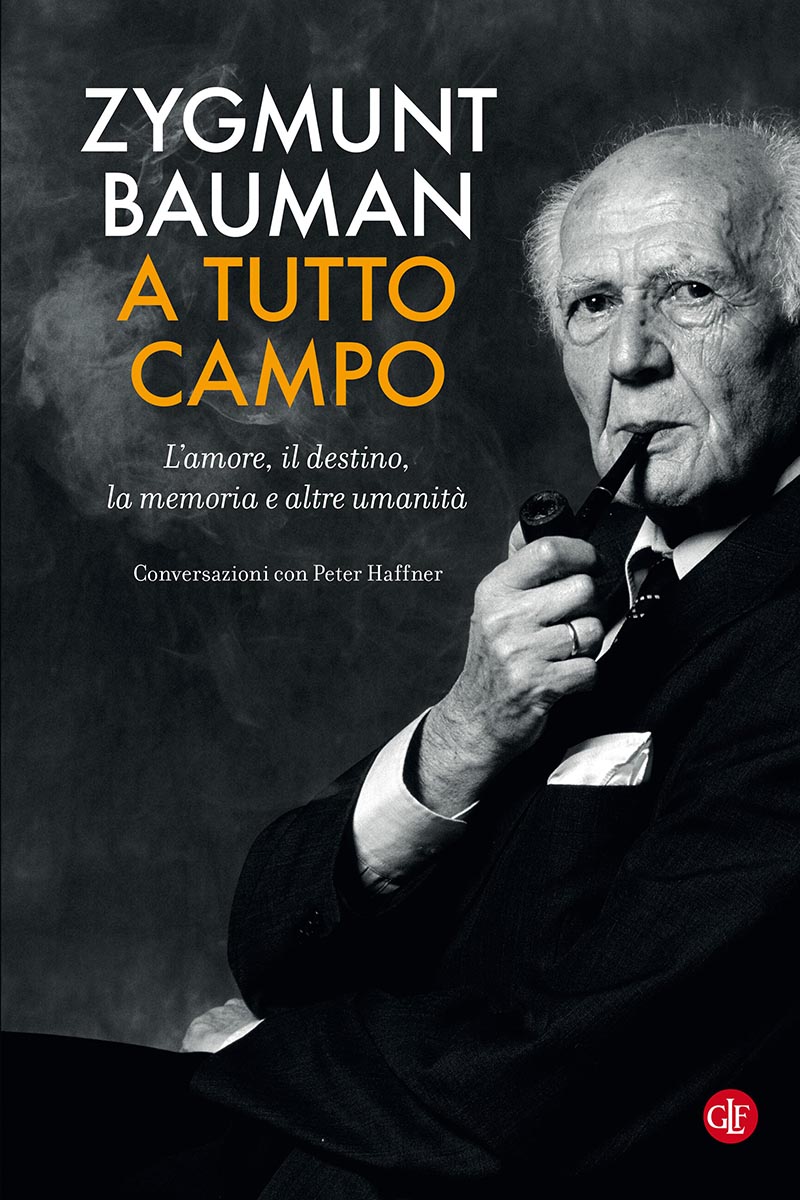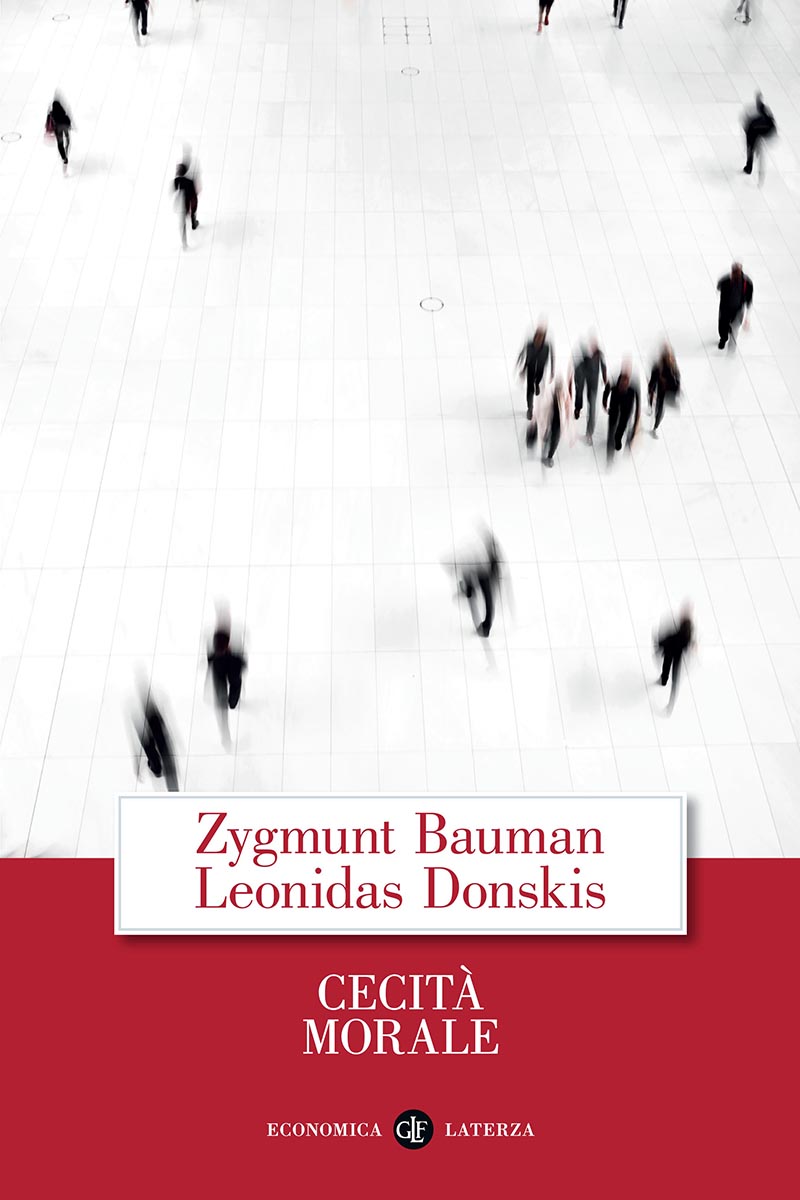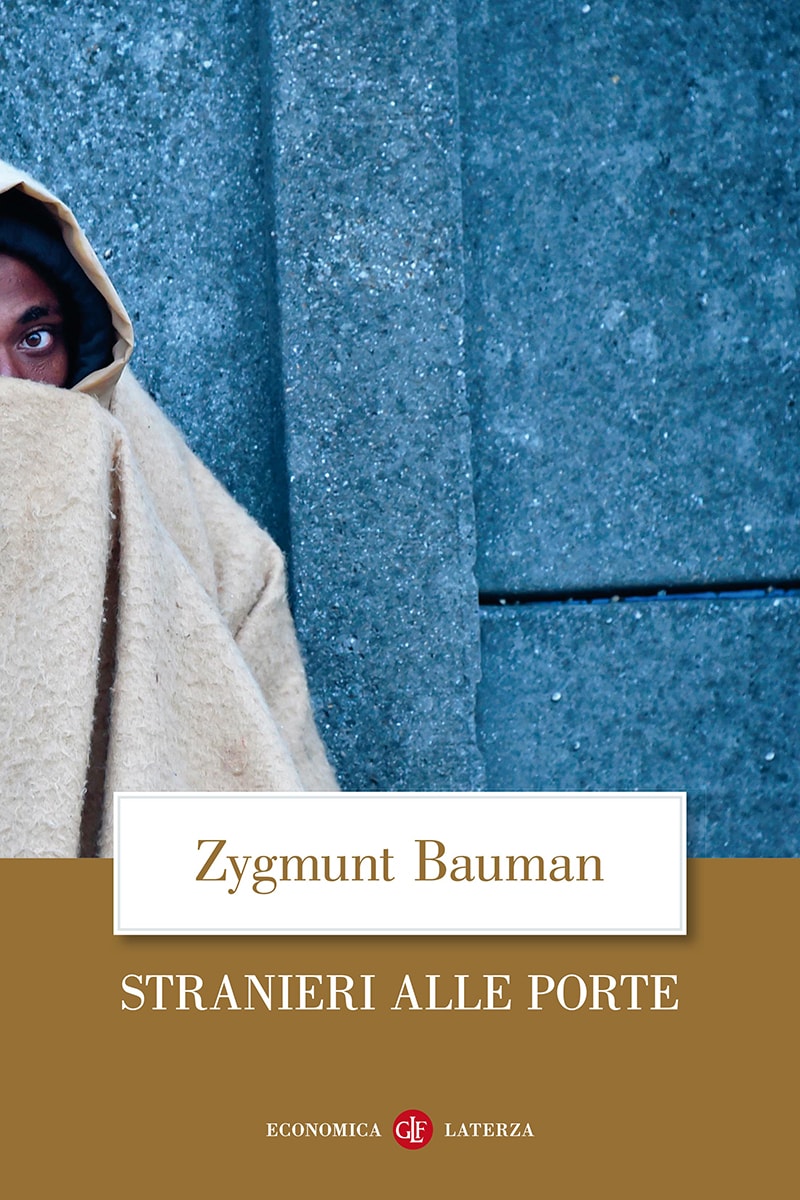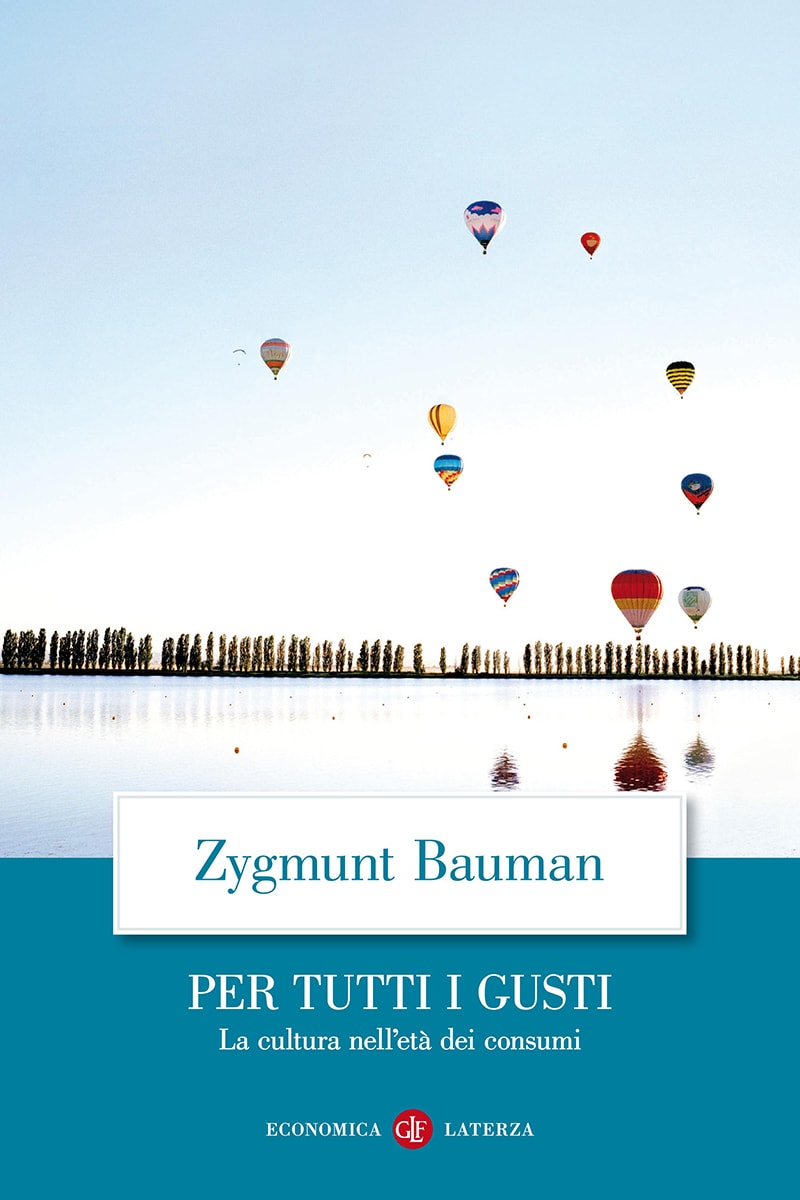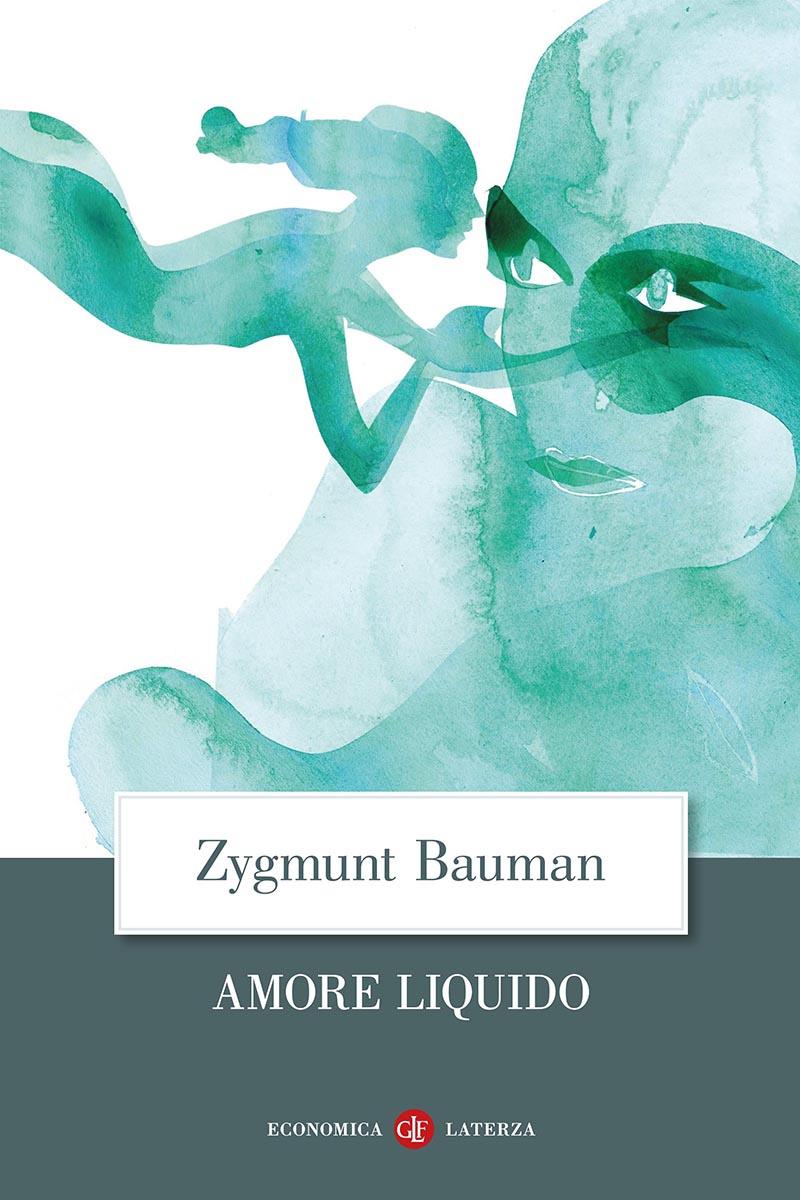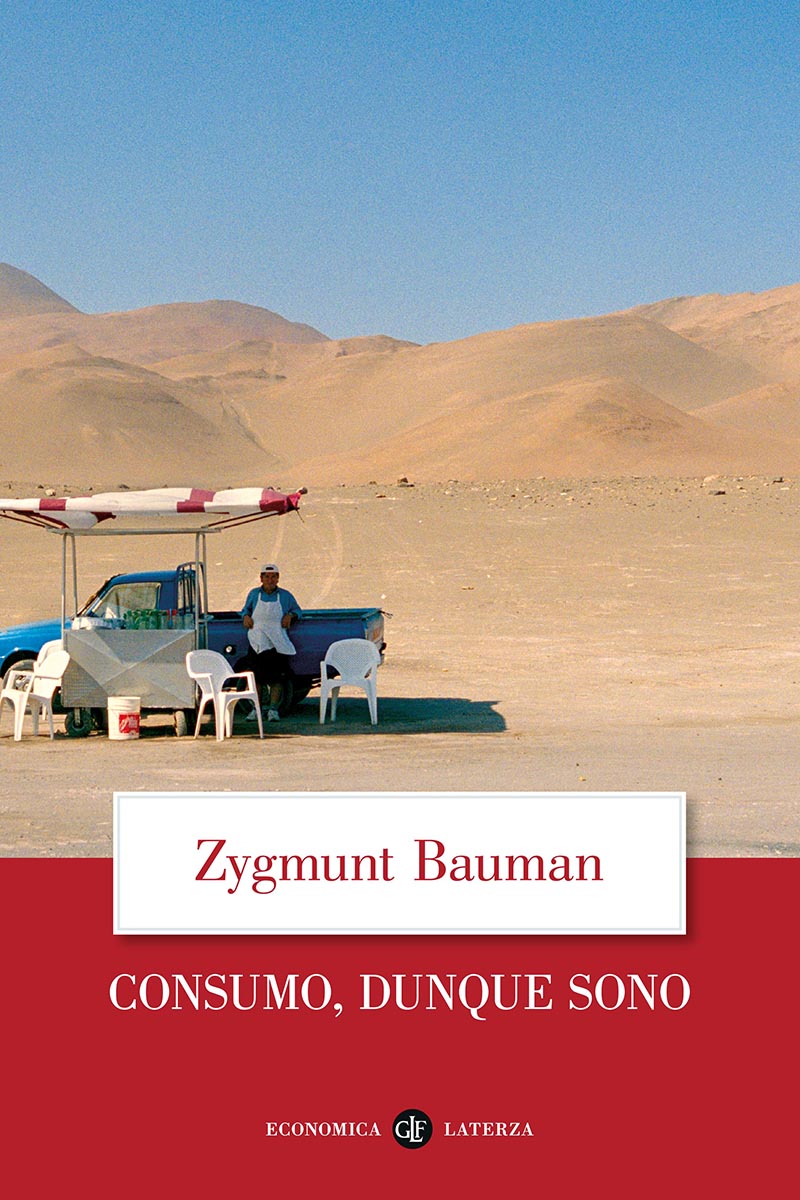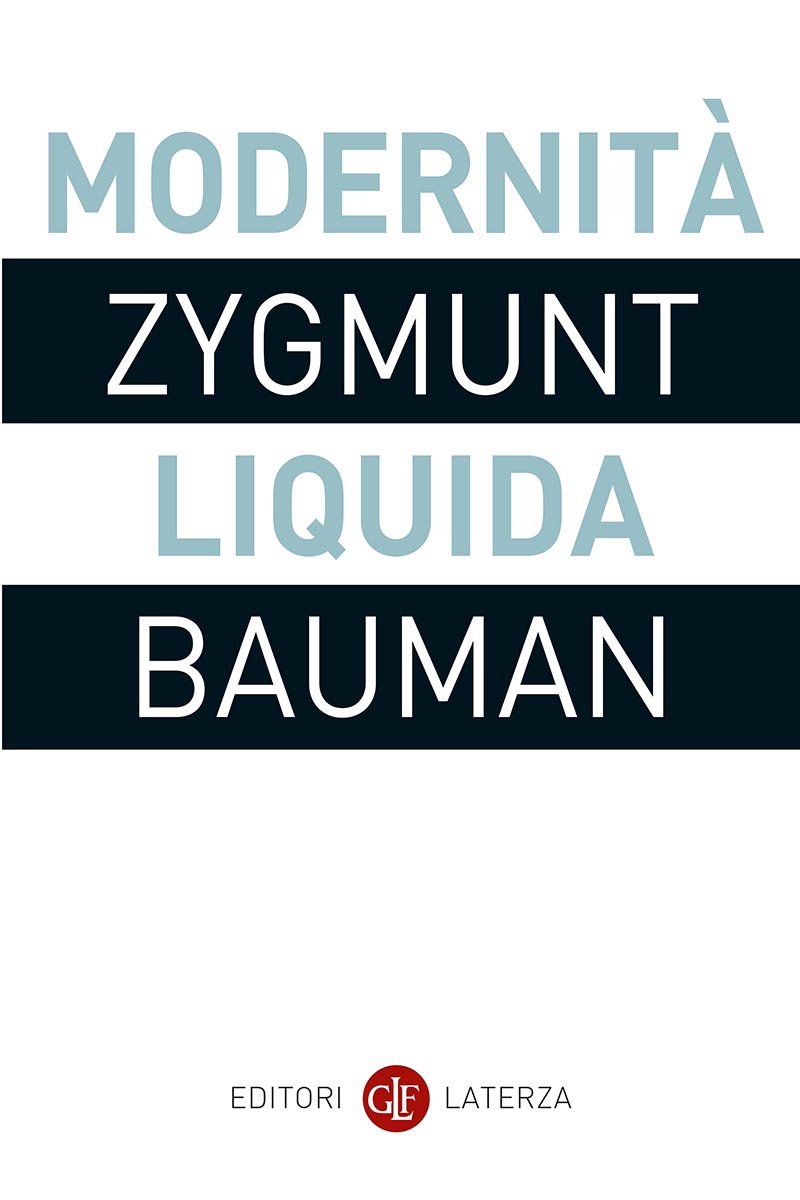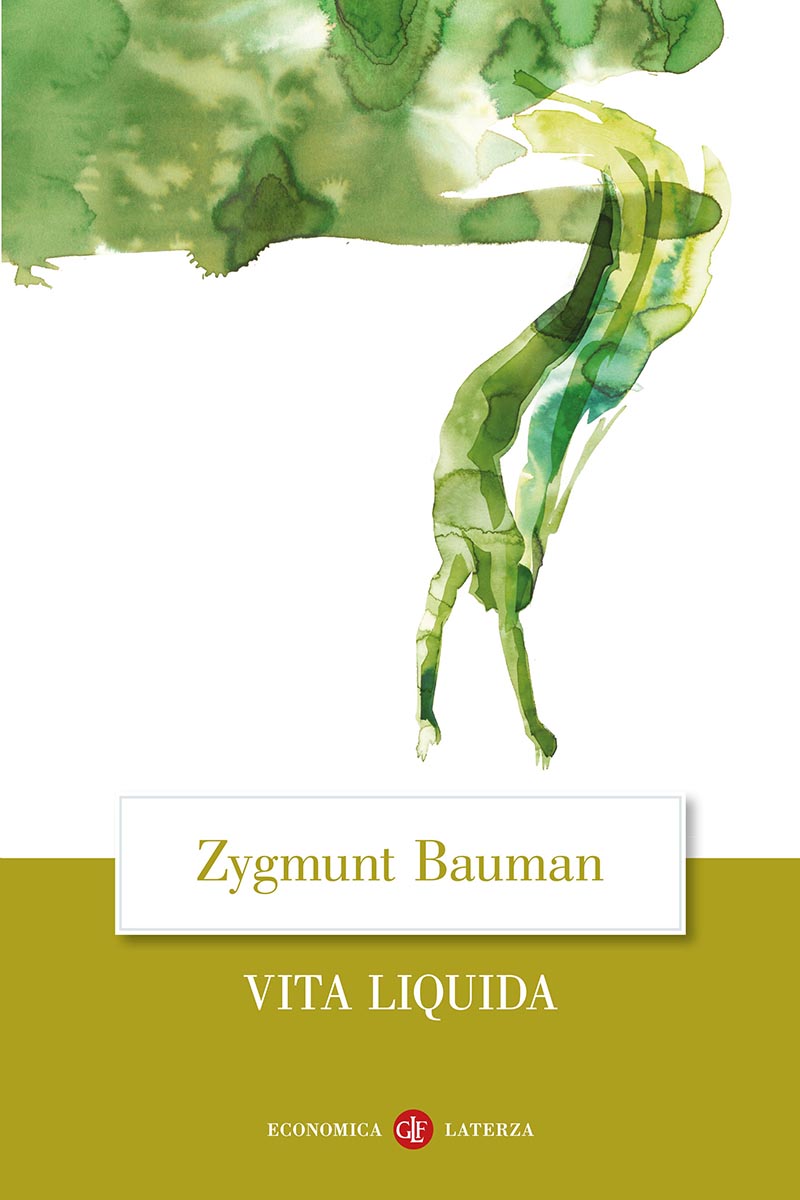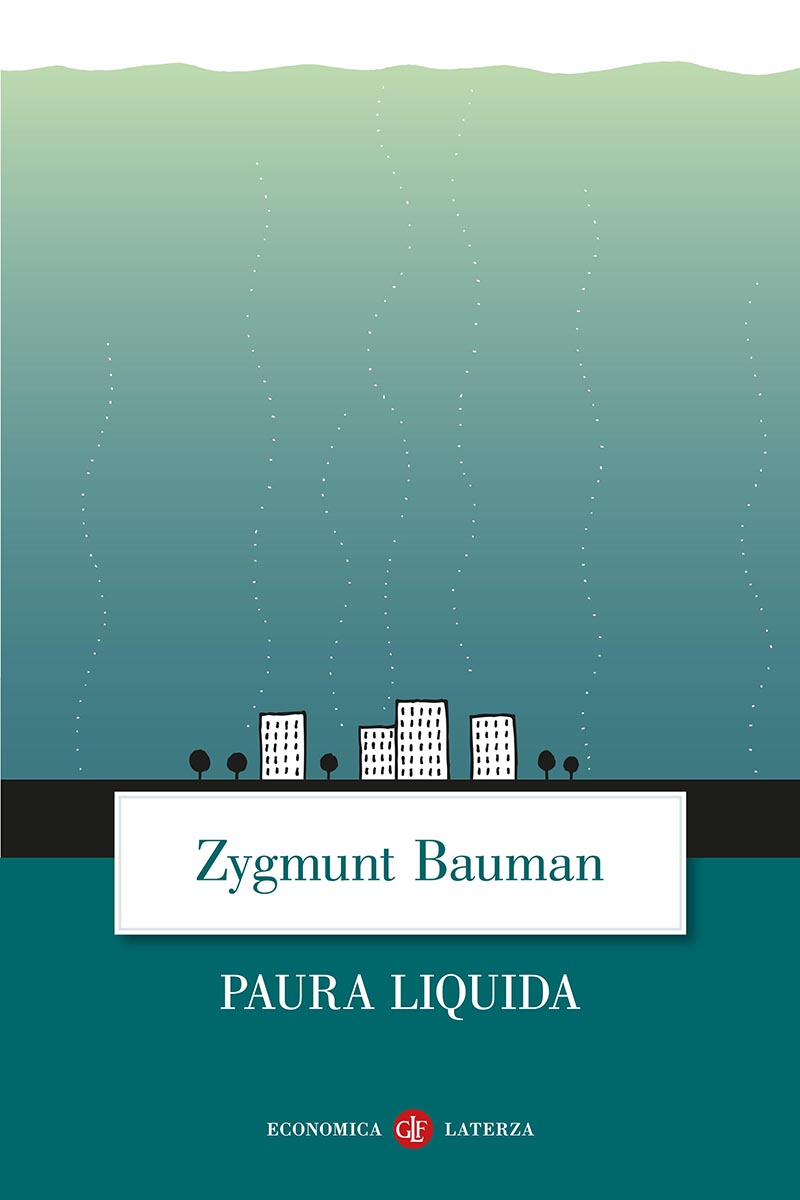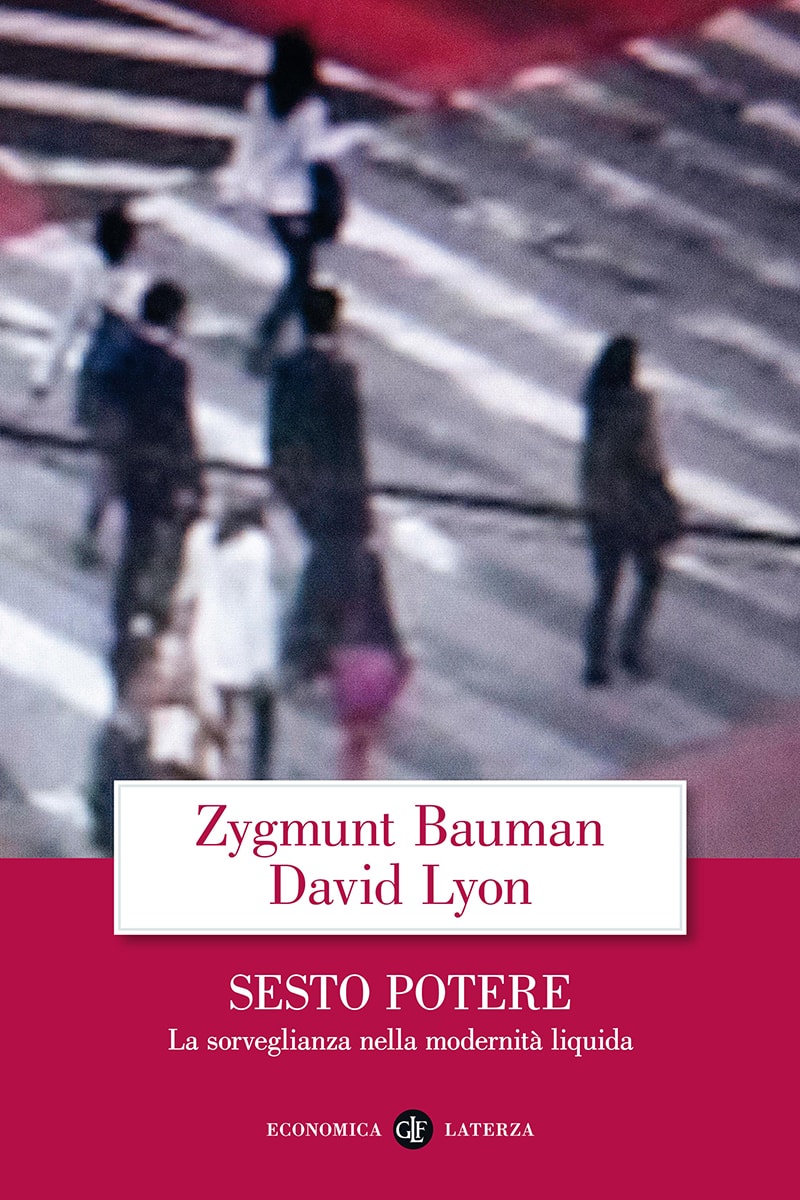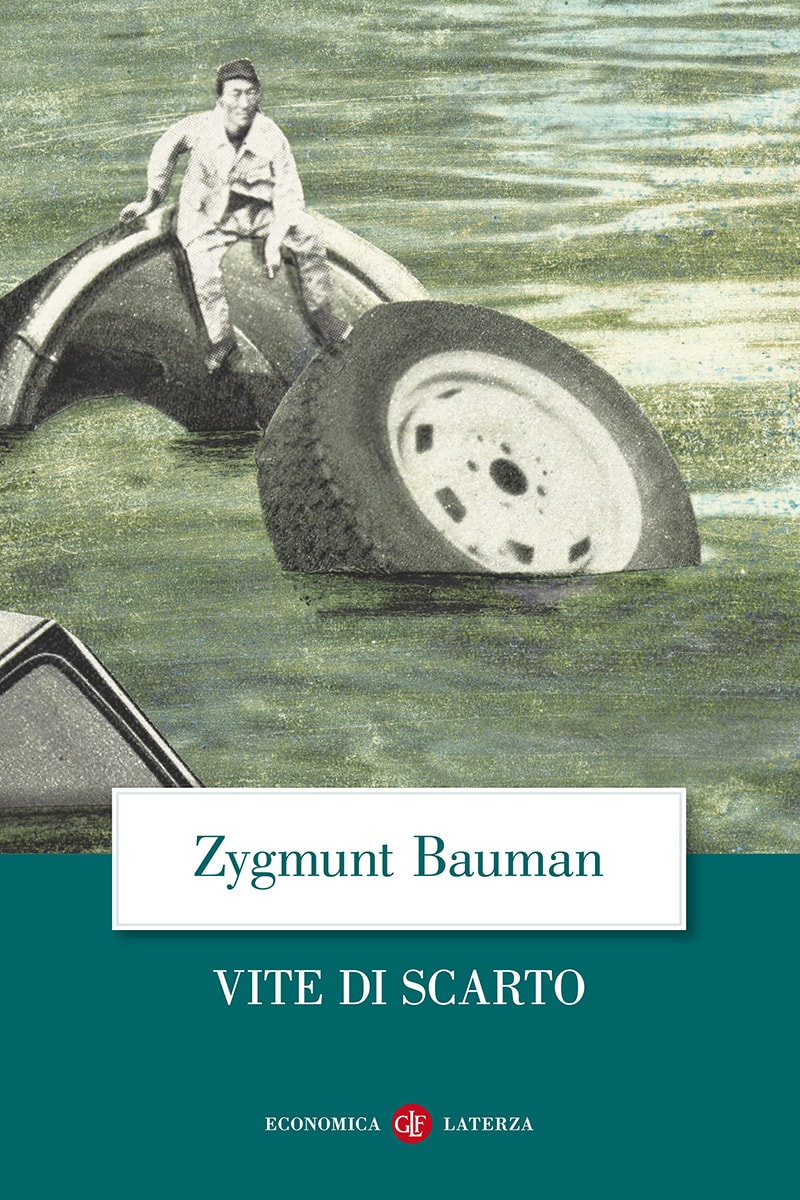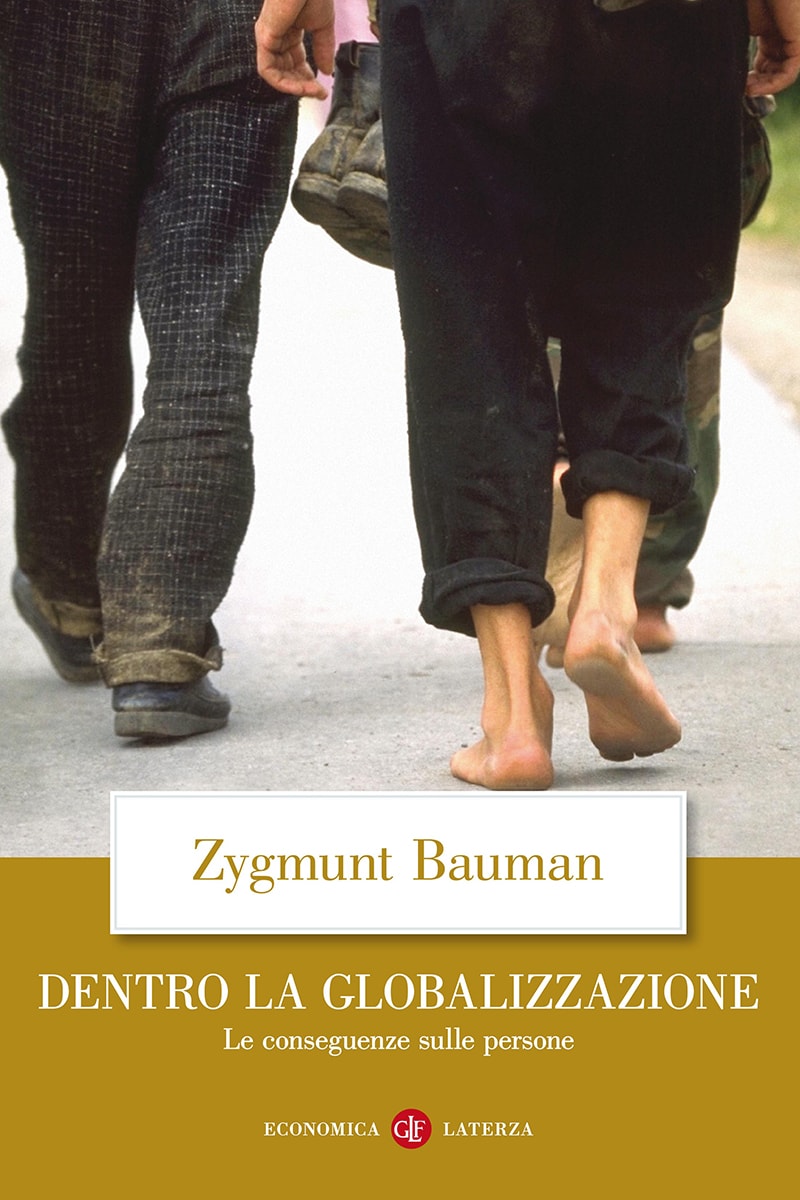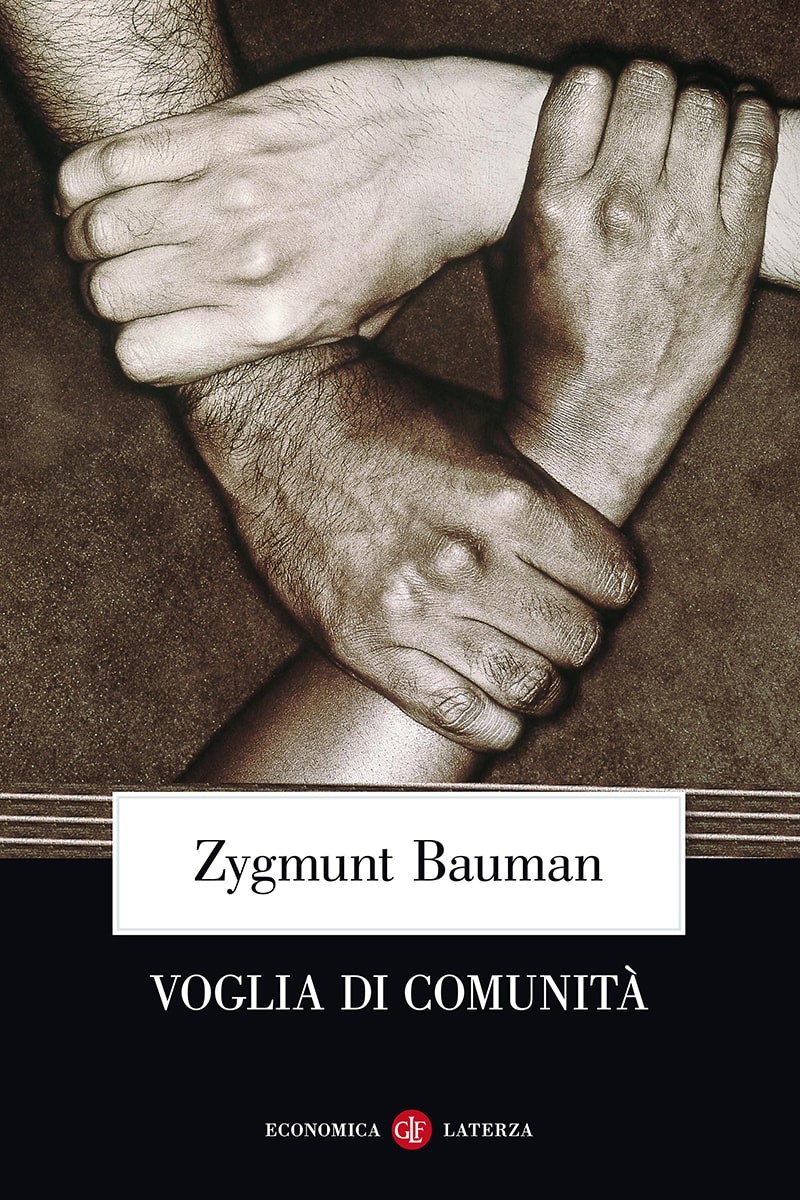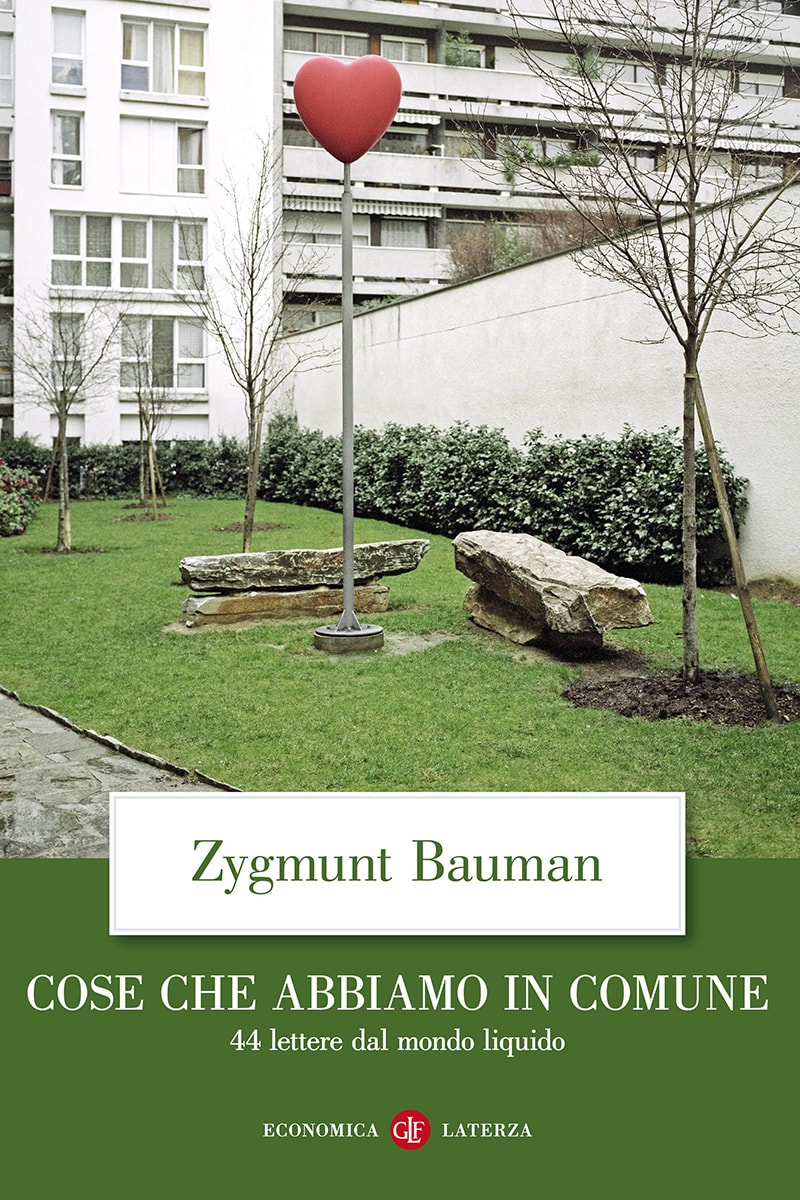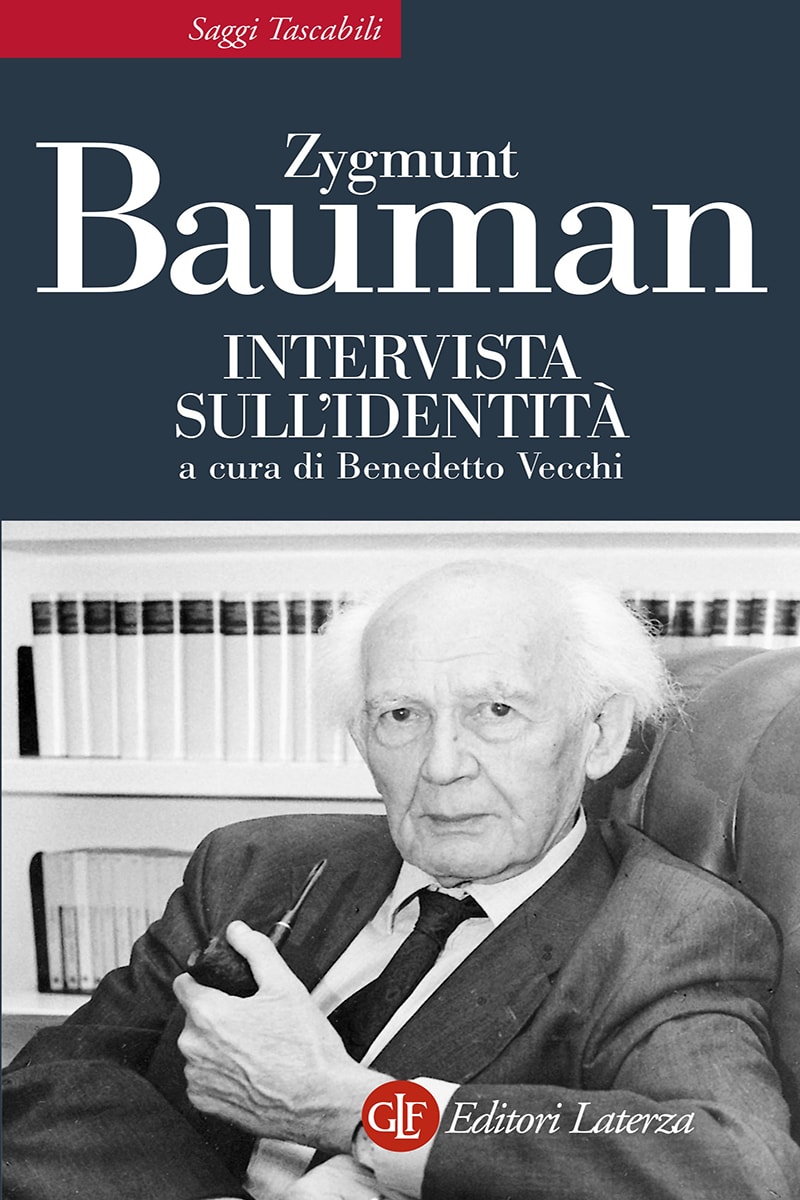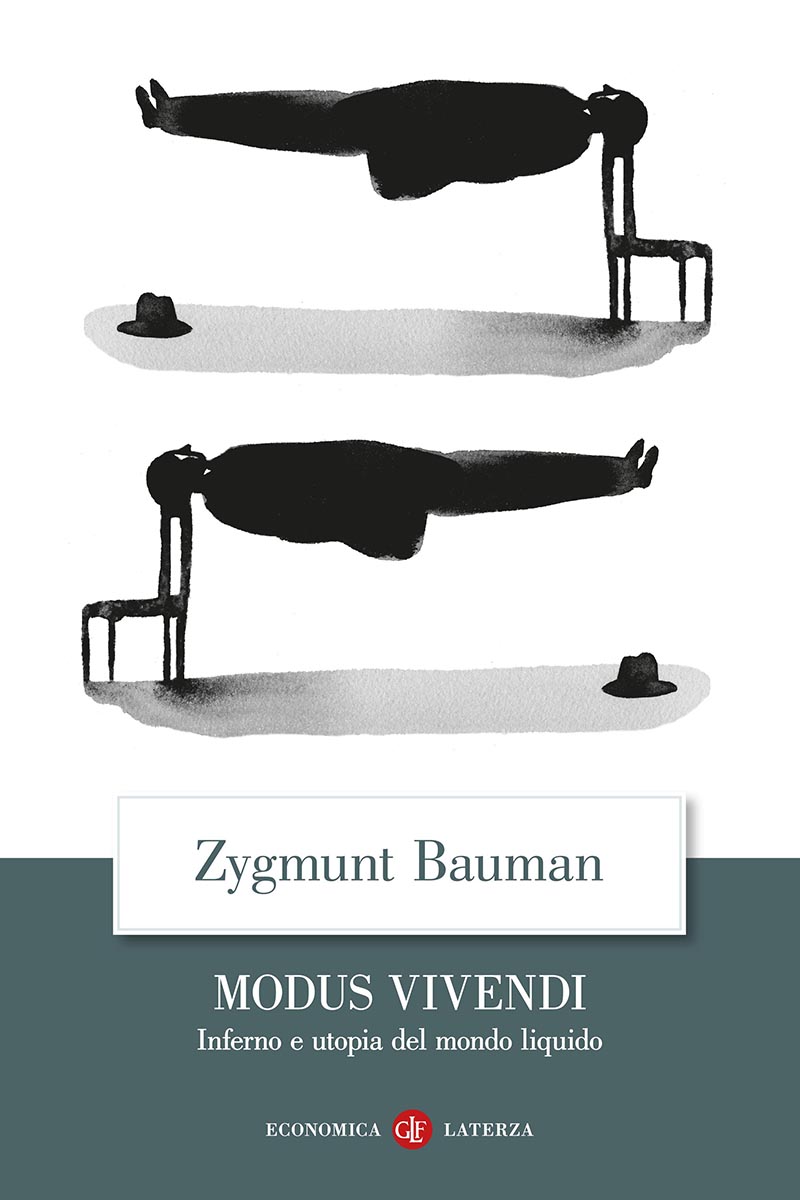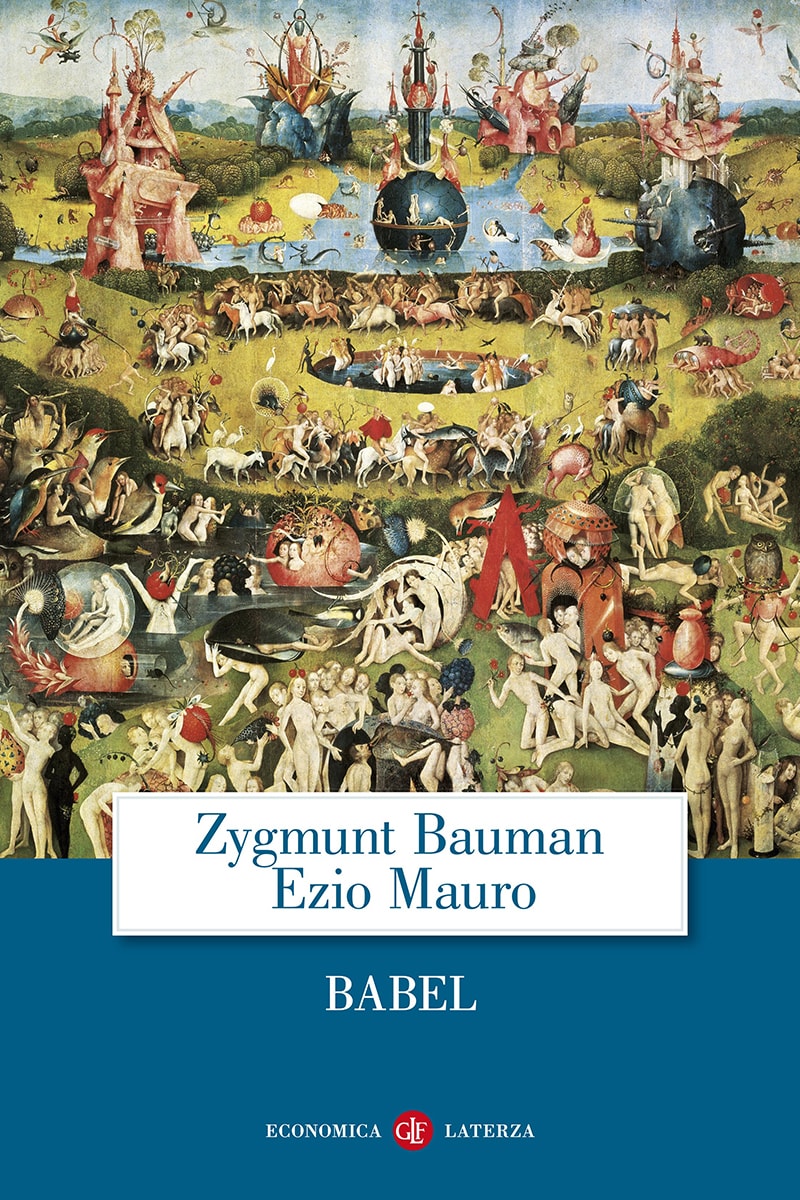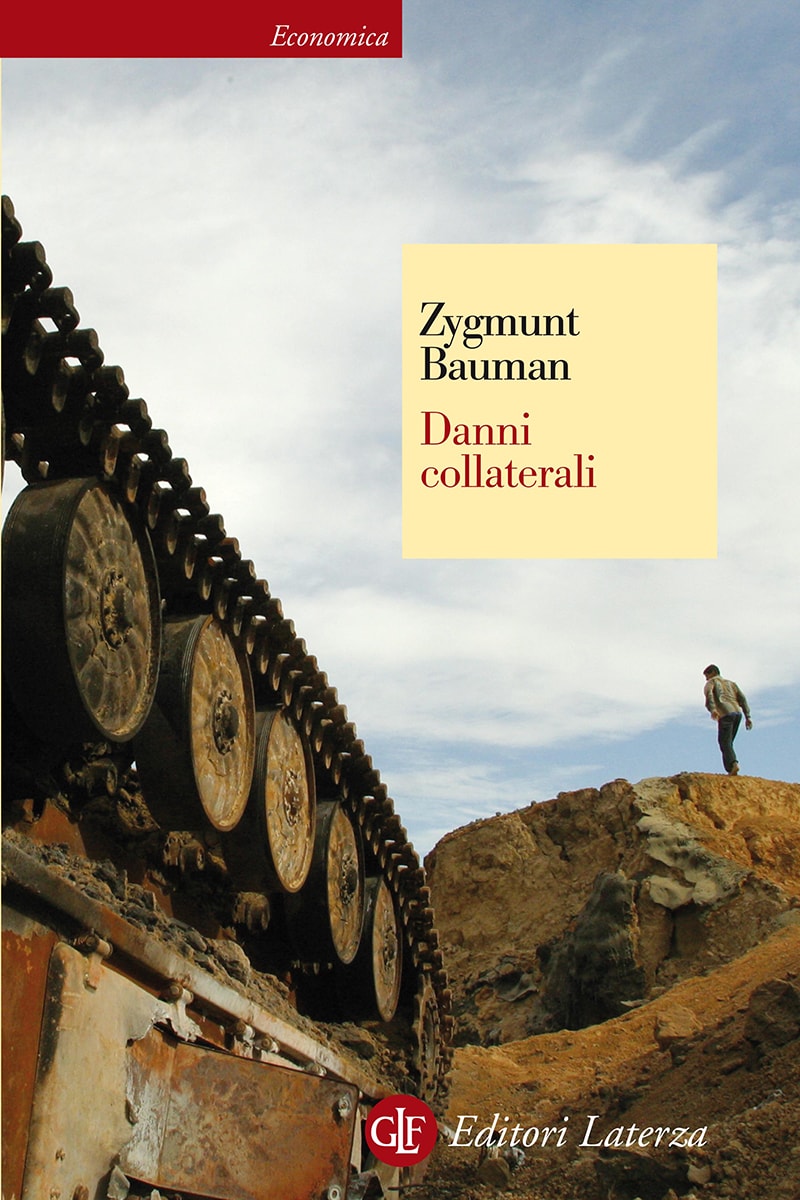I.
Un approdo comune
Stanisaw Obirek Le strade che hanno condotto me e te all’agnosticismo sono state diverse. Io
per anni sono rimasto nel sistema, anche se mi sentivo a disagio. Confidavo che lo
si potesse cambiare dall’interno. Finché questa fiducia l’ho persa. Oggi me ne sto
all’esterno, ma osservo con enorme curiosità quello che accade nel mondo della religione,
specialmente come essa agisce nella sfera pubblica. La tua avventura personale e intellettuale
con la religione sullo sfondo è diversa. Nondimeno, ciò che scrivi sulla religione,
e il modo in cui ne scrivi, è straordinariamente stimolante. Vorrei allora che mi
dicessi sulla religione qualcosa di più, e in modo più sistematico, rispetto a quanto
pubblicato finora, magari inscrivendolo più precisamente nella tua biografia intellettuale.
Forse possiamo iniziare da qui la nostra conversazione.
Zygmunt Bauman Davvero le strade che ci hanno condotto all’agnosticismo sono diverse? Certamente
lo sono nel senso che le religioni e le Chiese in cui «ci sentivamo a disagio», ma
che nonostante tutto ritenevamo di poter cambiare «dall’interno», erano differenti.
Penso tuttavia che solo in questo le nostre strade siano state diverse... Le nostre
perplessità spirituali, le nostre speranze di superarle e le nostre visioni di riforma
si sono inserite in ambiti concettuali e istituzionali diversi; ma rispetto alla logica
dei nostri percorsi, e forse anche alle vicissitudini delle mie e delle tue peregrinazioni,
esse sono, secondo me, sorprendentemente simili.
E per di più – ed è un «per di più» importante – partendo da due campi diversi ci
ritroviamo ora sullo stesso terreno. Ho l’impressione che ci bastino poche parole
per intenderci e che ciascuno di noi consideri «stimolanti» gli scritti dell’altro;
e forse questo accade perché sono stati timori simili, obiezioni simili e attrazioni
simili – spesso solo parzialmente consci, talvolta addirittura del tutto inconsci
– a tracciare la rotta delle nostre peregrinazioni spirituali... Ed è stato un percorso
dal monologo al dialogo, o al polilogo, dalla tracotanza del possessore di una verità
unica alla temperanza di chi è testimone della molteplicità delle verità umane, dal
monoteismo al... sì, appunto: al politeismo. Ecco come oggi, guardandomi indietro, me lo spiego: il «disagio» cui accenni è scaturito
dal trincerarsi di ogni Chiesa nella fortezza della propria ragione, dallo sbattere
la porta della fortezza in faccia a tutte le altre ragioni – a tutto ciò che non era
conciliabile con la propria ragione, oltre che a tutti quelli che dell’infallibilità
e dell’assenza di qualsiasi macchia di quella ragione non erano convinti – e, infine,
dalla compattezza nel negare a un dissidente il diritto di obiezione e disprezzare
il diverso: nell’umiliare e nel bandire, e persino nell’annientare chi pensa o crede
in modo non conforme. Sopra la porta sbattuta di quella fortezza stava scritto: «Se
il mio Dio è unico, a me che ne sono convinto tutto è permesso contro chi di questa
convinzione è privo».
L’agnosticismo, per dirla in breve – perlomeno quello che suppongo esso sia, nel tuo
caso come nel mio – non è l’antitesi della religione, o addirittura della Chiesa.
È l’antitesi del monoteismo e della Chiesa chiusa.
S.O. Con ciò abbiamo superato lo scoglio della prima domanda e della prima risposta.
Che è il più arduo, almeno per me. Come fu per Wisawa Szymborska la prima frase del
suo avvincente discorso in occasione del conferimento del premio Nobel. Il resto scorrerà
più semplice.
Non nascondo che mi dà un’enorme gioia il fatto che tu veda convergenze così profonde
nelle occasioni che la vita ci ha offerto. Di sicuro su di esse torneremo più di una
volta. Mi piace molto il tuo modo di cogliere il monoteismo che ci è, pur con contenuti così differenti, comune. Mi piacerebbe però parlare non
tanto di politeismo quanto dipolifonia. Già, perché dopotutto l’agnosticismo anche qui impone temperanza: non sappiamo infatti
se abbiamo a che fare con un Dio o con molti dèi. È difficile peraltro accertare l’esistenza
stessa di divinità. Lasciando perciò irrisolta tale questione, vorrei pregarti di
sviluppare il notevole aforisma con cui hai chiuso il tuo precedente intervento: «Se
il mio Dio è unico, a me che ne sono convinto tutto è permesso contro chi di questa
convinzione è privo». È proprio in questi termini che concepisci lo spietato sviluppo
del monoteismo? (Sorvoliamo sulla questione che si tratti di monoteismo religioso
o laico – perché infatti anche il pensiero ateo può essere escludente.) Se così è,
che fare del desiderio di trovare la verità insito nel dipanarsi della storia, della
gioia di trovarla, dello stringente bisogno di convincere di essa gli altri...?
Z.B. Il domenicano Maciej Ziba usa il concetto di «società veritale» (da veritas) per indicare quella modalità di convivenza umana secondo cui «la totalità della
vita individuale dalla nascita fino alla tomba, e della vita sociale» si organizza
«secondo una verità trascendente universalmente riconosciuta». E perché sia chiaro
quale modalità ha in mente, padre Ziba si affretta ad aggiungere che «ciò non riguarda soltanto gli Aztechi o i Masai»
(e neanche, come aveva spiegato in precedenza, il progetto Christianitas di Alcuino), «ma anche i seguaci di Marx, Mao Zedong o gli acritici, parareligiosi
seguaci della fisica o della genetica». Da parte mia aggiungerei alla lista anche i parareligiosi seguaci del Pil, della
circolazione delle merci o dell’informatica. Per tutti loro Dio è unico; questa caratteristica comune rende marginali le differenze che li dividono, come
pure la varietà dei nomi e dei tratti distintivi della fonte da cui scaturisce o del
campo in cui si coltiva la «verità trascendente universalmente riconosciuta». Tutte
le «società veritali» dichiarano guerra all’eterogeneità dei principi di vita e delle
loro autorità; tutte si arrogano il monopolio nella demarcazione dei confini tra il
bene e il male, la virtù e il vizio, il merito e la colpa, l’ortodossia e l’eresia,
la fede e il paganesimo, il vero e il falso. Ziba cita L’Europa dei barbari di Karol Modzelewski: ciò che, nell’incontro con i missionari cristiani, «riempiva i barbari di orrore
non era tanto il dio straniero in sé, quanto le pretese di monoteismo. Non mancano
testimonianze del fatto che i pagani erano pronti a includere Cristo nel proprio pantheon,
perché non mettevano in discussione né la sua esistenza, né la sua potenza [...].
Il battesimo in sé non spaventava. Spaventava l’ostentata distruzione del vecchio
culto che accompagnava l’accoglimento della nuova fede».
D’altra parte – secondo i testi tramandati dai cronachisti e l’interpretazione che
ne danno gli storici –, gli imperatori romani, con la loro politica di aggiungere
al pantheon di Roma gli idoli dei paesi di nuova conquista, non avevano particolari
difficoltà ad assicurarsi l’obbedienza dei popoli sottomessi. L’unica eccezione a
questa regola fu, come sappiamo, la Giudea – dove covavano incessanti la ribellione
e la protesta – perché era anche, in seno all’impero, il solo rifugio dell’idea di
«Dio unico»; per il suo popolo sarebbe stato intollerabile anche solo pensare di collocare
il proprio Dio in compagnia di altri dèi, i quali comunque, in ragione della propria
diversità, non potevano essere altro che falsi pretendenti al trono divino.
Chiamala polifonia, se preferisci, o politeismo – fenomeno noto molto prima che venisse
creata la polifonia –, ma è ciò che si associa a una pacifica convivenza fra i diversi
modi di essere uomini; al contrario, il monoteismo si accompagna a una lotta fratricida
tra quei modi, a una guerra reciproca fino allo sfinimento o all’annientamento. E
nella nozione di «verità», non importa se munita dell’attributo «unica» o meno, è
già insito il concetto, quasi inscindibile, di «unicità», o quantomeno il suo postulato
(propenderei addirittura per l’idea che la formula «verità unica» costituisca, analogamente
all’espressione «i volatili sono animali che volano», una tautologia). «Verità» è
un concetto, per origine e natura intrinseca, agonistico, che è potuto nascere solo
in collisione con la sua alternativa nei momenti in cui una convinzione cessava di
essere ovvia (per dirla più precisamente, veniva tratta fuori dal buio dell’impercettibilità)
a causa della comparsa di un’alternativa o di un concorrente; in altre parole – come
scriveva Heidegger – quando quel convincimento, fino ad allora inarticolato (e perché
mai doveva essere diversamente?), veniva sospinto fuori dalla sfera dello zuhanden nella sfera del vorhanden – e quindi, in ragione del suo essere messo in discussione, diventava oggetto di
attenzione, stimolando di conseguenza indagini e azioni... Il concetto di «verità»
non avrebbe senso senza polifonia e senza la tentazione, scaturita dalla molteplicità
delle credenze e delle opinioni, di rivaleggiare e lottare per il predominio. Il bisogno
di questo concetto sorge allorquando l’affermazione «è come è» deve essere completata
dalla considerazione: «e non è come gli altri (chiunque siano gli altri) pensano».
La «verità» appartiene alvocabolario del monoteismo – e, in fin dei conti, del monologo...
Dalla Sacra Scrittura sappiamo che solo Dio, proprio in ragione della sua unicità,
poteva presentarsi a Mosè con le parole: «Io sono colui che è». Gli altri candidati
allo status divino nominati nella Bibbia portano, come la gente comune, nomi propri
– ovvero esprimono una propria differentia specifica che presuppone/segnala la presenza di un insieme di più elementi. L’anonimia del
Dio di Mosè costituisce nella Bibbia l’unica eccezione – ed è l’unica eccezione immaginabile.
Non serve possedere un nome proprio se si è, e fin quando si è, un essere unico. L’idea
di «verità» è una sferza per gli infedeli e gli increduli: solo gli apologeti e i
missionari del Dio biblico, trovatisi al cospetto del politeismo, furono costretti
ad argomentare la sua verità (ossia la falsità di tutti gli altri). Può darsi che
le guerre di religione abbiano avuto origine dalla ricerca della verità; ma è certo
che il loro scopo dichiarato era la dimostrazione di una verità messa in discussione
e la demolizione di una verità che metteva in discussione.
Maciej Kalarus, studioso straordinariamente acuto del nostro mondo polifonico e instancabile,
impavido osservatore dei suoi angoli di rado visitati da curiosi e ricercatori di
professione, chiede che la parola «verità», analogamente a vocaboli come forbici o
pantaloni, possa essere usata solo al plurale (pretendendo con ciò stesso una Lebenswelt – un mondo vissuto, un mondo delle esperienze – che ne consenta esclusivamente quest’uso).
Effettivamente, usare la parola «verità» al singolare in un mondo polifonico è un
po’ come pretendere di applaudire con una mano sola... Con una mano sola si possono
dare pugni sul muso, ma non applaudire. Anche con la verità unica si può picchiare
(del resto è stata inventata a questo scopo...), ma con il suo aiuto non ci si può
mettere a indagare le forme della condizione umana (indagine che per sua natura può
e deve compiersi solo nel dialogo, ovvero con l’assunto, dichiarato o tacito, ma sempre assiomatico, di un’alternativa).
Odo Marquard, il filosofo tedesco rappresentante della scuola neoscettica, tra il
serio e il faceto fa derivare il termine tedesco per «dubbio» (Zweifel) dalla parola che significa «due» (zwei in tedesco) e dice quanto segue: «Se – in riferimento al testo sacro – due interpreti
affermano in contrasto fra loro: ‘Io ho ragione, la mia comprensione del testo è la
verità, la verità indispensabile alla salvezza, questa e non un’altra’, si può arrivare
allo scontro violento. [...] Si può comprendere questo testo anche diversamente e
– se ciò non basta – ancora diversamente e ancora una volta diversamente?».
L’«ermeneutica della pluralizzazione», che Marquard tanto per cambiare rivendica,
muta il rapporto basato su un «caparbio insistere sulla propria ragione» in un «confronto
interpretativo». Ciò equivale, secondo il parere di Marquard a favore del quale anch’io
propenderei, a sostituire l’«essere per uccidere» con l’essere per il testo... Non ci sarà allora posto per il grido, ricordato da padre Ziba e attribuito sia all’abate Arnaldo Almarico di Cîteaux sia a Simone di Montfort:
«Caedite eos! Novit enim Dominus, qui sunt eius» («Uccideteli tutti! Dio riconoscerà i suoi»)...
S.O. Parliamo allora del pluralismo nella religione. Citi l’«ermeneutica della
pluralizzazione» che Odo Marquard auspica nell’approccio ai testi sacri, o meglio
ai testi riconosciuti come sacri. Questo appello mi è assai congeniale e con una certa
– peraltro gradita – sorpresa da alcuni anni scorgo questo approccio nelle opere degli
esegeti di quegli scritti. D’altronde, forse, in fondo neanche nelle cosiddette religioni
monoteistiche ci si è mai dimenticati del substrato pluralistico dei testi biblici,
che anzi arrivava a farsi sentire in diverse forme. Forse soprattutto nel cristianesimo,
in particolare nelle sue versioni ortodossa e cattolica. Perché infatti le chiese
protestanti, contrapponendosi proprio all’offuscarsi della purezza del monoteismo
(così in ogni caso lo intendevano), combattevano il culto dei santi, delle immagini
sacre e di forme simili di ritorno al pluralismo, e talvolta addirittura al politeismo,
«perduto». E, d’altra parte, non è forse vero che i santi locali sono spesso più importanti
di Dio o di Gesù? E le evolutissime forme del culto mariano non sono forse da tempo
sfuggite al controllo dei guardiani della purezza monoteistica? La peculiare «legalizzazione»
dei santuari e delle immagini della Madre di Dio per me è espressione più di una rinuncia
a vigilare sulla «purezza monoteistica» che di un’evoluzione della religiosità cristiana.
Già, ma torniamo ai testi.
Inizierò dai biblisti ebrei, perché in un certo senso proprio il giudaismo, come tu
stesso ricordi, sembra essere il principale responsabile della riduzione della divinità
all’Uno. La questione non è però così semplice. Ecco, non foss’altro perché Yochanan
Muffs, autore di un insolito saggio dedicato nientemeno che alla «persona di Dio»,
segnala la complessità dell’Essere Divino. Questo autore mostra che il Dio della Bibbia ebraica non è solo il Motore Immobile
aristotelico, ma in ogni pagina del libro sacro degli Ebrei si manifesta come un Assoluto
vivo, dotato di sensibilità. Per dirla in breve, l’immagine di Dio che emerge dalle
analisi di Muffs è tanto sorprendente quanto fondata su un’analisi precisa del testo
biblico oltre che sul contesto religioso in cui il testo stesso si colloca. Mi pare
che la posizione di Muffs non sia isolata. In essa si può udire la voce del giudaismo
contemporaneo radicato nell’interpretazione talmudica. È proprio una penetrante e
laboriosa lettura della Bibbia ebraica a svelare il tragico volto di Dio. Vale la
pena citare il brano in cui Muffs rievoca l’epoca dei suoi studi a beneficio dei lettori:
«Come ci insegnava Saul Lieberman [...] la figura più tragica nella Bibbia non è né
Giacobbe, né Saul, e nemmeno Giobbe, ma lo stesso Dio, che è incessantemente lacerato
fra il suo amore per Israele e una profonda disperazione, la cui fonte è costituita
dal popolo prediletto».
Si tratta in sostanza di una strana concezione di Dio, e ciò sia per il credente sia
per l’ateo. Il primo si stupisce che il fondamento della sua fede possa essere percepito
in questo modo, mentre per il secondo è un’affermazione semplicemente assurda. Drammatiche,
semmai, possono essere definite le vicende umane, e ciò indipendentemente dal fatto
che le riconduciamo a un Essere Trascendente o che ci accontentiamo di spiegazioni
contingenti. Per me la concezione di Muffs, profondo conoscitore delle religioni mediorientali,
è quella che più colpisce nel segno sul tema di Dio. Essa diventa comprensibile se
prendiamo atto che nella Bibbia non solo l’uomo fa dipendere il proprio comportamento
da Dio, ma anche Dio – il Creatore dell’uomo – fa dipendere la riuscita dei suoi propositi
dal comportamento dell’uomo. Dice Muffs: «Mentre il Dio dell’agape è umano nella sua preoccupazione per l’uomo, Egli non è umano nella sua indipendenza.
D’altra parte, il Dio legislatore è molto umano – troppo umano – nel suo desiderio
che venga osservata la legge, nella sua frustrazione e nella sua ira quando non viene
osservata, nonché nella sua propensione a consentire ai mortali di mitigare la sua
collera affinché non si giunga alla distruzione del mondo». Qui mi viene in mente la nota tradizione talmudica che l’esistenza del mondo dipenda
dall’esistenza di trentasei giusti. Così dunque l’uomo decide del futuro del mondo
tanto quanto Dio.
Questo motivo della reciproca dipendenza del Creatore e del creato era presente nella
riflessione teologica ebraica fin dalle più antiche tradizioni orali, foss’anche solo
nelle cosiddette Massime dei Padri (Pirqè Avot) dove si parla soprattutto dell’uomo. Per evitare di apparire uno che parla senza
fondamento, cito alcune massime, le più famose, attribuite a Hillel il Vecchio, forse
uno dei maestri spirituali di Gesù di Nazareth. Ed ecco cosa diceva Hillel: «Non fare
al tuo prossimo ciò che non vorresti fosse fatto a te», e aggiungeva: «Ama la pace
e persegui la pace, ama gli uomini e falli accostare alla sapienza». Se queste sono
le più importanti prescrizioni del giudaismo, da dove derivano le accuse secondo cui
il monoteismo ebraico rappresenta una fonte di alienazione, di fondamentalismo, di
ostilità verso gli altri? Sono ben lungi dal non scorgere questi indizi della religiosità
ebraica nell’Israele di oggi, e tuttavia in essi si vede non tanto la misura della
fedeltà alla tradizione, quanto piuttosto il grado della sua falsificazione.
Mi esprimo in modo così duro perché a ciò mi incoraggia il pensiero, cui mi sento
vicino, di Abraham J. Heschel, il quale ha basato tutto il suo sistema teologico sull’idea
di «Dio che cerca l’uomo». L’idea di Dio che ha bisogno dell’uomo, per quanto paradossale, trova conferma nel
concetto dell’alleanza, centrale per la Bibbia. Serviamoci ancora una volta di una
citazione dal saggio di Muffs: «L’impegno di Dio si manifesta nello stringere l’alleanza
con Israele. In una certa misura, l’uomo è consocio di Dio nella creazione di un mondo
morale». Si vorrebbe dire che questo per Dio non era ovvio fin dal principio. Solo la storia
comune ha svelato a Dio il vero carattere dell’uomo – un essere debole, e tuttavia
necessario per la costruzione del mondo.
Difficile trovare in una simile concezione tracce di un carattere moralizzante della
religione o della fede in Dio. Qui si tratta piuttosto di una forma di incontro e
di dialogo in cui i partner si studiano a vicenda, e soprattutto rispettano i propri
limiti e la propria diversità. Dio non si aspetta dall’uomo una nobiltà morale, anzi
è piuttosto incline a una sempre maggiore indulgenza, che in linguaggio biblico si
è soliti chiamare misericordia. Così, in ogni caso, ci insegna Muffs, che citerò qui
per l’ultima volta (ma ne vale la pena):
Probabilmente Dio si rese conto che, avendo sbagliato ad aspettarsi l’impossibile
dall’uomo e poi a punirlo [per aver disatteso quelle aspettative], avrebbe fatto cosa
più ragionevole a provare maggior simpatia per gli errori umani. [...] Sono disposto
a sopportare un’umanità peccatrice, dice Dio, a lasciare spazio alla debolezza dell’uomo,
dal momento che non posso avere la botte piena e la moglie ubriaca: non posso avere
un essere libero dal peccato che sia al tempo stesso un uomo. Meglio un’umanità peccatrice
piuttosto che un mondo senza uomini.
Ammetto che forse è una bella, ma isolata se non addirittura falsa, interpretazione
della Bibbia ebraica. In soccorso di Muffs però arriva un altro studioso di testi
biblici, Israel Knohl dell’Università Ebraica di Gerusalemme, in un suo libro dedicato
alla «divina sinfonia» con un sottotitolo che, tradotto, suona: Le molte voci della Bibbia. Ebbene, secondo lui, «i compilatori della Torah furono i primi compositori della
divina sinfonia contenuta nella Bibbia e nel giudaismo. Trasmettendoci una scala completa
delle diverse – e talvolta fra loro contrastanti – voci, ci hanno insegnato ad ascoltare
attentamente la rivelazione divina in tutta la sua ricchezza e in tutta la sua pienezza». Una voce particolarmente intrigante è legata alla rivelazione del nome di Dio a
Mosè. Riconosco che l’interpretazione di Knohl suona enigmatica, e in ogni caso fa
a pugni con un’opinione abbastanza comune circa l’essenza della religiosità ebraica.
Siamo soliti infatti collegarla con l’idea dell’eccezionalità del vincolo che unisce
Dio al suo popolo eletto. Invece per Knohl
La rivelazione del nome YHWH fu una rivoluzione teologica di tipo copernicano. Mosè,
e con lui tutto Israele, imparò a riconoscere l’essenza della divinità, che non è
legata né alla creazione, né all’uomo e ai suoi bisogni. [...] Dinanzi al sacro, l’uomo
non può più percepire se stesso come centro dell’universo, né guardare a Dio dall’angusto
punto di vista dei propri bisogni e desideri.
E se è così, chi è allora davvero questo Dio, perché credere in un simile Dio, visto
che non c’è modo di inserirlo nella mia vita? Domande del genere può porsele chi,
come me, è fuori dal giudaismo; ma poiché malgrado tutto credo, così almeno mi sembra,
nella presenza di questo Dio nel mondo, forse allora il mio agnosticismo religioso
non è privo di basi. Non sarò forse io ad aver in fondo ragione nel guardare con scetticismo
alle forme istituzionali di una religione che a quanto pare si riallaccia alla rivelazione
biblica? Knohl suggerisce, citando una delle più importanti tradizioni del giudaismo,
che Dio ha lasciato all’uomo la libertà e sta bene attento a non immischiarsi nelle
questioni umane: «La scuola di Hillel rappresenta una tendenza – la si può chiamare
razionalistica – che cerca un’autonomia per l’uomo sulla terra. ‘I cieli sono i cieli
del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell’uomo’ (Salmi 115,16). Il cielo non
può intervenire in ciò che accade sulla terra». Devo ammettere che ciò mi va molto a genio.
Rispondendo al tuo intervento temo di essere andato in una direzione che non ti aspettavi.
Poco male, però: dopotutto noi non siamo qui per risolvere nulla, piuttosto riflettiamo
su come comprendere meglio questo mondo. Forse Dio – nell’accezione tanto degli autori
biblici quanto dei commentatori ebrei – non ostacola questa comprensione. O forse,
al contrario, l’aiuta? O mi sbaglio?
Z.B. Molti gli spunti, Staszek, nella tua presentazione della questione, e ciascuno richiede un diverso approccio...
Comincerei dal fatto che la moltitudine di dèi non è lo stesso che l’incoerenza (la
molteplicità) di un unico Dio. Il Dio cristiano in effetti è trino, e per la conoscenza
che ho della storia si è versato molto sangue per conciliare la sua unicità con questo
fatto. Non sono un conoscitore della Scrittura, e riguardo alle opinioni dei suoi
commentatori sono francamente ignorante, ma per quanto ne so (come laico curioso più
che come esperto) gli esegeti hanno scoperto almeno tre figure di Dio compresenti
nell’Antico Testamento per opera dei suoi compilatori. C’è il Dio degli elohisti (che
creò il mondo e gli uomini), il Dio degli jahvisti (che condusse gli Ebrei fuori dall’Egitto
per stringere con essi un’alleanza e prendersi cura di loro) e il Dio dei sacerdoti
(autore delle prescrizioni di cui esige l’osservanza in cambio di quella cura). I
compilatori della Torah fecero il possibile per conciliare l’inconciliabile, ma forse
non vi riuscirono pienamente – le cuciture traspaiono da sotto un tessuto, nelle intenzioni,
omogeneo. Penso che ne fossero consapevoli e che il divieto di «farsi alcuna immagine»
fosse da parte loro una prescrizione preventiva o una sorta di polizza assicurativa
contro gli entusiasti della logica con i suoi principi di non contraddizione e del
terzo escluso.
Il riconoscimento della sostanziale incoerenza del Dio unico non equivale però all’accettazione
di una pluralità di dèi. Il primo può essere un imbarazzo interno al sistema di credenze
– anche se principalmente per i suoi studiosi e interpreti armati di logica, e in
minor grado per i suoi guardiani e custodi, e in misura ancora minore per gli hoi polloi, i «soldati semplici» membri della comunità. La seconda invece è dettata da condizioni
esterne: la presenza di concorrenti, di rivali o di oppositori che lanciano altri dèi, i quali esigono fedeltà ad altre prescrizioni di vita nonché ad altri interpreti
e guardiani dell’obbedienza. Soltanto quest’ultima circostanza pone i fedeli di fronte
alla necessità di schierarsi per una delle parti in conflitto fra monoteismo e politeismo.
Ed è proprio questa situazione, universale e sempre più vicina a casa (alla casa di
ognuno di noi!) nel nostro mondo globalizzato e diasporizzato, a essere cruciale per
le prospettive dell’umanità... Fra parentesi, proprio per questa ragione preferisco
parlare di «politeismo» piuttosto che di «polifonia» – concetto che nelle sue intenzioni
comprende già in certo qual modo un’armonia e perciò va bene per vagliare il primo
dei due problemi, ma già decisamente meno per risolvere il secondo... Questa soluzione,
detto ancora per inciso, non può spingersi tanto lontano quanto il concetto di «polifonia»
suggerirebbe, fino a un’armonia in certo qual modo organica, ossia a una solidarietà
fra melodie (cioè a una sistemazione di tutti gli dèi in un unico pantheon). Ci si
deve accontentare della tolleranza: riconoscere l’autonomia e rinunciare alla voglia
di imporre la propria verità...
Quanto al secondo tema che sollevi – la relazione fra Dio e l’uomo – devo dire che
esso ormai non mi si associa più con la questione del dilemma monoteismo/politeismo.
Nel quadro della creazione come atto divino, organicamente compreso nel sistema monoteistico,
l’uomo occupa la posizione centrale – se non come scopo della Genesi, almeno come
strumento o fattore indispensabile per condurla al suo «completamento» o al suo pieno
compimento. L’attività dell’uomo, per così dire, è un componente/complemento indispensabile
dell’opera divina. Possiamo esprimere questa interdipendenza anche nel modo seguente:
l’umano affaccendarsi laico conferisce retrospettivamente senso alla creazione divina,
fosse anche stato assente nell’originaria intenzione di Dio (cosa che non sapremo
mai, perché il Dio degli gnostici, come l’En Sof della cabala [qabbalah] ebraica – l’Infinito, l’Eterno –, fu considerato, molti secoli prima della nascita
dei «noumeni» di Kant, inconoscibile; direi che fu proprio la considerazione della
sua inconoscibilità a collocare Dio al di sopra dell’uomo e a tracciare un confine
fra il sacrum e il profanum che era bestemmia e sacrilegio varcare). Secondo la cabala, l’uomo può avvicinarsi
alle qualità di Dio solo attraverso i suoi sefirot e parsufim – prodotti e volti, e più precisamente, indizi e manifestazioni – e attraverso ciò
che da essi è capace di apprendere.
Non sono purtroppo un esperto di cabala, e nemmeno delle sue interpretazioni e critiche
talmudiche e rabbiniche (spesso in estremo contrasto fra loro). Quello che so della
cabala mi viene principalmente da Gershom Scholem, e mi affido al suo approccio, nonostante io mi renda conto che altri interpreti
(e ultimamente si sono moltiplicati a dismisura) promuovono versioni differenti, piegando
il messaggio verso le attuali mode New Age o totalmente neo-occultistiche.
Seguendo Scholem, nella cabala (e, in modo già più chiaro, nel compendio dei suoi
motivi medievali redatto da Luria, all’inizio dell’età moderna) le ricerche gnostiche
in seno alla religione monoteistica presero l’avvio proprio dai paradossi di cui il
monoteismo non può liberarsi: l’unicità di Dio a fronte dell’inaudita eterogeneità
della sua creazione e la bontà di Dio a fronte del disordine morale del mondo da Lui
creato. In un certo senso proprio da questi paradossi (o piuttosto dal tentativo di
districarli e risolverli) ha avuto origine il mito del peccato originale, che addossa
agli umani esiliati dal paradiso la colpa ereditaria per il tohu (caos) che aveva preso il dominio del mondo. La cabala, invece, affida alla stirpe
umana il compito del tiqqun – di riparare il mondo guasto e riportare in tal modo l’opera della creazione a conformarsi
all’intento di Dio –, e inserisce questa missione umana nel piano divino. Il mondo
divino fu guastato dall’atto del tzimtzum – il «contrarsi» di Dio, in origine identificato con l’esistenza, il suo «arretrare»,
ritirarsi da una parte dell’esistenza per fare posto alla missione umana della sua
riparazione. Da ciò consegue che, benché l’iniziativa della creazione del mondo appartenesse
completamente a Dio, la sua realizzazione comprendeva fin dal primo momento un’interdipendenza
del Creatore e delle sue creature e una loro collaborazione, cosa di cui parli tu
attingendo da altre fonti. Al contrario di quel che afferma Muffs, da te citato, Dio
non si sbagliò, sopravvalutando le possibilità e la propensione al bene degli uomini;
e non è corretto dire che le sofferenze da essi subite furono la punizione (la vendetta?!)
per non essere stati all’altezza delle aspettative divine. Al contrario, il tzimtzum, il cui correlato fu la creazione di un territorio su cui la protezione e il bene
divini non si estendevano, significava da parte di Dio un invito alla collaborazione
e l’atto di nobilitazione dell’uomo, della sua elevazione al rango di co-creatore
dell’esistenza.
Il contrarsi di Dio, come viene spiegato da Luria in modo figurato, ha mandato in
frantumi i vasi di argilla in cui si trovavano la shekhinah (la luce? lo Spirito Divino?) e le qelippot (forme tenebrose); schegge o detriti di quei vasi si sono sparsi per il mondo ponendo
gli uomini (e più in particolare il popolo di Israele, e in questo risiede il senso
della sua chiamata al ruolo di nazione eletta) dinanzi al compito di raccoglierli
e ricomporli – di far tornare le scintille e gli sprazzi di bene sparpagliati e dispersi
a ricongiungersi in una fiamma che tutto avvolga... Nella situazione della diaspora
ebraica, a cui gli autori della cabala si rivolgevano, e dalla quale essi stessi provenivano,
il tiqqun comportava la trasformazione di un esilio come punizione per i peccati in una missione
di salvezza: tirare fuori l’uomo dalla caduta e difendere il mondo dal suo essere
precipitato nella caduta...
Muffs qui è in consonanza con il messaggio della cabala: sia lui sia la cabala sostengono
che l’uomo è consocio di Dio nella creazione del mondo morale, e non un prodotto, premeditato o non premeditato, riuscito o sconsolatamente difettoso,
di quella creazione. In questo partenariato, direi, Dio è l’autorità che indica la
direzione ed esorta a mettersi in cammino; e l’uomo è colui che, avendo scelto Dio
come autorità, si guadagna l’opportunità di procedere nella direzione da Lui indicata...
Ho trovato la descrizione più efficace di questa relazione nelle riflessioni di Lévinas
sulla «tentazione della tentazione» – espressione con cui egli ha definito la tentazione
del sapere: lo stato in cui il tentato può ascoltare il canto delle sirene senza rinunciare
al ritorno a Itaca:
Il fascino esercitato da questo o quel piacere, col tentato che rischia di darsi ad
esso anima e corpo, non è ancora la tentazione della tentazione. Chi è tentato dalla
tentazione, non il piacere lo tenta, ma l’ambiguità della situazione in cui il piacere
è ancora possibile, ma l’io conserva nei suoi confronti la sua libertà, non ha rinunziato
ancora alla sua sicurezza, mantiene le sue distanze. Ci tenta la situazione stessa,
in cui l’io resta indipendente, di un’indipendenza che però non l’esclude affatto
da ciò che deve assorbirlo per esaltarlo, per perderlo; in cui l’io è, nello stesso
tempo, fuori di tutto e di tutto partecipe.
La libertà, dispiegata nello spazio fra l’esteriorità e l’interiorità, preannuncia
il rischio del male, ma al tempo stesso anche la possibilità di evitarlo. Proprio
questa, suggerisce Lévinas, è la «tentazione della tentazione»; di questo abbiamo
fame e per questo abbiamo bisogno della libertà, ossia di un’indeterminatezza talmente
vasta da contenere anche la possibilità dell’errore e della caduta. E proprio della
possibilità di salvare il mondo attraverso l’opposizione al male gli uomini hanno
il dono. Ed è questo dono a renderli consoci di Dio nella creazione di un mondo morale.
È questa creazione a non potere fare a meno dell’uomo...
II.
La minaccia del fondamentalismo,
non solo religioso
Stanisaw Obirek Le nostre rispettive interpretazioni dell’influenza delle concezioni religiose,
e specialmente del monoteismo, sulla vita dell’uomo cominciano a differenziarsi. La
cosa non mi preoccupa affatto, anzi, al contrario, mi rallegra, perché permette di
definire più precisamente questioni finora non enunciate in maniera esplicita. Così,
almeno, mi sembra. Tu, Zygmunt, dici: «Quanto al secondo tema che sollevi – la relazione
fra Dio e l’uomo – devo dire che esso ormai non mi si associa più con la questione
del dilemma monoteismo/politeismo». A me pare essenziale che ci rendiamo conto che,
malgrado le garbate rassicurazioni di Muffs e Knohl da me citati, gli eredi del Dio
monoteistico, non appena si sia presentata loro l’occasione (ne hanno avute di più
i cristiani e i musulmani degli ebrei, per questo forse nel giudaismo è una cosa più
difficilmente percepibile), hanno persuaso gli altri della propria concezione in modo
per nulla pacifico, e ciò è in relazione col modo di intendere il monoteismo. Nonostante
la fede dichiarata in un solo Dio, nella vita pratica non restavano affatto monoteisti
coerenti. Non sono esperto nei fatti della storia di Dio e non oso svolgere un quadro
così ampio come ha fatto Karen Armstrong nella sua Storia di Dio, che del resto suscita in me ammirazione e profondo rispetto, ma vorrei richiamare l’attenzione proprio sul cosiddetto lato pratico dei monoteismi,
ovvero sul vivere secondo i loro principi e quello che ne consegue.
Capisco come la tradizione ebraica della cabala riveli un modo insolitamente sottile
di connettere ciò che è divino con ciò che umano e i concetti cabalistici che tu hai
ricordato ne danno prova in maniera eccellente. Tuttavia, come sai bene, il giudaismo
istituzionale guardava alle speculazioni dei cabalisti con enorme sospetto, un atteggiamento
analogo, del resto, a quello delle Chiese cristiane riguardo agli slanci spirituali
dei mistici, e dell’establishment islamico nei confronti delle pratiche sufi. Tu citi
gli esiti delle ricerche di Gershom Scholem, e qui forse vale la pena ricordare un
suo allievo, Moshe Idel, che ha sviluppato e arricchito le conclusioni cui era giunto
il suo maestro. (Giustamente hai accennato all’erosione dei fondamenti della scienza
cabalistica nella cultura popolare contemporanea, che conduce non solo all’appiattimento
delle dimensioni più profonde del giudaismo, ma addirittura alla sua falsificazione.
Queste forme caricaturali non dovrebbero però offuscare ciò che è l’essenza della
cabala – in essa l’uomo non solo incontra Dio, ma addirittura si fonde con lui.) Se
permetti, cito dal libro di Idel alcuni pensieri che mi sembra possano ispirare particolarmente
il nostro sguardo verso quella che i pensatori russi definiscono con il termine «divinumanità».
Ebbene, Idel si accosta alla cabala in modo fenomenologico, non tralasciando però
nemmeno l’immensa tradizione ermeneutica con Paul Ricoeur in testa. Faccio riferimento
qui all’unico lavoro di Idel tradotto in polacco, Qabbalah: nuove prospettive. Non è solo un saggio di stupefacente erudizione, ma pone anche domande ponderose
sul tema dei legami più profondi tra l’esperienza religiosa e la sua trasmissione
orale e sulla questione del ruolo di quell’esperienza nelle diverse tradizioni religiose,
specialmente in quelle spuntate dall’unico tronco della fede di Abramo.
Idel riprende alcuni dei motivi citati anche in molti altri lavori che non c’è bisogno
di elencare in questa sede; non posso tuttavia non ricordare un suo saggio sui mistici
messianici, pubblicato nel 1998, in cui segue un tòpos fondamentale per il cristianesimo, quello del Messia, ma nella sua accezione ebraica. È una riflessione che ha enormi conseguenze per la comprensione cristiana del Messia
e, paradossalmente, può darsi sia proprio per questo che le sue ricerche, almeno finora,
non hanno trovato un adeguato riscontro fra i teologi cristiani. Ma torniamo alle
nuove prospettive nelle ricerche sulla cabala. Ecco come Idel tratteggia il suo proponimento:
Il mio assunto è che i temi centrali del misticismo cabbalistico siano due: l’estatico-unitivo
e il teosofico-teurgico. Se da un lato intendo concentrarmi sulla descrizione di questi
due aspetti centrali della Qabbalah, dall’altro prenderò in esame lo sviluppo storico
di questi due temi nella letteratura cabbalistica. Il mio approccio si serve dunque
della fenomenologia per isolare fenomeni significativi e solo successivamente esaminare
le possibili relazioni storiche tra di essi.
Mi sembra che la distinzione introdotta da Idel sia di importanza capitale nella descrizione
degli atteggiamenti, abbastanza eterogenei, per non dire estremamente diversi, dei
cabalisti. Da una parte osserviamo tendenze mistiche il cui scopo è in un certo senso
di «toccare» il Creatore, e dall’altra tentativi di estorcergli determinati comportamenti,
e non altri, rispetto al mondo. Entrambi questi atteggiamenti sono abbondantemente
documentati e non c’è bisogno di contrapporli l’uno all’altro; conviene piuttosto
vederli come complementari. Veniamo a sapere, per esempio, in che modo i cabalisti
raggiungevano il devekut (unione) – e quindi come riuscivano ad arrivare fino al Creatore senza perdere con
ciò la vita. In un altro capitolo Idel fa i conti con l’opinione, piuttosto radicata,
che l’unio mystica sia incompatibile con il giudaismo, mostrando in modo convincente che è proprio la
dimensione mistica di questa religione ad avvicinarla tanto al cristianesimo quanto
all’islam, se non addirittura alle religioni orientali. È interessante anche la rassegna
delle diverse tecniche mistiche, attraverso la quale comprendiamo di avere a che fare
non solo con postulati astratti, ma anche con pratiche concrete che si riscontrano
tra gli esponenti di diversi sistemi religiosi. Particolarmente intrigante è l’analisi
della teosofia cabalistica che svela i profondi legami del pensiero cristiano non
solo con lo gnosticismo, ma anche con il creazionismo ebraico. Richiamandosi alle
affermazioni di Gedaliah Stroumsa, Idel mostra come molte delle visioni di san Paolo
si possano ritrovare nello stesso giudaismo. Si tratta qui di concetti fondamentali
quali la comprensione di Cristo come Immagine di Dio (Col 1,15-17) o come Figlio dell’Uomo.
Altrettanto affascinanti sono le analisi del concetto di du-partzufim, di solito riguardante la bisessualità dell’uomo, ma, nel caso delle riflessioni
cabalistiche, riferito a Dio e al fenomeno della coincidentia oppositorum nella sua natura. Qui di nuovo si può considerare se le speculazioni dei cabalisti
non possano diventare un punto di partenza per un dialogo interreligioso il cui oggetto
potrebbero essere la concezione ebraica di Dio e la concezione cristiana della Santissima
Trinità. Mi scuso se mi sono diffuso troppo sul tema della cabala, ma mi sia di giustificazione
lo stimolo dell’interpretazione che tu dai di questo aspetto del monoteismo ebraico.
Ma qui concludo il discorso.
Mi ha colpito ultimamente la lucidità dello storico francese Paul Veyne che incidentalmente
ha buttato là una considerazione che mi sembra assai calzante. Ebbene, a suo parere,
non sono i monoteismi abramitici citati nel libro della Armstrong a meritare il nome
di monoteismo, ma la religiosità dei Greci. Ammetto che ciò mi ha fatto molto riflettere,
perché ero solito associare l’immagine della religione greca con un Olimpo affollato,
e non con la solitudine di un unico Dio. Do quindi la parola a Veyne:
[Nel paganesimo greco-romano] si tratta [...] di un monoteismo degno di questo nome,
mentre le tre grandi religioni monoteistiche, di cui si parla molto in questo momento,
meritano meno onori. Ci si sbaglia sulla loro antichità (il preteso monoteismo ebraico
fu, per lungo tempo, il culto di un dio non unico ma geloso, geloso degli altri dèi,
di quelli degli altri popoli, i quali sì esistevano ai suoi occhi e agli occhi del
suo popolo, ma, beninteso,Yahweh era più forte delle altre divinità); ci si sbaglia
sulla loro realtà (con la Trinità, i santi e la Vergine, il monoteismo cristiano è
un mero punto d’onore dei teologi); ci si sbaglia sulla loro portata (Allah è dio
unico in virtù di una superstizione gratuita come quella del politeismo; è il prodotto
del desiderio di esaltare un dio-re): no, il monoteismo non è affatto un asse cardinale
della storia delle religioni.
Il brano appena citato mi consente una piccola critica al tuo scetticismo. Sono proprio
l’impossibilità di praticare realmente il monoteismo e la sua traduzione in una moltitudine
di dèi clanici a far sì che i presunti seguaci del monoteismo combattano con tanto
accanimento coloro che non condividono le loro idee. Da qui la mia convinzione circa
lo stretto legame fra la permanenza terrena degli uomini e le loro pa
...