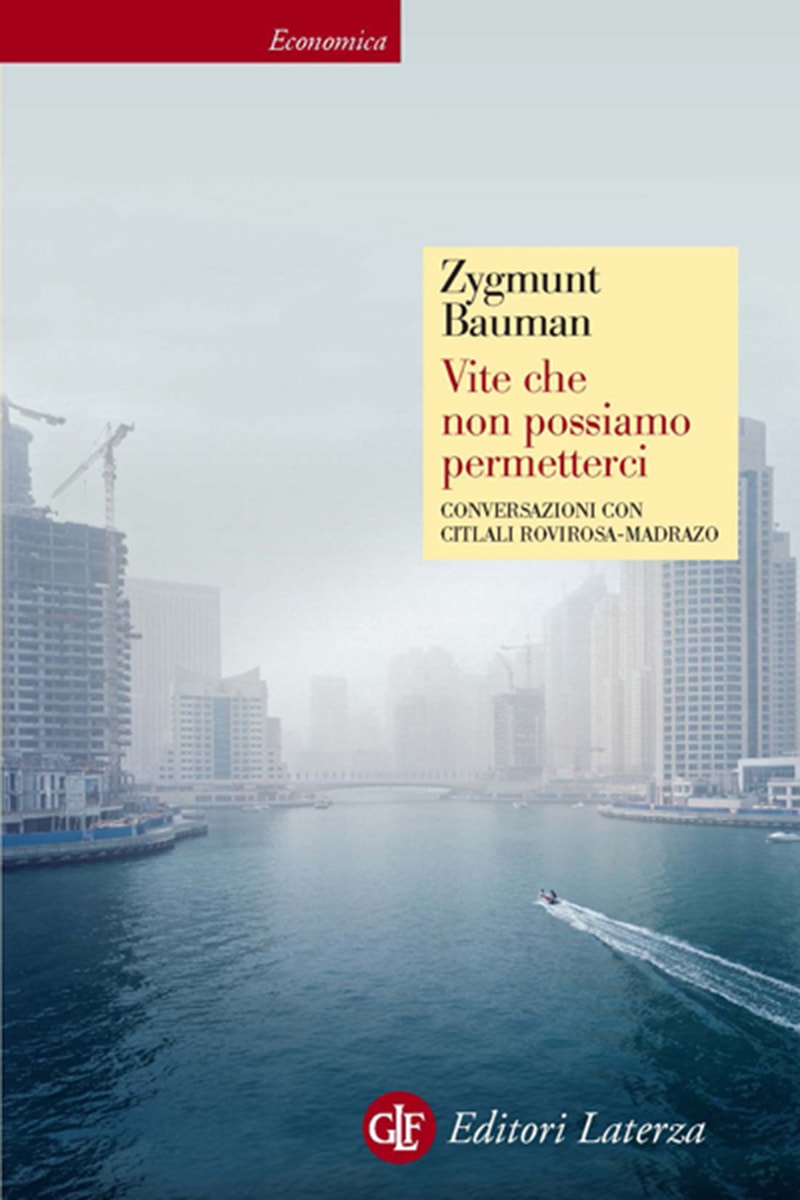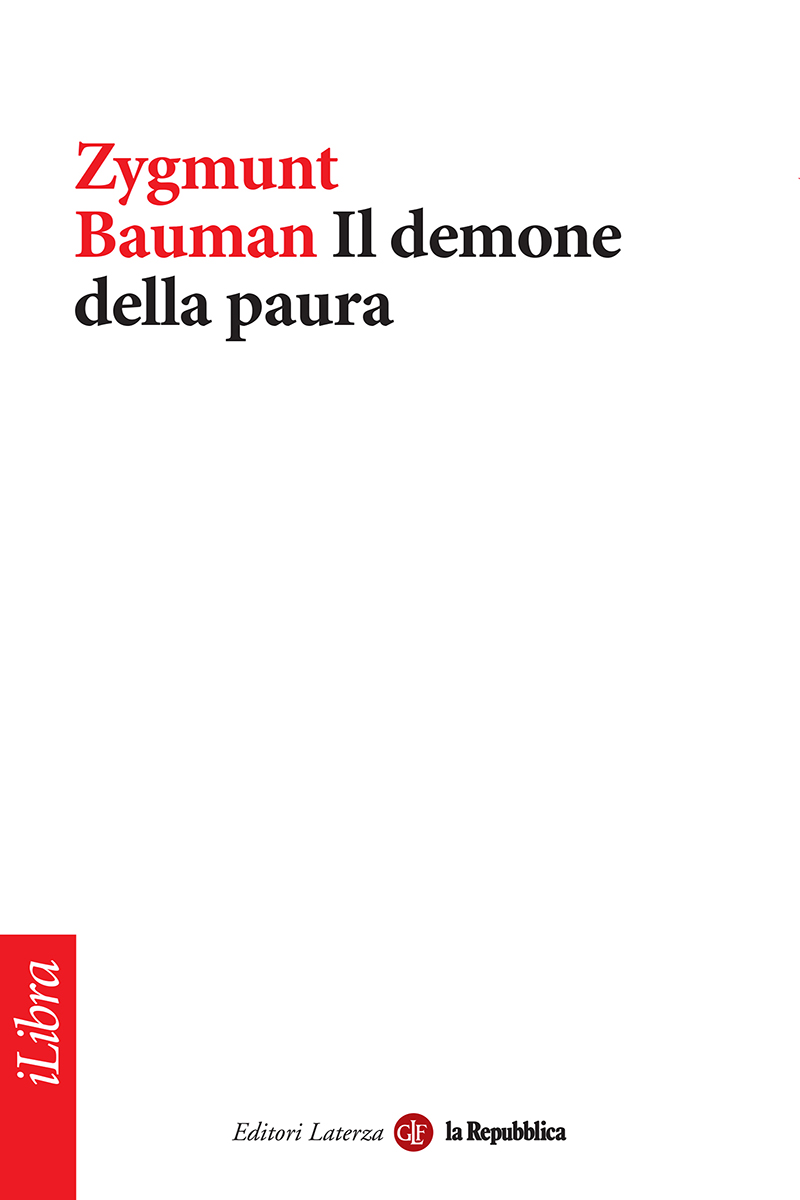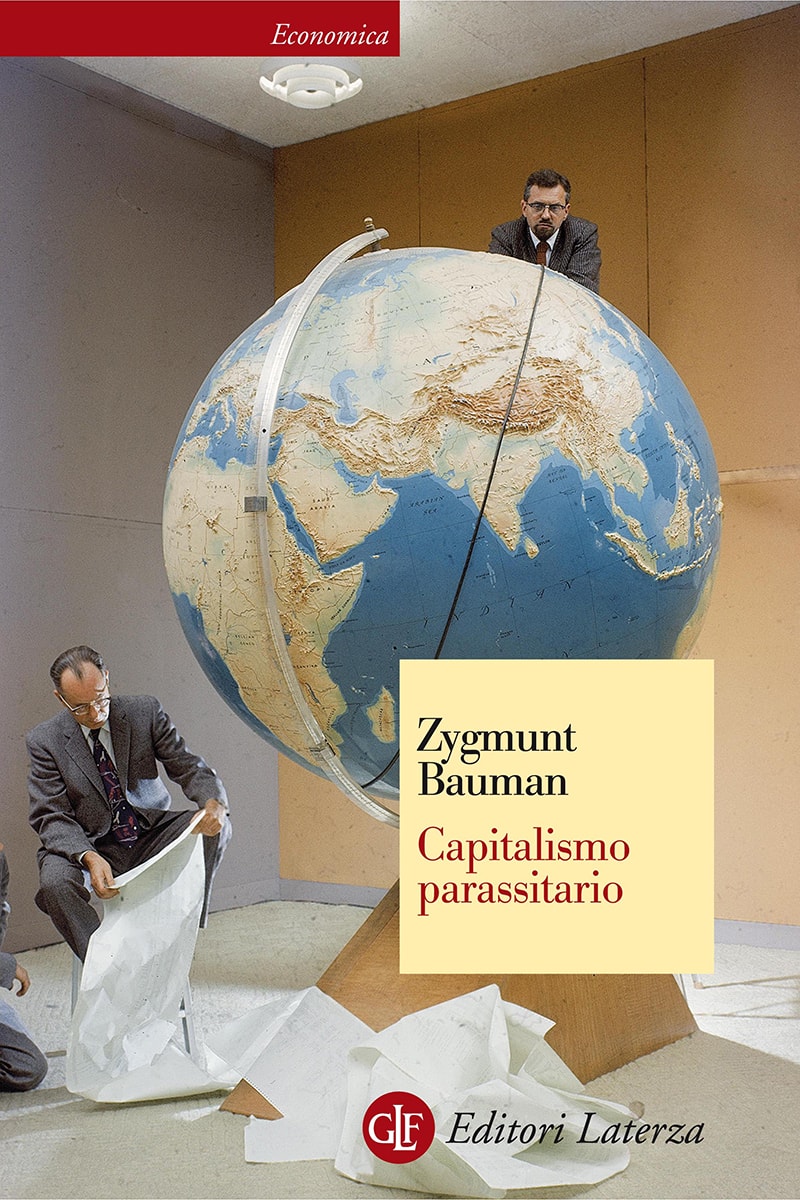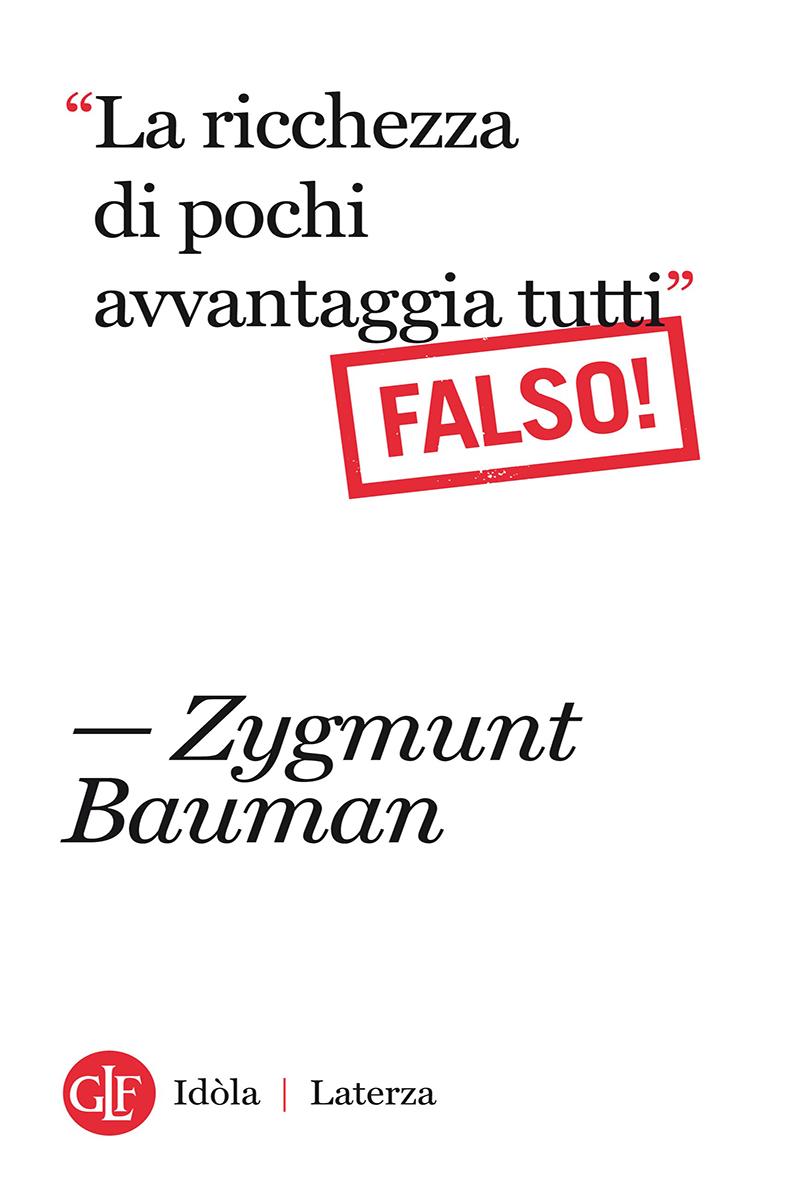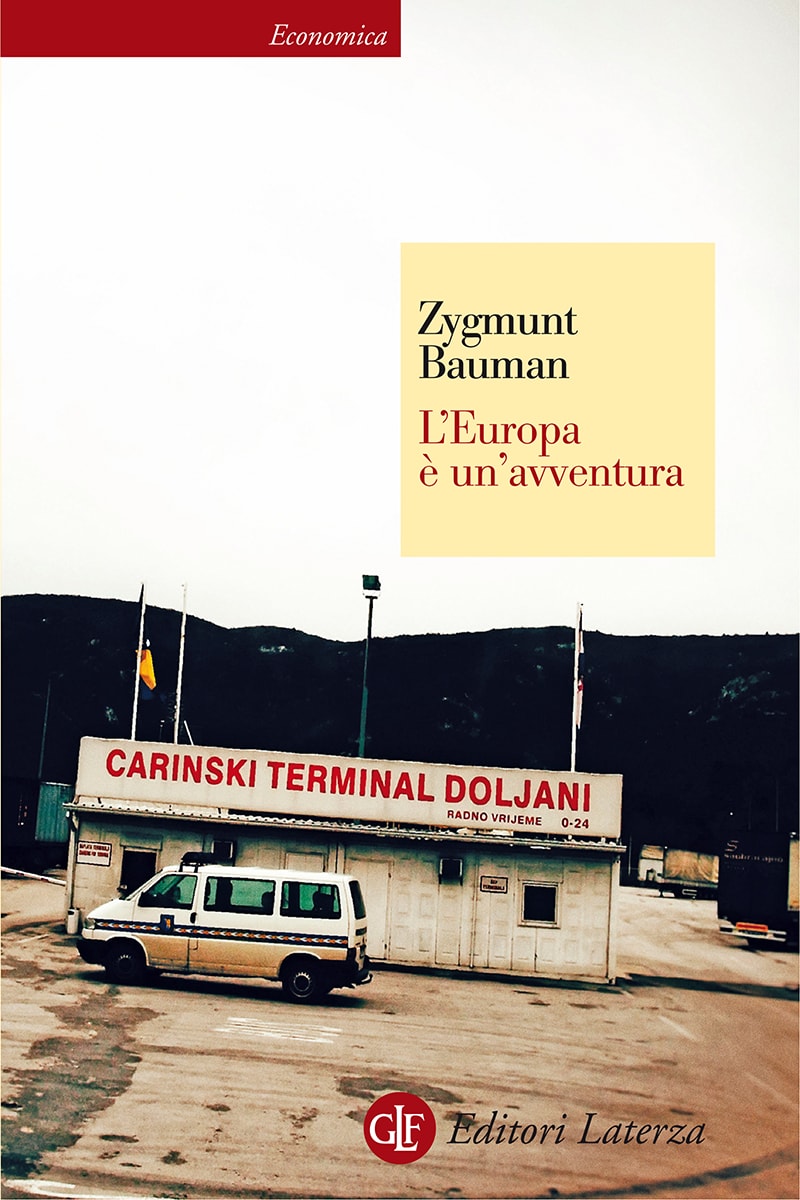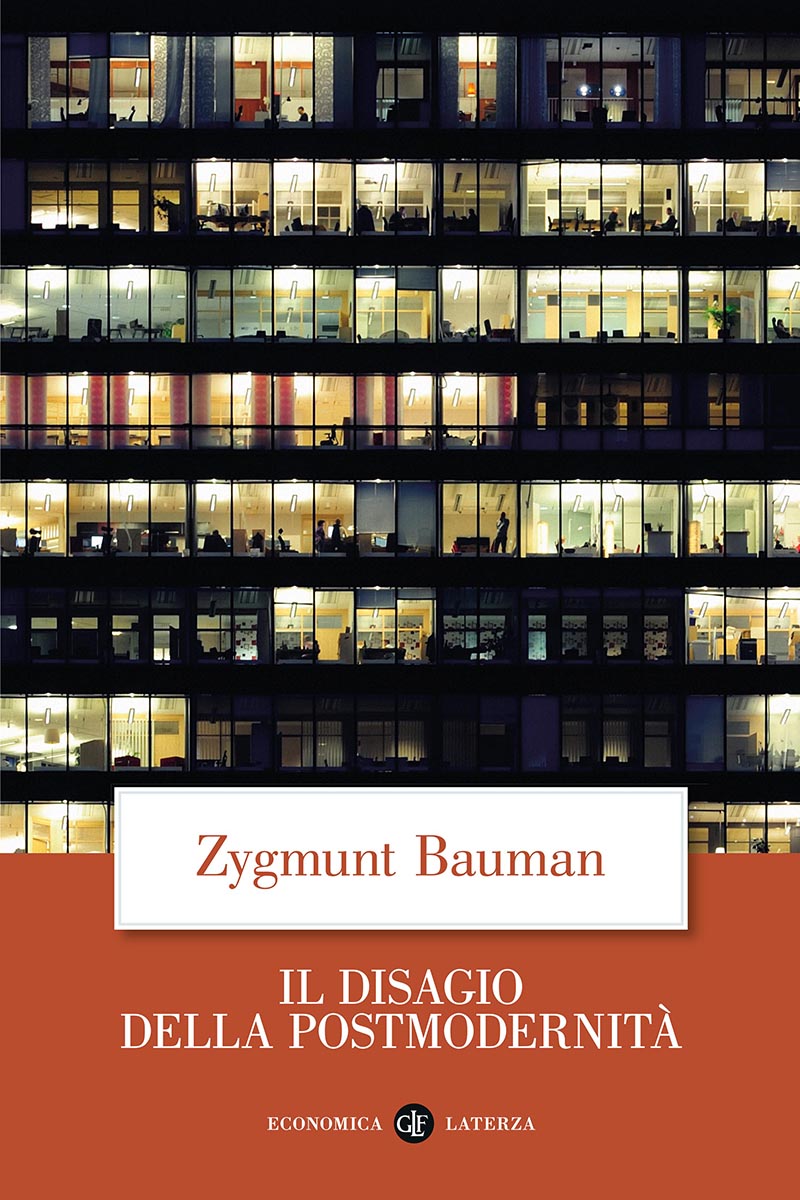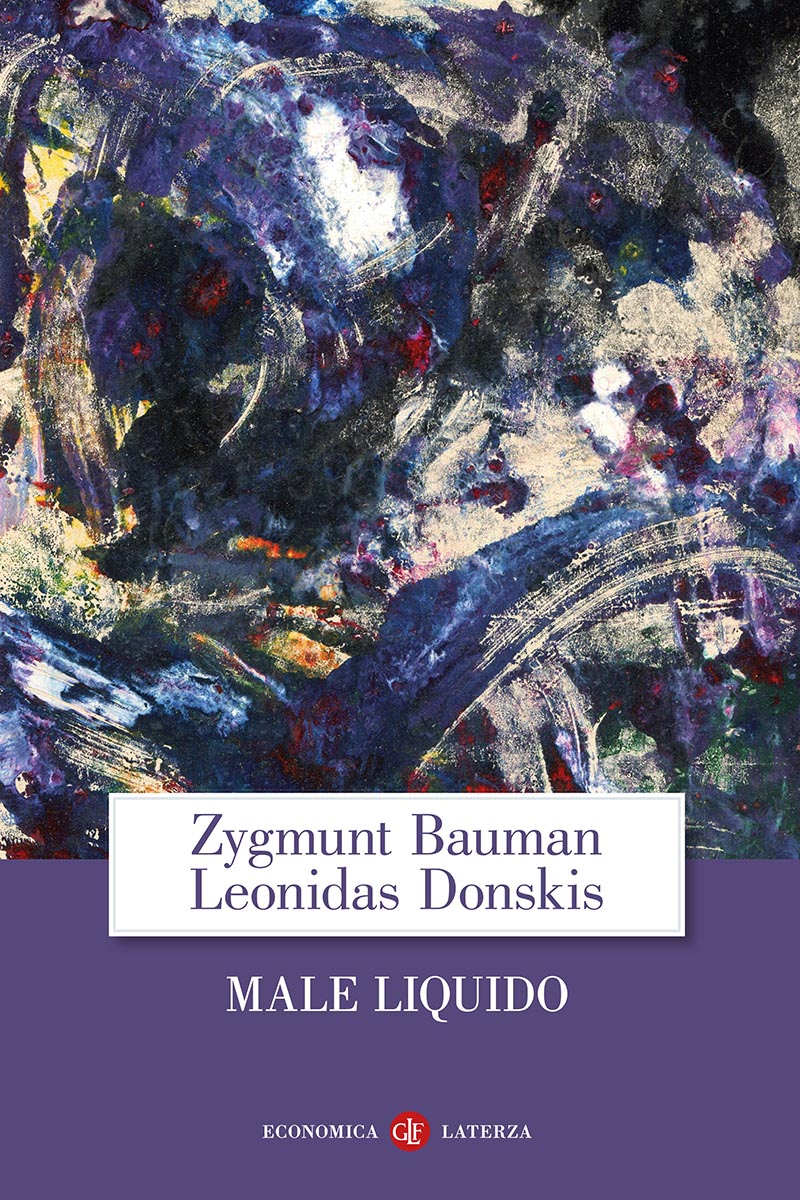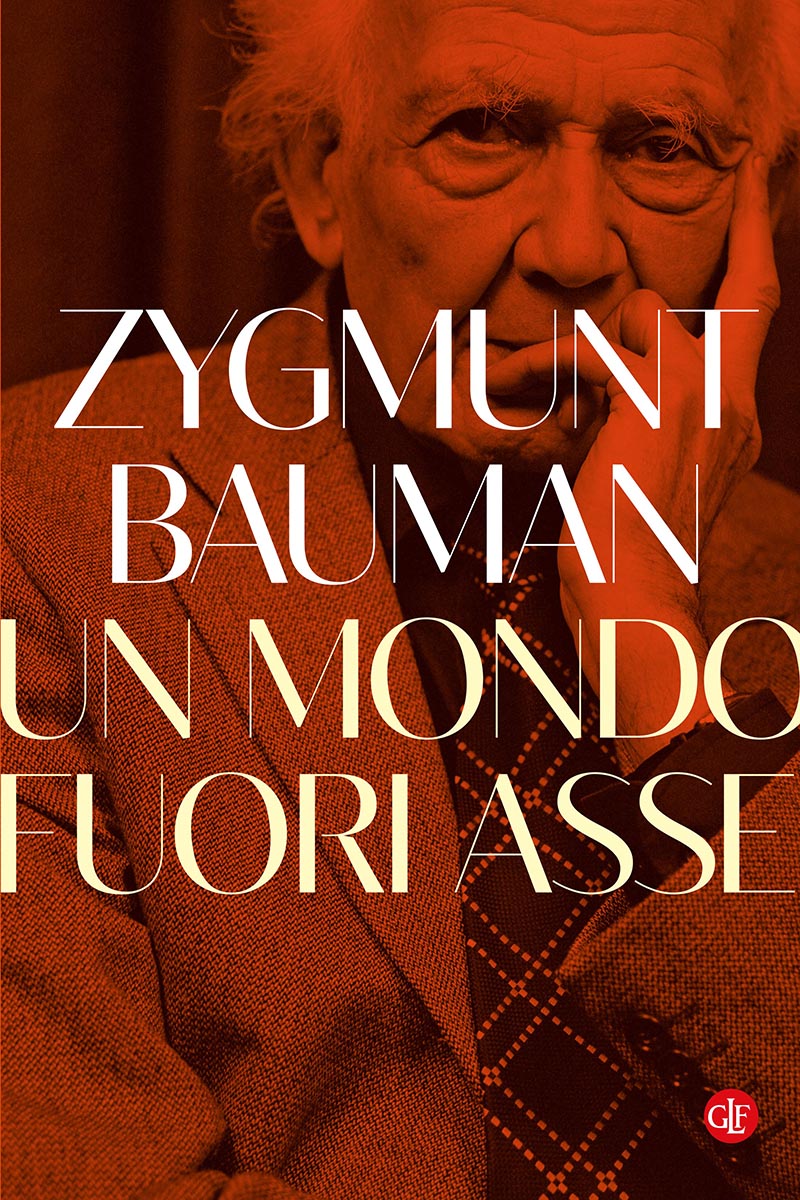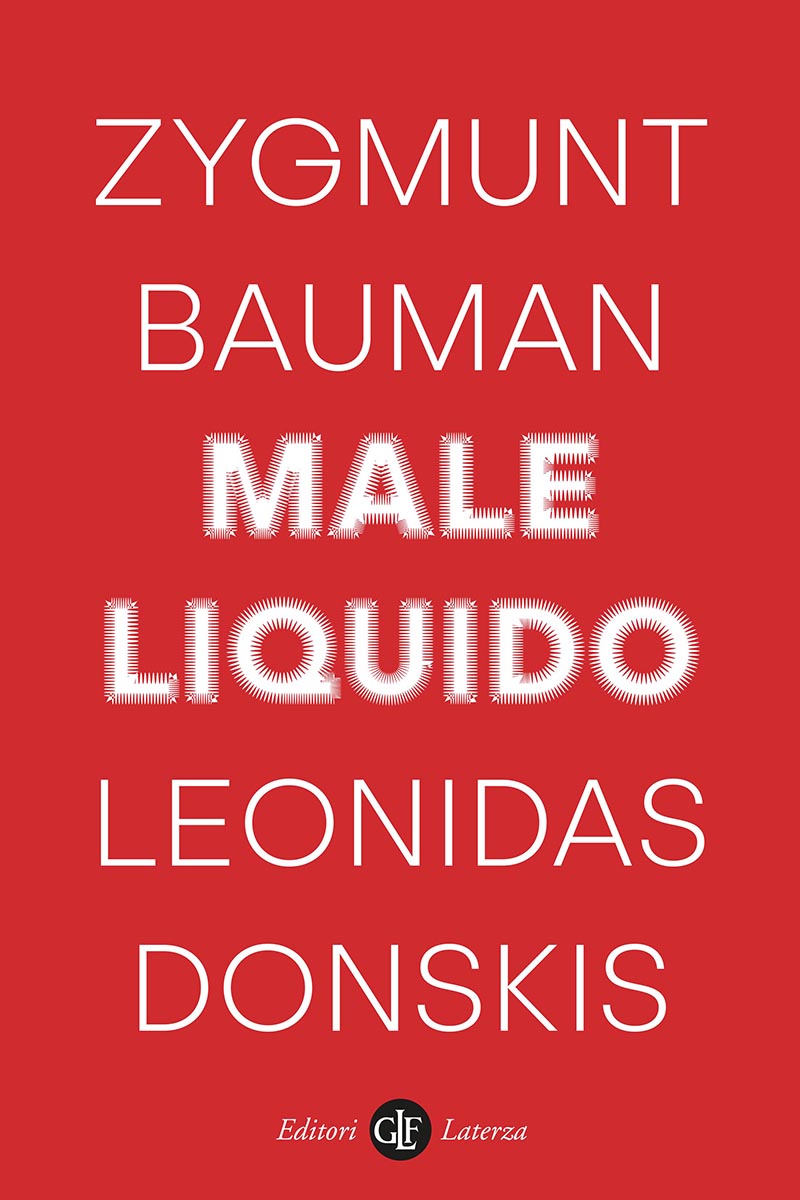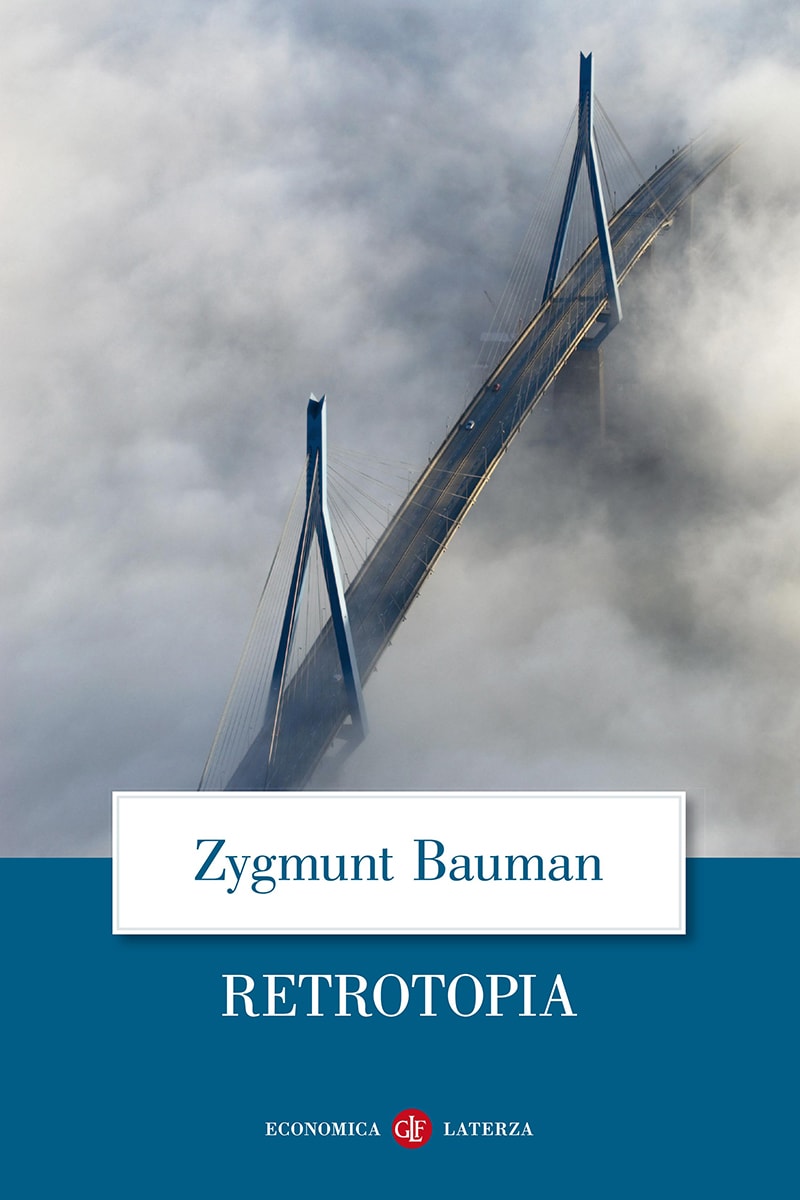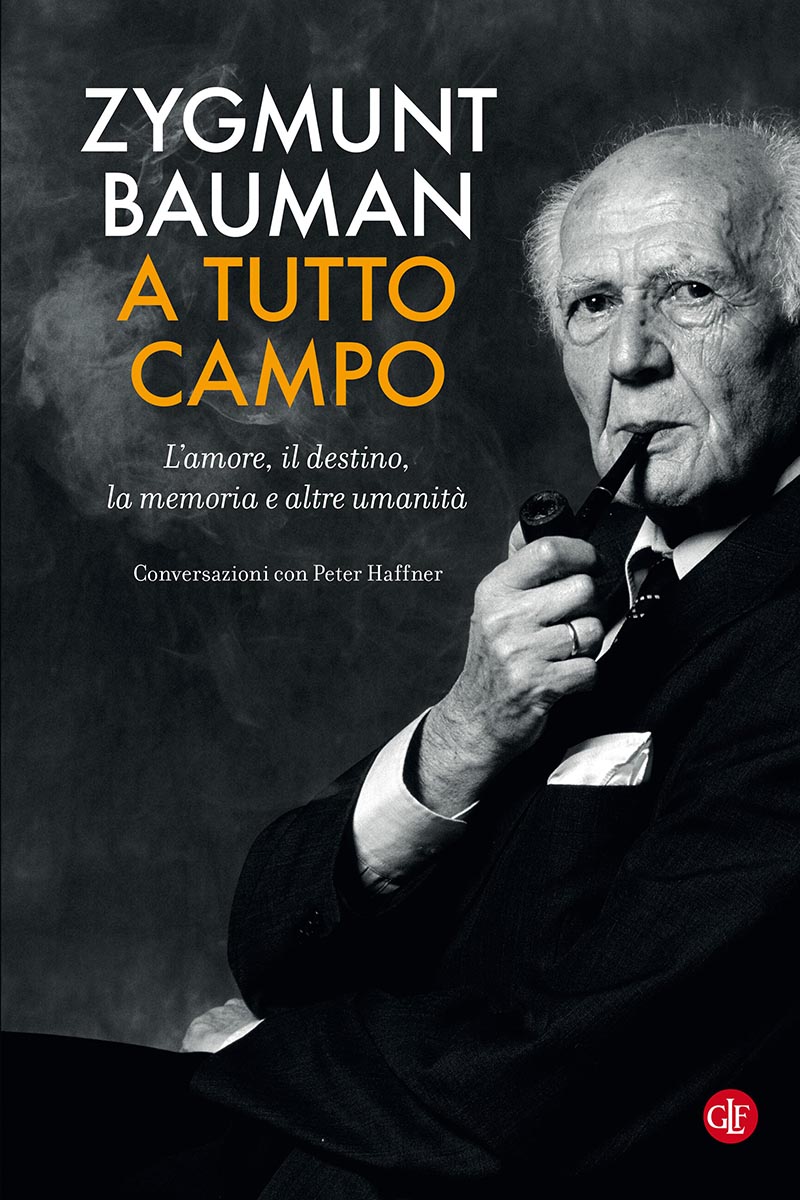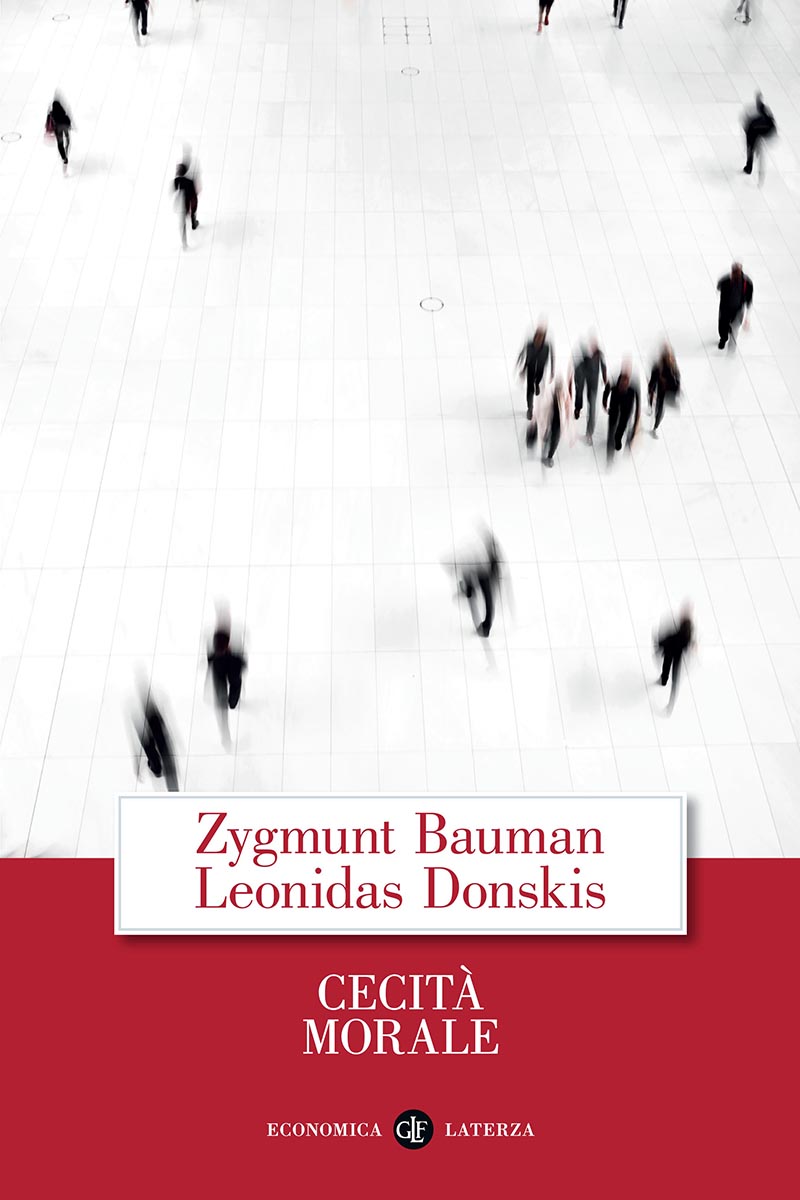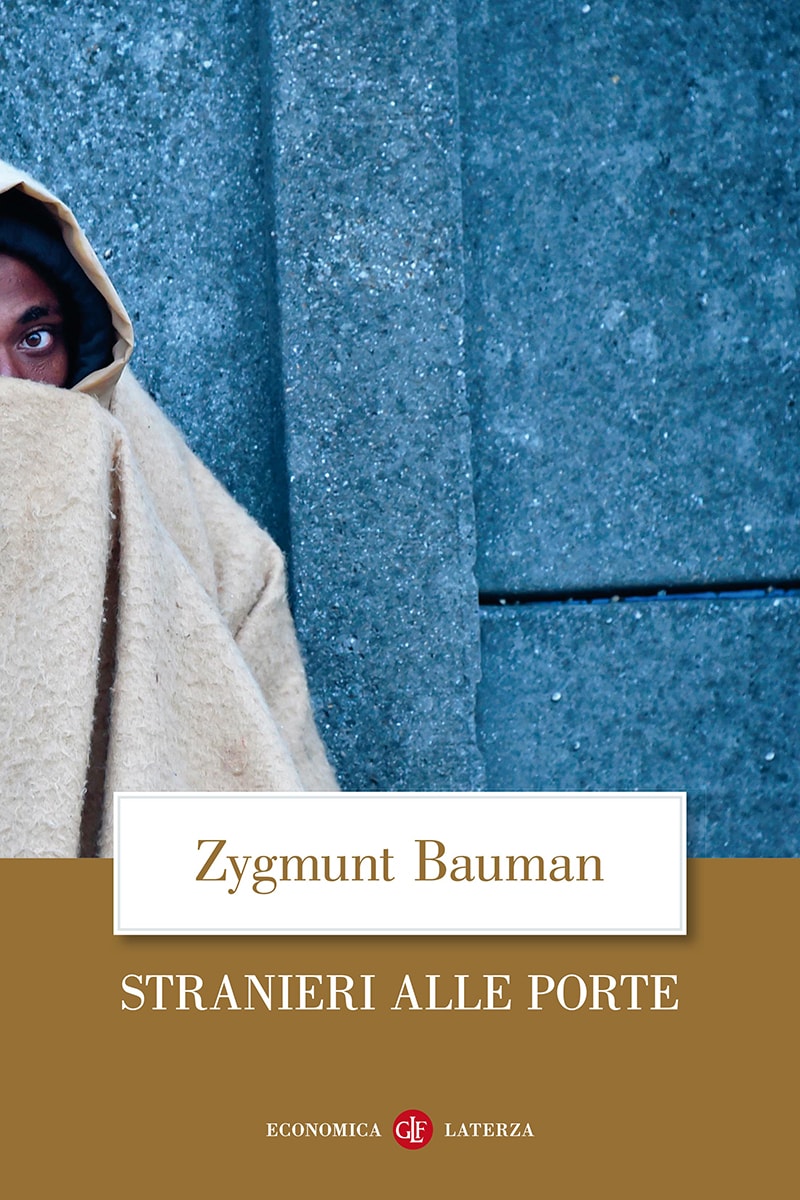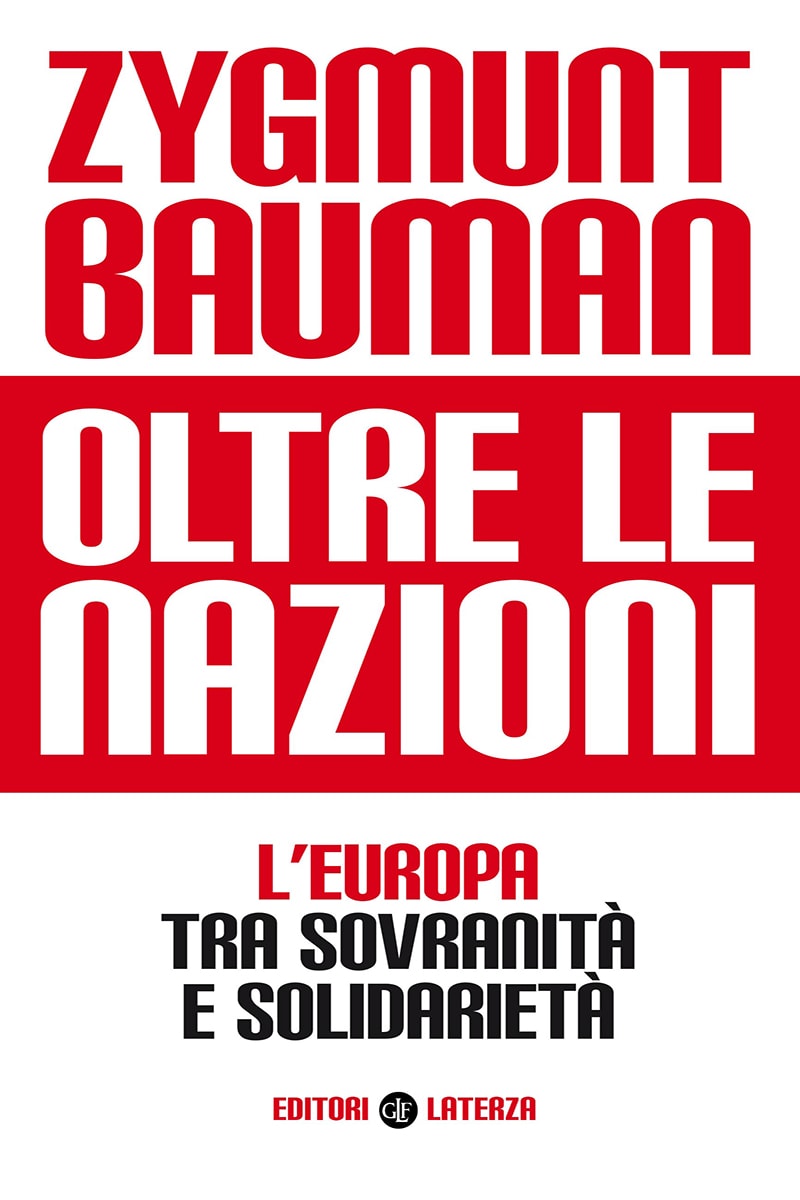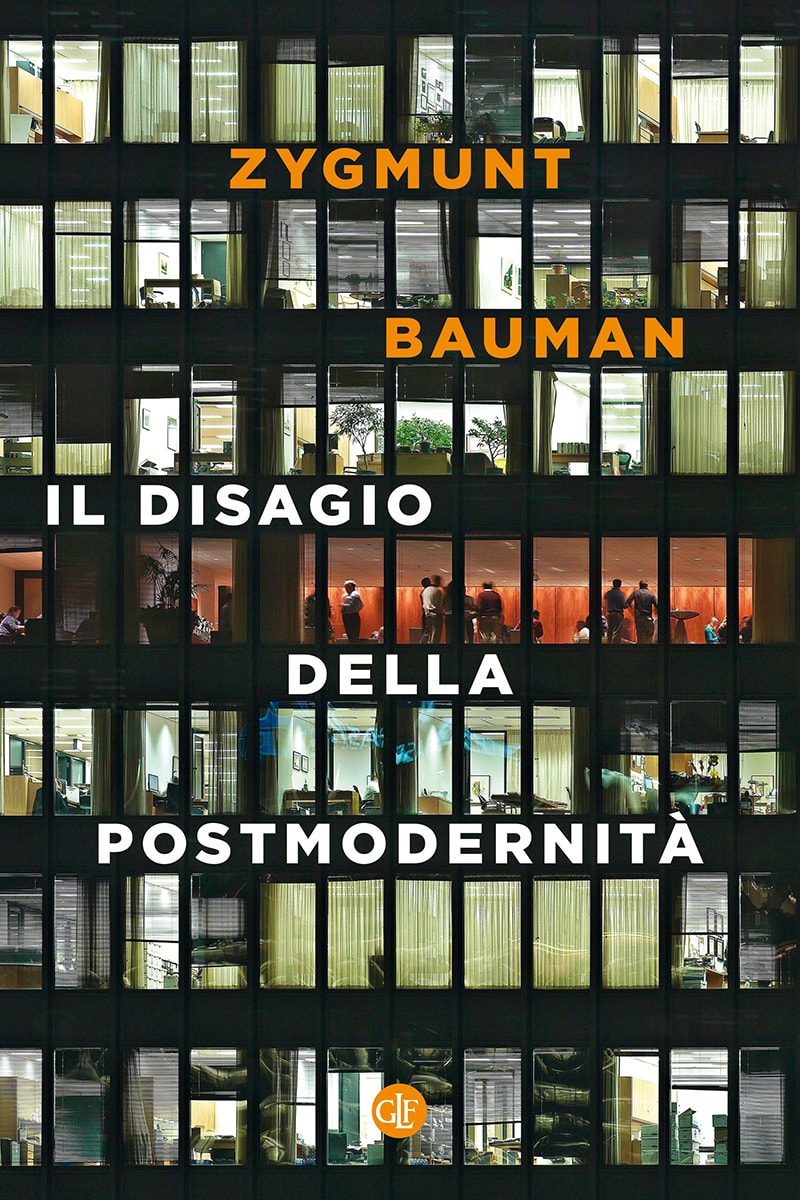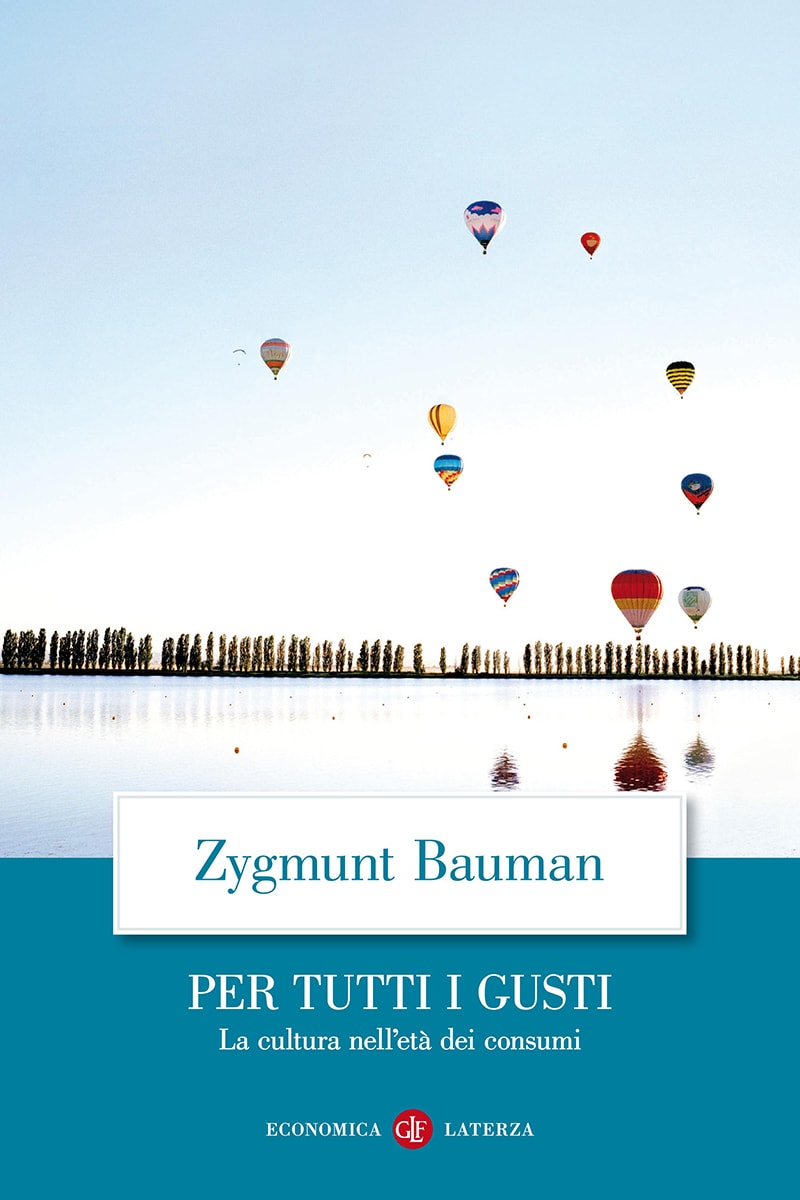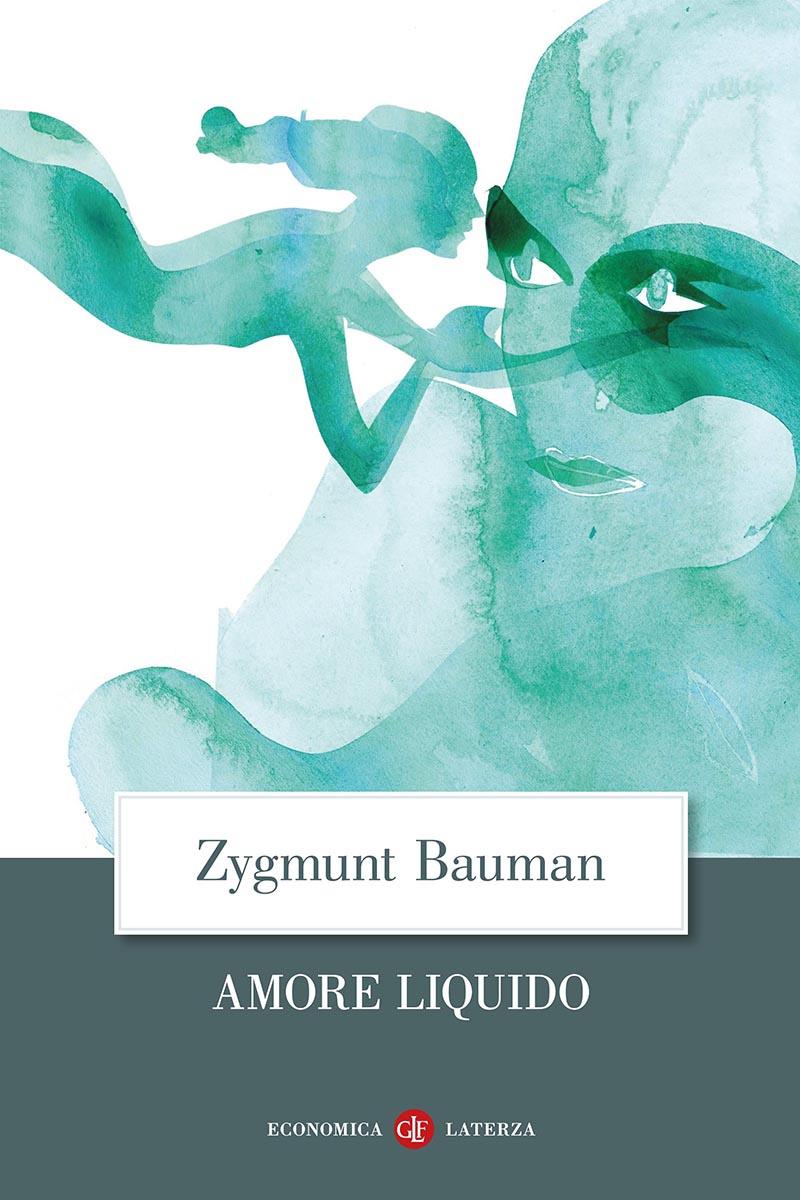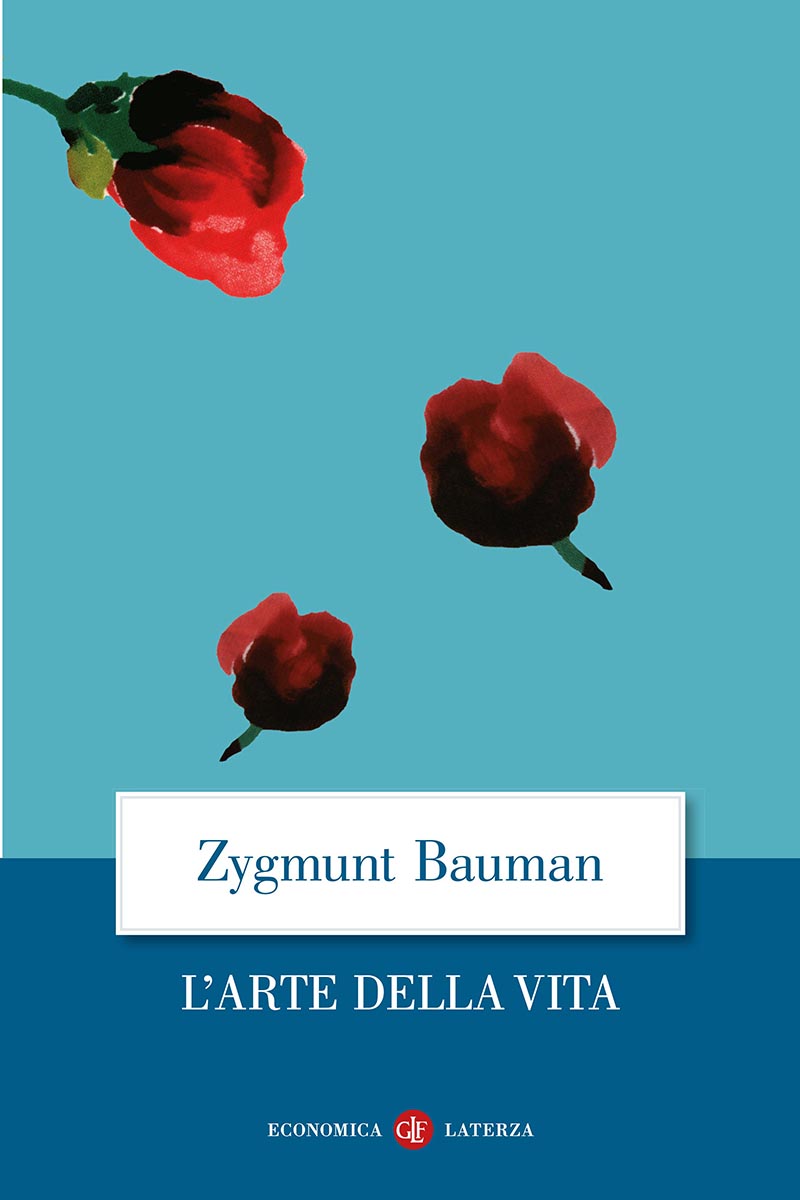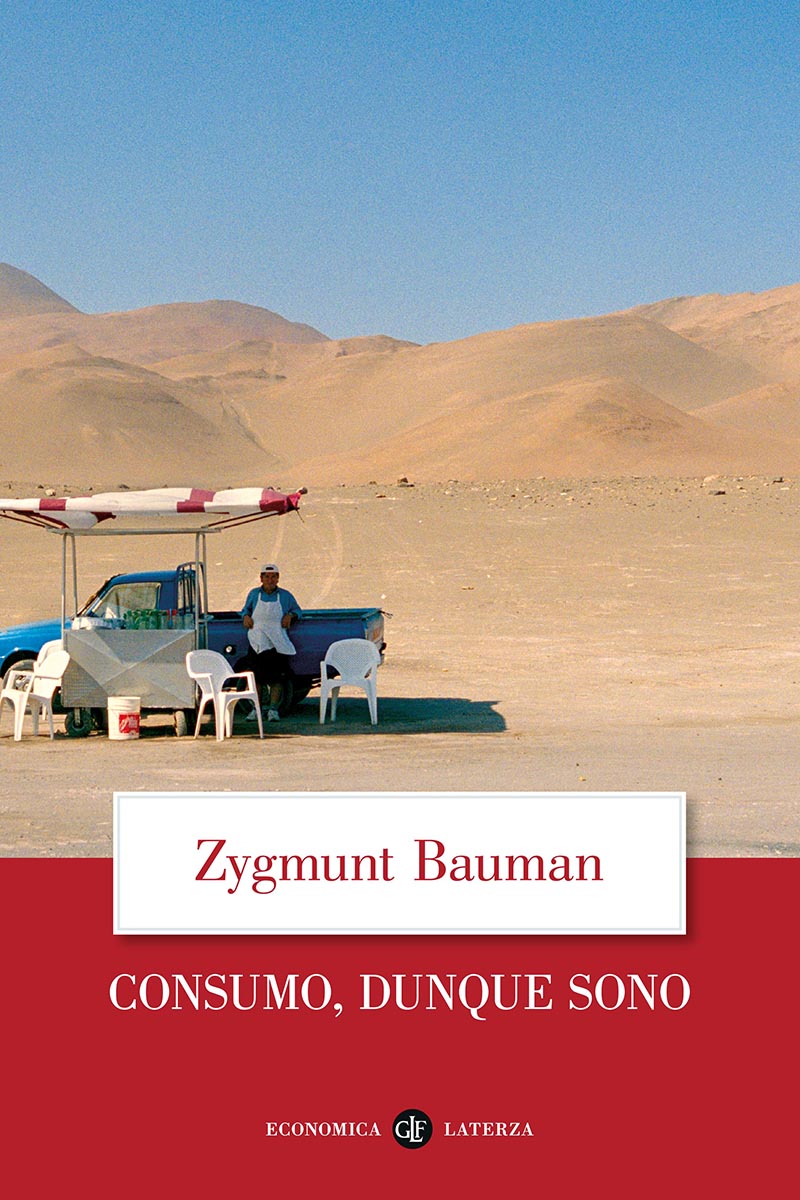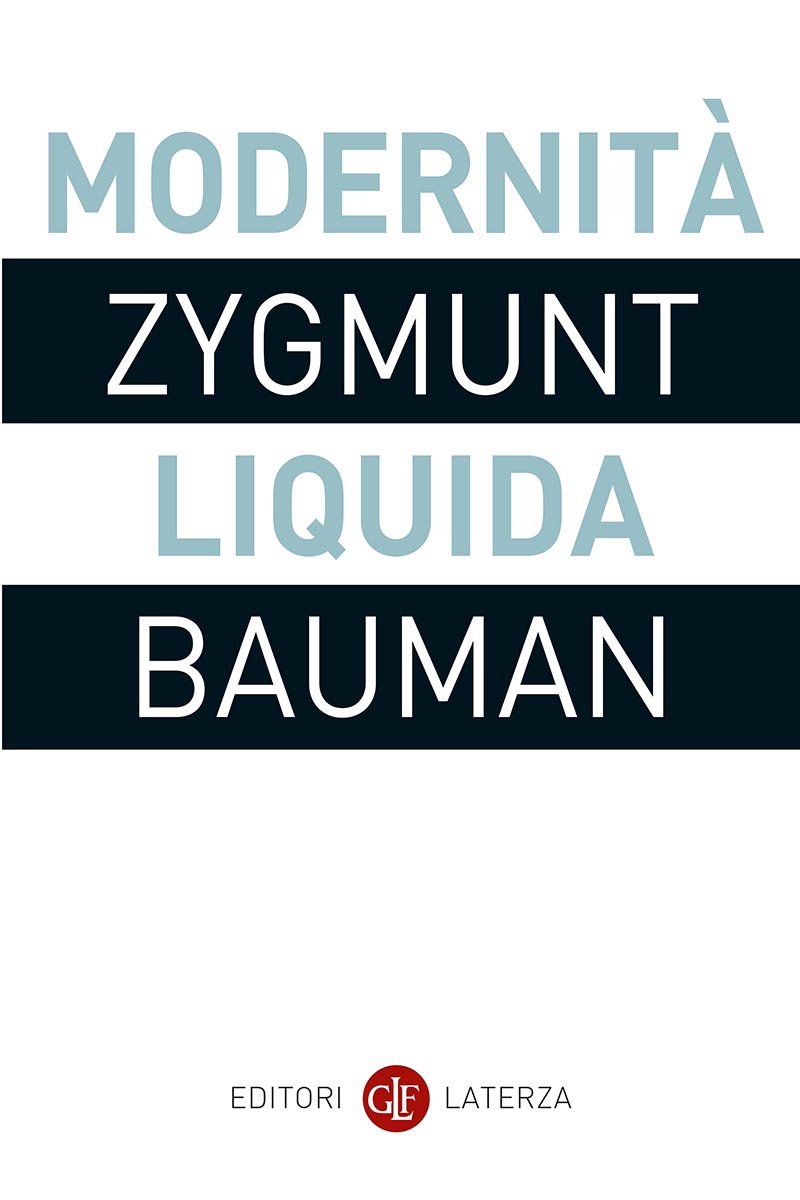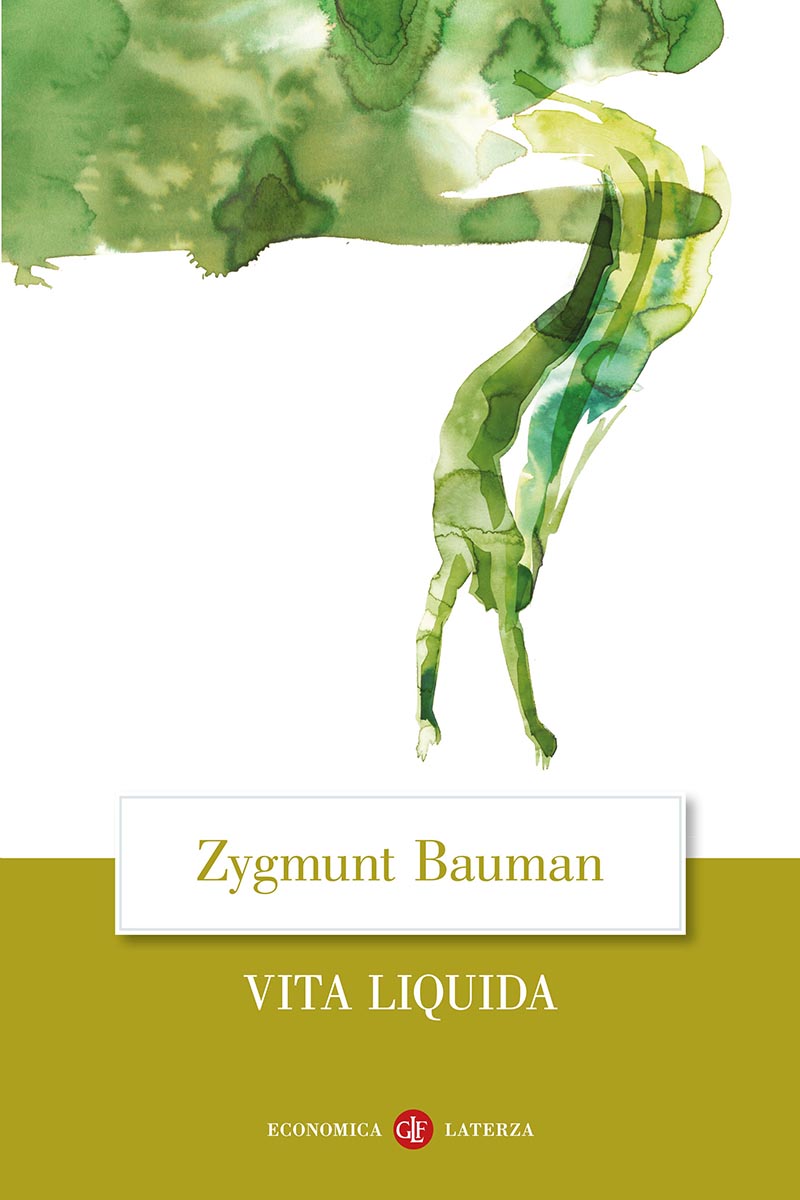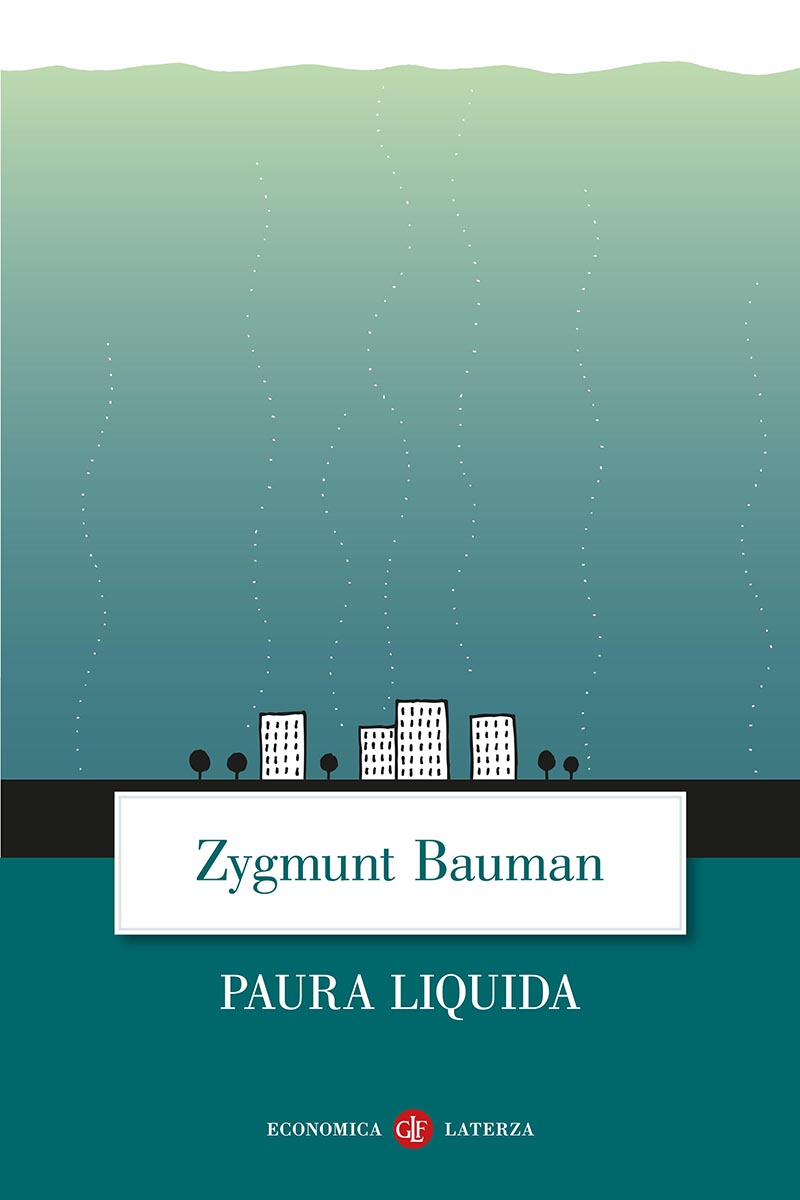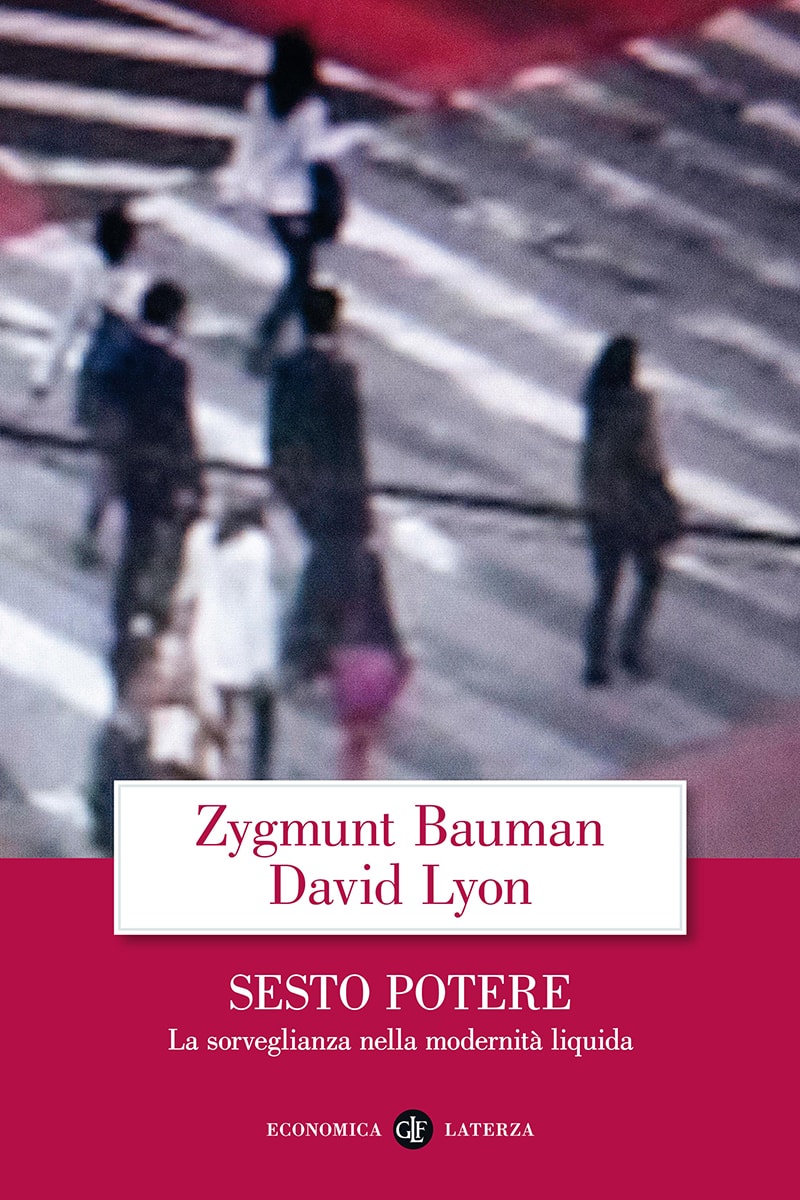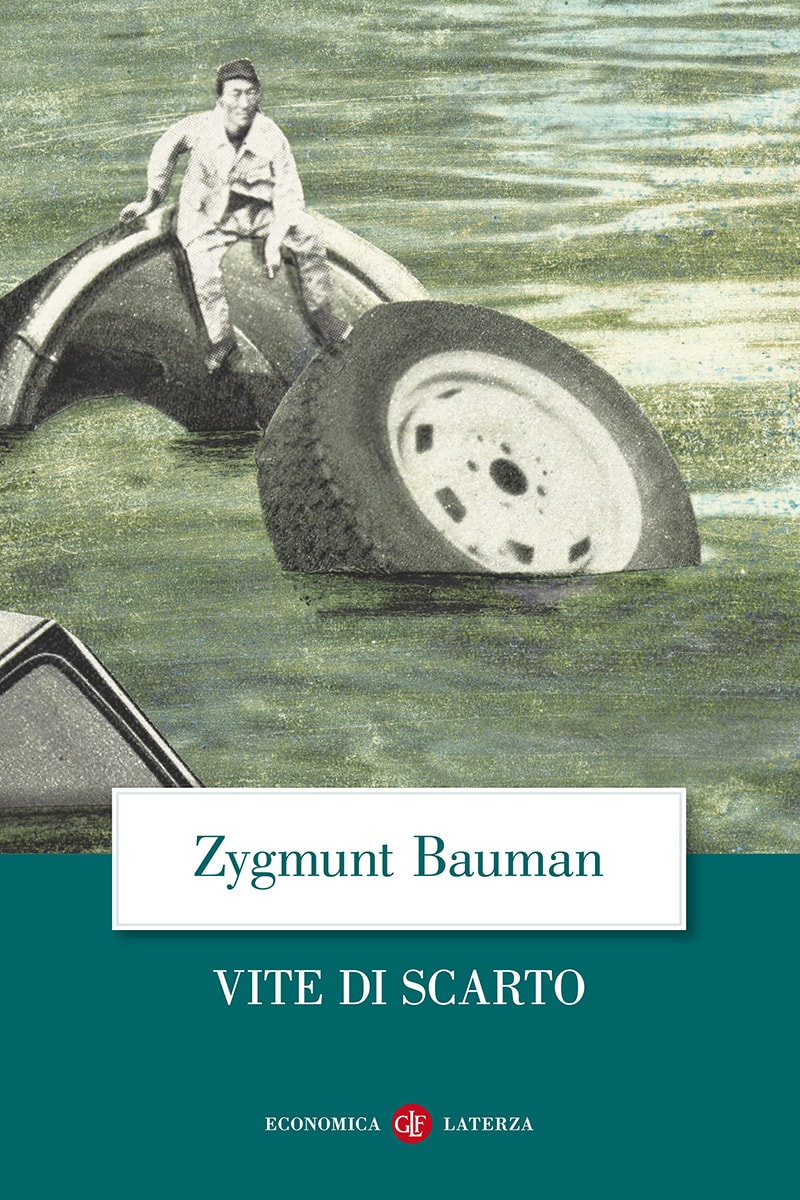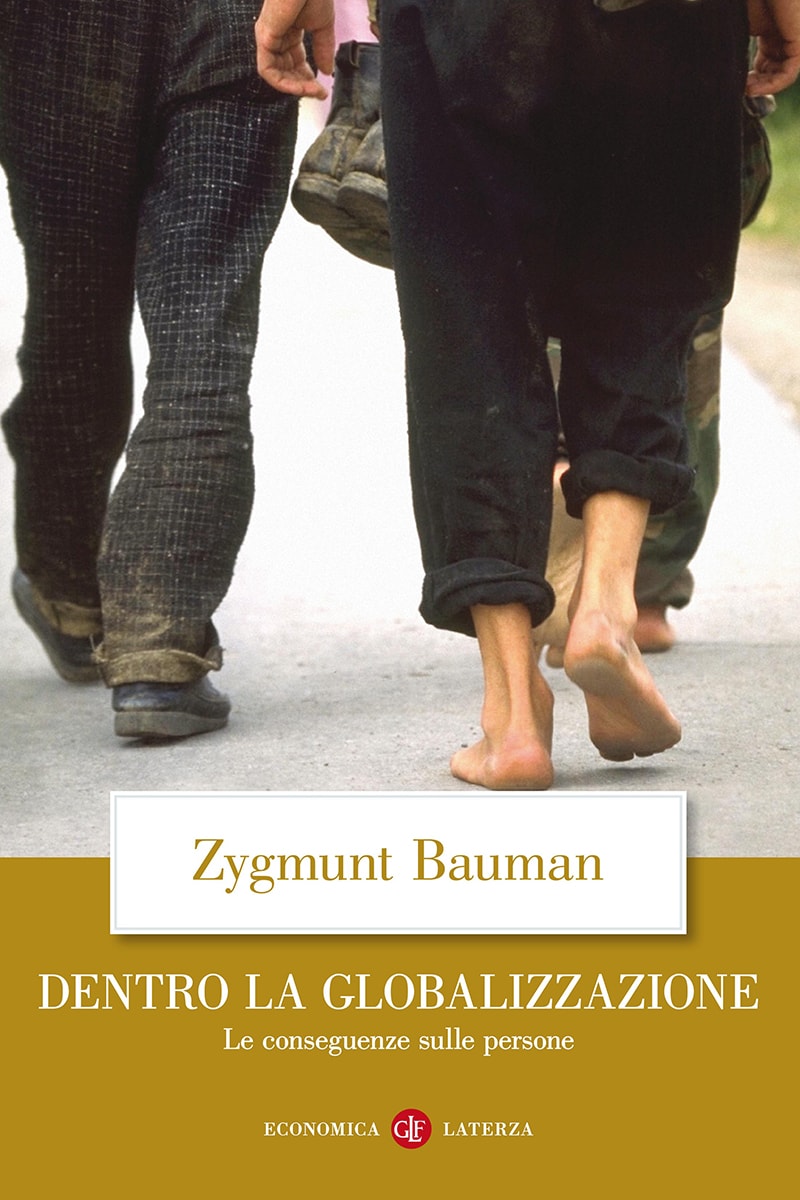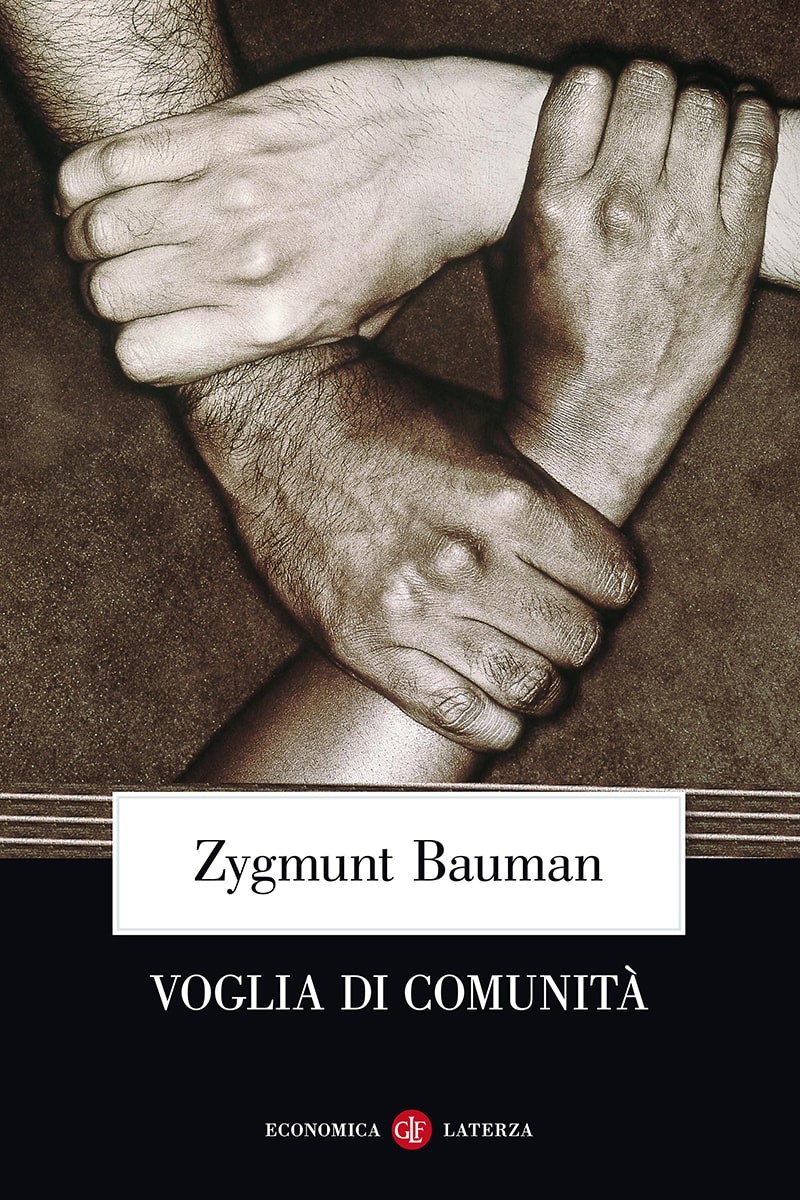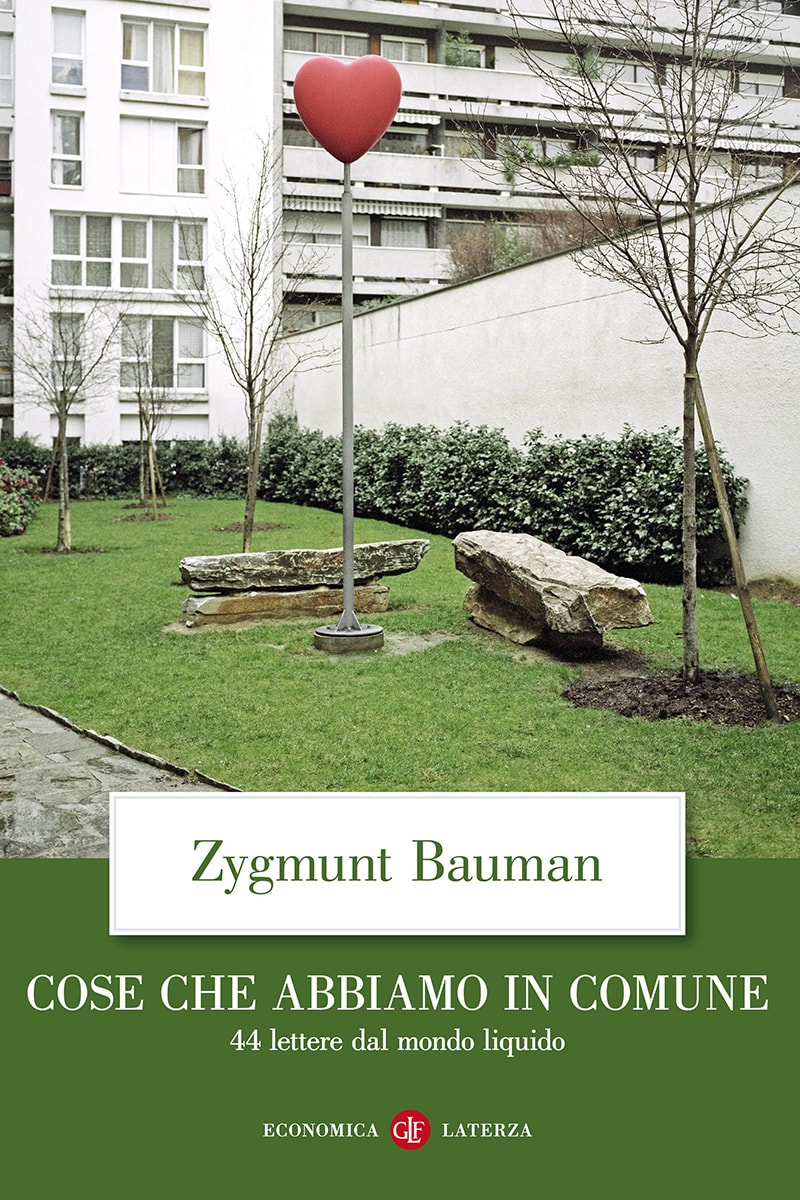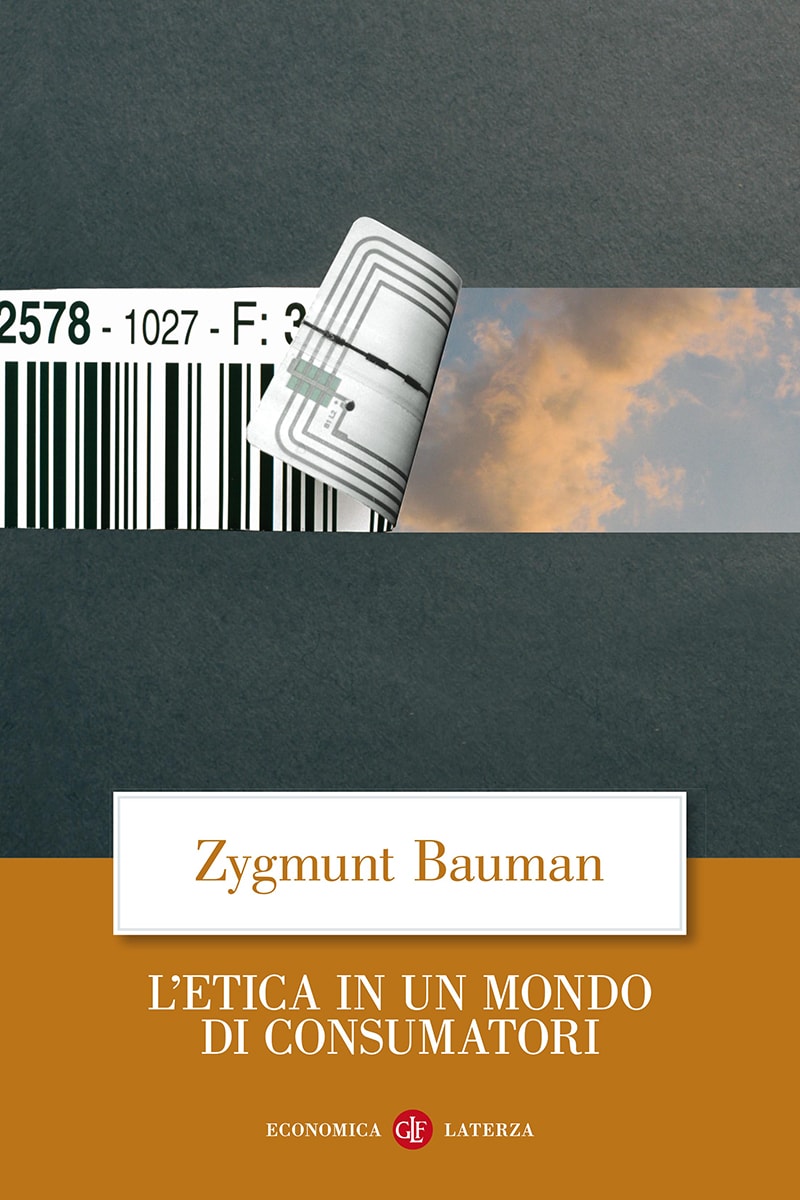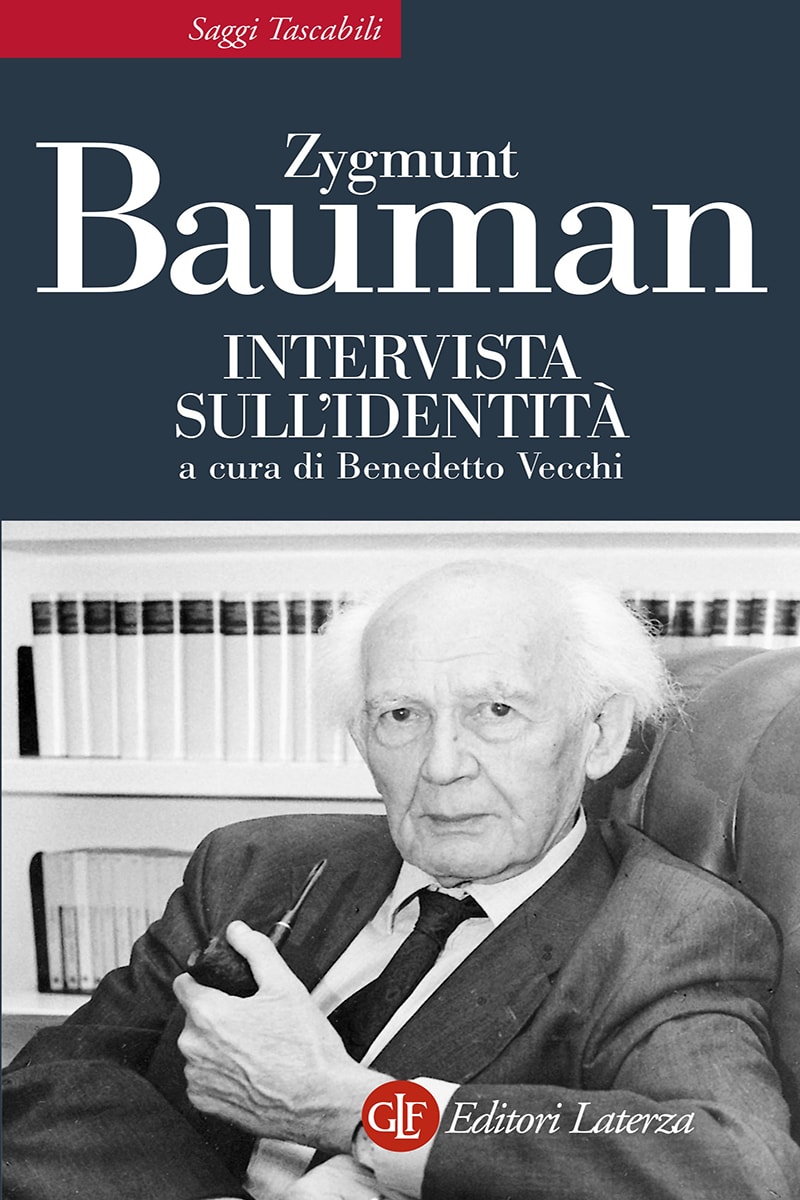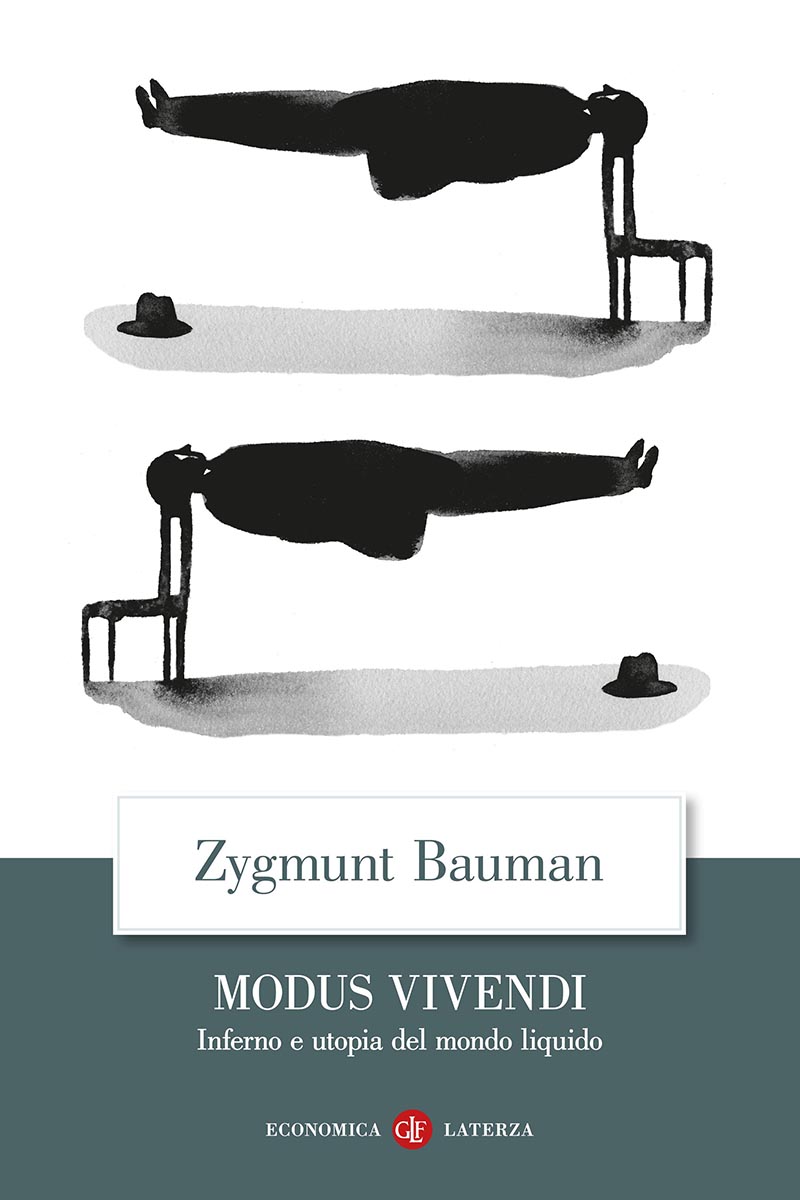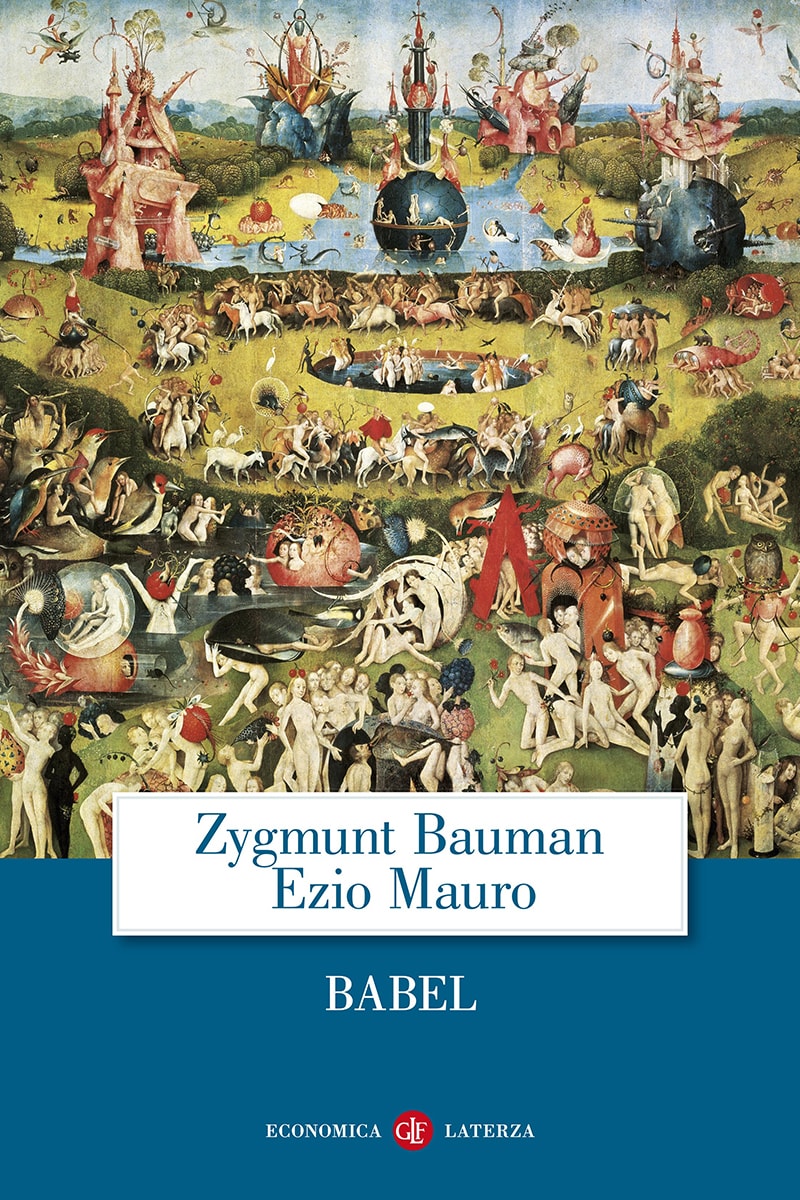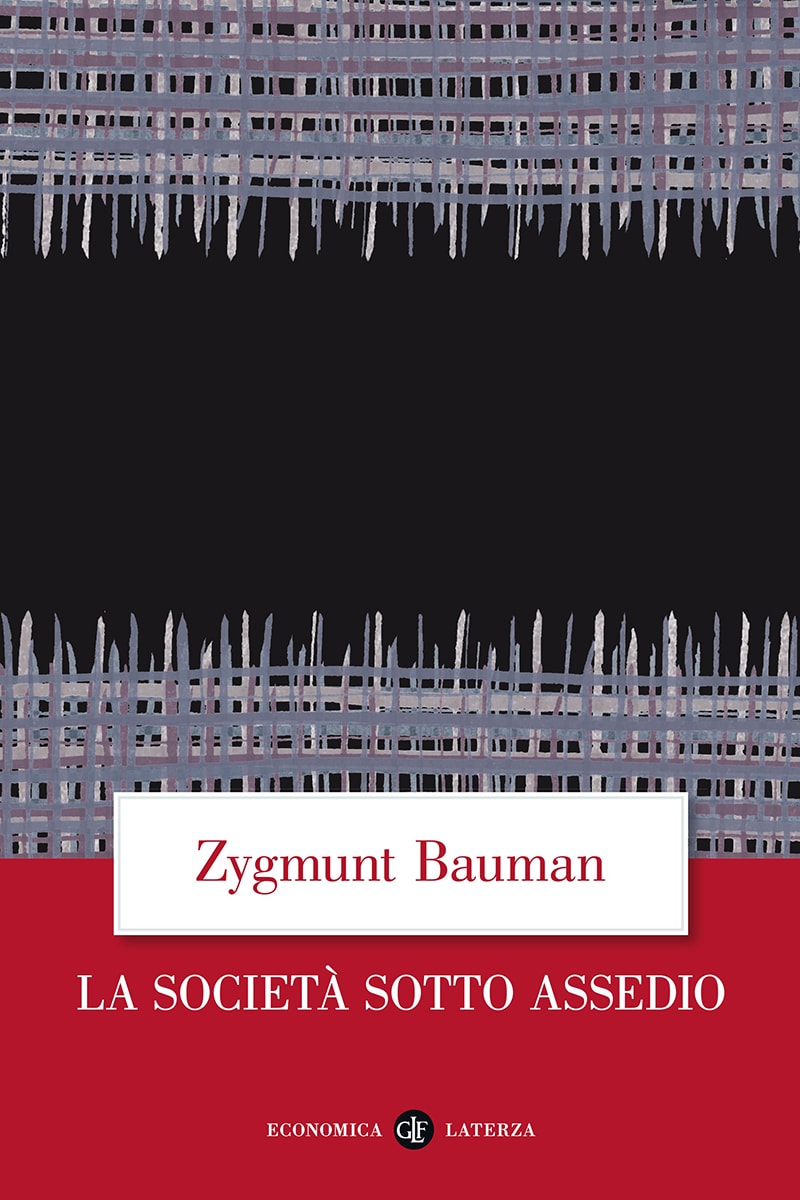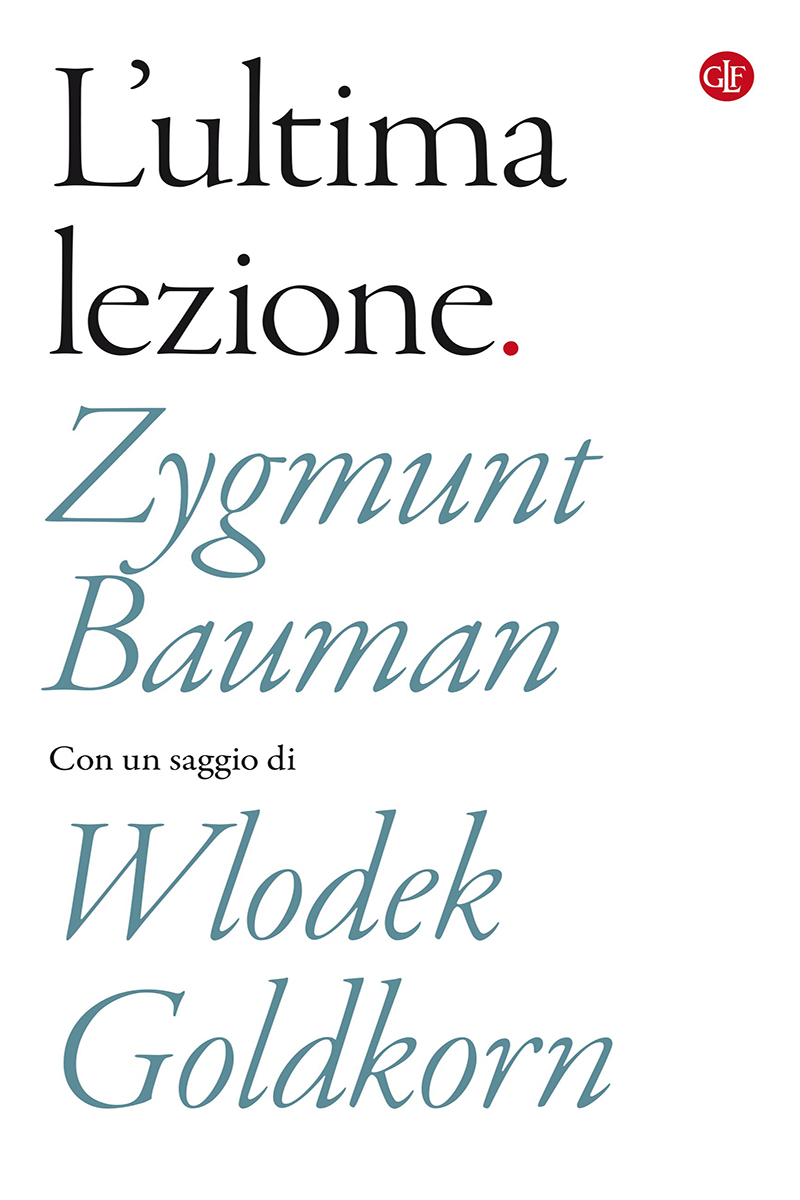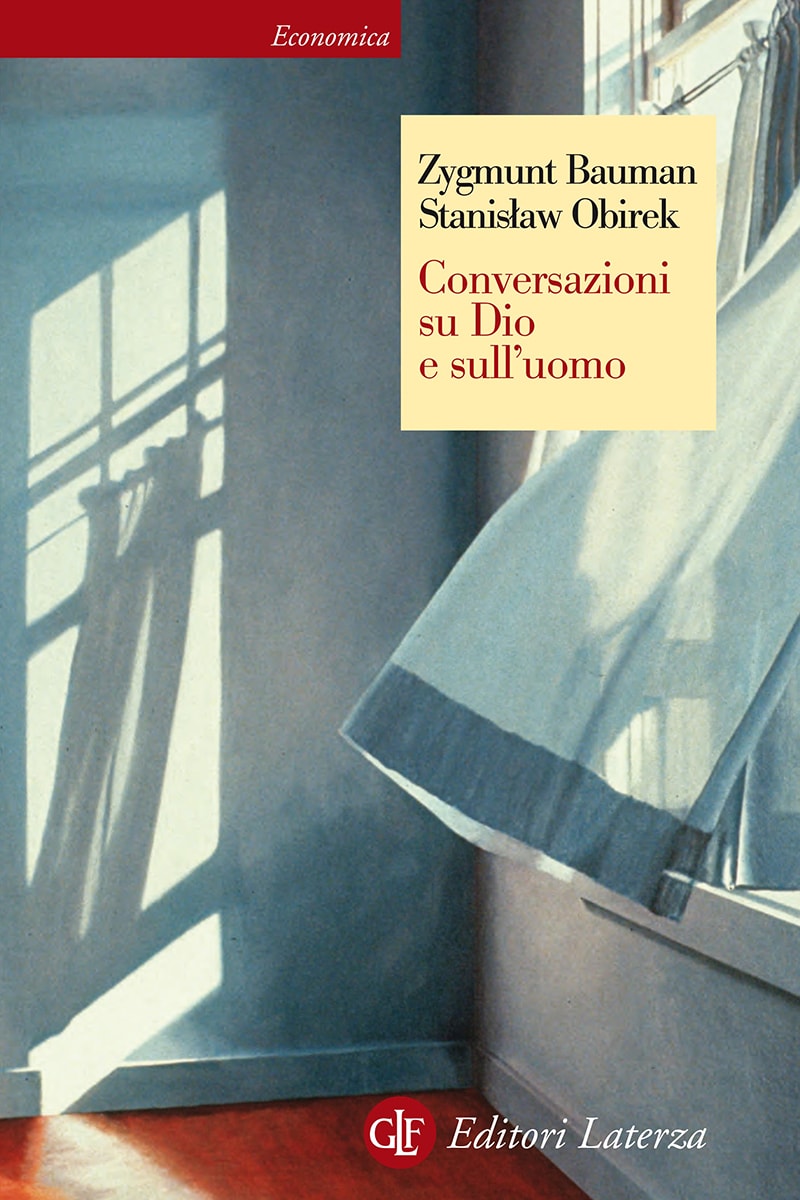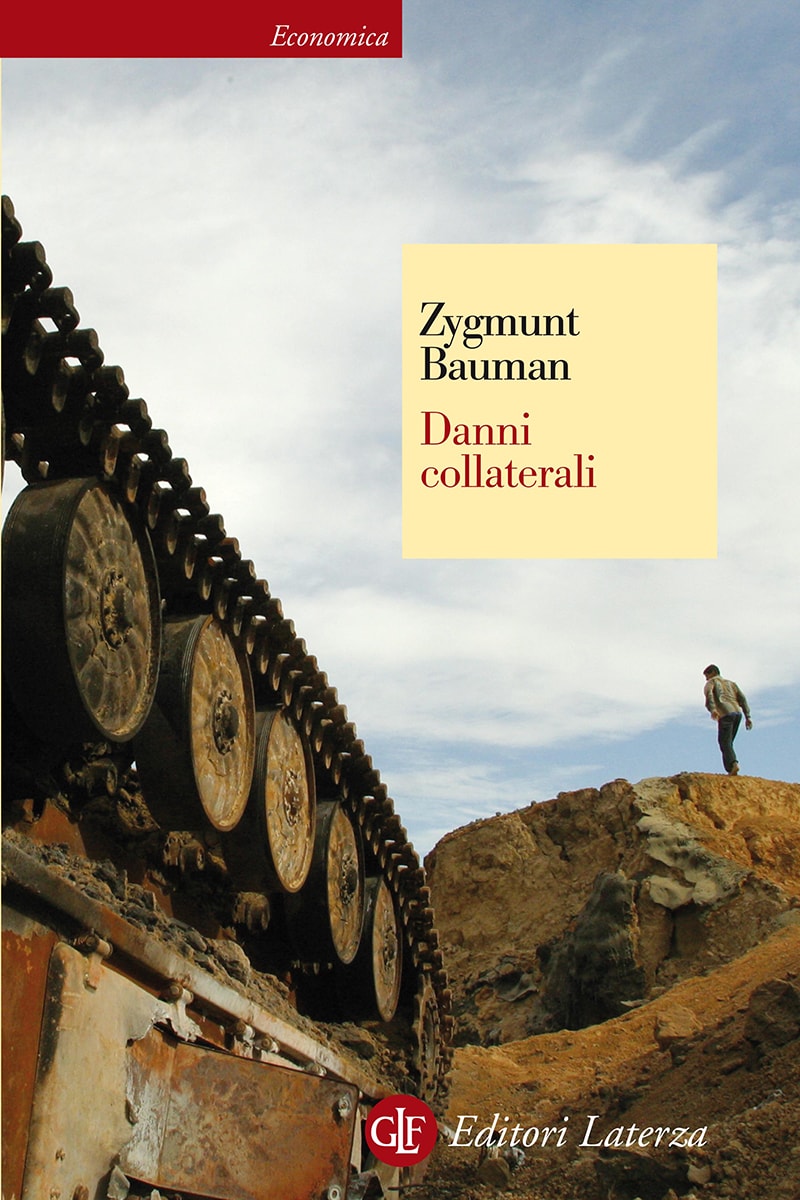La crisi del credito è il risultato del fallimento della Banca o del suo straordinario
successo? Il capitalismo non è morto
CITLALI ROVIROSA-MADRAZOLei è cresciuto durante la prima grande recessione del XX secolo, e all’indomani di
essa è stato testimone di alcuni straordinari momenti storici. Da allora ha fatto
molta strada, finendo per ritrovarsi davanti alla prima grande recessione del XXI
secolo. Tuttavia non è mai stato un semplice osservatore passivo delle novità «scagliate
dalla storia», ma fin da giovanissimo è stato politicamente attivo e ha militato in
movimenti controversi in cui risuona fortemente l’eco delle sfide attuali. Quali sono
stati i suoi primi pensieri quando ha capito che eravamo di fronte a uno «tsunami
finanziario» e che andavamo verso il «crollo inevitabile» dell’economia occidentale?
Quali lezioni avremmo potuto (ma non abbiamo saputo) trarre dalla recessione del XX
secolo? Che cosa possiamo imparare dagli errori del passato? Avverte qualche nostalgia
per il socialismo o per il comunismo?
ZYGMUNT BAUMANMi è impossibile avere «nostalgia per il comunismo». Il comunismo, che una volta ho
definito il «fratello minore impaziente del socialismo»1, è per me un progetto che impone una «scorciatoia per il Regno della Libertà». Questa
scorciatoia, per quanto attraente e incoraggiante a parole, nella sua applicazione
pratica conduce ogni volta al cimitero delle libertà, alla schiavitù. L’idea di scorciatoie
e ancor più la prassi coercitiva contrastano nettamente con la libertà. La coercizione
è una prassi che si alimenta e si rafforza da sé, e richiede uno sforzo attento e
costante per mantenere nell’obbedienza e nel silenzio coloro che la subiscono. Tale
coercizione – se proclamata in nome della libertà umana (come Jean-Jacques Rousseau
riteneva possibile, come Lenin decise di fare a tutti i costi e come Albert Camus
capì drammaticamente essere diventata la regola nel XX secolo) – non fa che distruggere
l’obiettivo che dichiara di perseguire e non serve più a nulla se non ad autoperpetuarsi.
Quanto alla «nostalgia per il socialismo», l’avrei se non credessi più (ma non è così)
nella saggezza e nell’umanità della posizione socialista, e potrei averla se nel «socialismo»
vedessi (ma non vi vedo da tanto) non solo una posizione, un atteggiamento e un principio
guida, ma anche un tipo di società, un progetto, uno specifico modello di ordine sociale.
La parola socialismo esprime per me una grande sensibilità all’ineguaglianza e all’ingiustizia,
all’oppressione e alla discriminazione, all’umiliazione e alla negazione della dignità
umana. Essere su «posizioni socialiste» significa opporsi e resistere a qualsiasi
sopraffazione, da chiunque commessa, in nome e ai danni di chiunque, ovunque e in
qualunque momento.
E il «capitalismo»? Il recente «tsunami finanziario», come lei vividamente lo definisce,
ha dimostrato «al di là di ogni ragionevole dubbio» a milioni di individui, cullati
nel miraggio della «prosperità ora e sempre» e convinti che i mercati capitalisti
e le banche capitaliste fossero metodi garantiti per risolvere i problemi, che il
capitalismo dà il meglio di sé non quando cerca (se cerca) di risolvere i problemi,
ma quando li crea. Il capitalismo, proprio come i sistemi di numeri naturali dei famosi
teoremi di Kurt Gödel, non può essere contemporaneamente sia coerente che completo; se è coerente con i suoi principi sorgono problemi che esso non è in grado
di risolvere, e se cerca di risolverli non può fare a meno di perdere la coerenza
con i propri assunti di base.
Molto prima che Gödel formulasse il suo teorema Rosa Luxemburg, studiando l’«accumulazione
del capitale», aveva sostenuto che il capitalismo non può sopravvivere senza economie
«non capitalistiche» o «precapitalistiche»: esso è in grado di progredire in base
ai suoi principi finché ci sono «terre vergini» aperte all’espansione e allo sfruttamento,
ma appena le conquista per sfruttarle le priva della loro verginità precapitalistica,
ed esaurisce così le fonti del proprio nutrimento. Per dirla senza mezzi termini,
il capitalismo è un sistema sostanzialmente parassitario e, come tutti i parassiti,
quando trova un organismo ancora non sfruttato di cui nutrirsi può prosperare per
un certo periodo, ma non può fare a meno di danneggiare l’ospite, distruggendo così
prima o poi le condizioni della sua prosperità e persino della sua sopravvivenza.
Tuttavia, scrivendo in un’era di imperialismo e di conquiste territoriali senza freni,
Rosa Luxemburg non immaginava, e non poteva immaginare, che i territori premoderni
situati in continenti esotici non erano gli unici potenziali «ospiti» di cui il capitalismo
avrebbe potuto nutrirsi per prolungare la sua esistenza e inaugurare una serie di
periodi di prosperità. Oggi, a distanza di quasi un secolo, sappiamo che la forza
del capitalismo sta nella straordinaria inventiva con cui, ogni volta che le specie
sfruttate in precedenza si riducono o si estinguono, riesce a cercare e a trovare
(o meglio produrre) nuove specie in grado di ospitarlo, e nell’opportunismo e nella
velocità con cui riesce a riadattarsi come un virus alle idiosincrasie dei suoi nuovi
terreni di pascolo. L’attuale stretta creditizia non è il segnale della fine del capitalismo,
ma solo dell’esaurirsi del pascolo più recente.
C’era una volta una storiella su due venditori che viaggiavano in Africa per conto
delle rispettive aziende, che fabbricavano scarpe. Il primo venditore inviò al suo
ufficio questo messaggio: qui tutti vanno a piedi nudi, perciò non spedite scarpe.
Il secondo, invece, scrisse alla sua azienda: qui tutti vanno a piedi nudi, perciò
spedite subito dieci milioni di paia di scarpe. Lo spirito dell’aneddoto è l’elogio
di un senso degli affari brillante e aggressivo e la condanna dei limiti di una filosofia
imprenditoriale che miri a soddisfare i bisogni esistenti tramite offerte costruite
come semplice risposta alla domanda esistente. Tuttavia, nell’arco di qualche decina
d’anni il mondo imprenditoriale ha compiuto una vera e propria inversione a U. La
filosofia di business oggi in auge, in una società che da società di produttori (in
cui i profitti venivano in primo luogo dallo sfruttamento del lavoro dipendente) si
è trasformata con successo in società di consumatori (in cui i profitti vengono in
primo luogo dallo sfruttamento dei desideri dei consumatori), si basa sull’idea di
fondo che le imprese debbano evitare che i bisogni vengano soddisfatti e debbano suscitare,
indurre, evocare e gonfiare altri bisogni che chiedono a gran voce di essere soddisfatti,
e altri consumatori potenziali che agiscono spinti da quei bisogni: in una parola,
che sia compito dell’offerta creare la propria domanda. Tale filosofia si applica
a qualsiasi prodotto delle fabbriche come delle imprese finanziarie. I prestiti non
fanno eccezione: l’offerta di credito deve creare ed espandere il bisogno di credito.
Il segnale è stato l’introduzione delle carte di credito. Esse furono lanciate «sul
mercato» una trentina d’anni fa, con lo slogan, efficace e straordinariamente seducente,
Take the waiting out of wanting, «togli l’attesa dal desiderio». Desideriamo qualcosa, ma non abbiamo ancora guadagnato
denaro sufficiente per poterlo pagare? Ai vecchi tempi, ormai per fortuna morti e
sepolti, bisognava rinviare le gratificazioni (questo rinvio, secondo Max Weber, uno
dei padri della sociologia moderna, fu il principio che rese possibile l’avvento del
capitalismo moderno): stringere la cinghia, negarsi tante gioie, spendere con prudenza
e frugalità e depositare le somme risparmiate in un libretto di risparmio, sperando
di riuscire, con la dovuta cura e pazienza, a raccogliere abbastanza da tradurre i
sogni in realtà. Grazie a Dio e alla benevolenza delle banche, ora non più! Con una
carta di credito si può invertire l’ordine dei fattori: godersela adesso e pagare
dopo. La carta di credito ci rende liberi di gestire le gratificazioni, di ottenere
le cose quando le vogliamo, non quando ce le saremo guadagnate e potremo permettercele.
Questa era la promessa. Ma vi era allegata una clausola, difficile da decifrare ma
facile da indovinare (se solo ci si fosse riflettuto un momento): ogni «dopo» diventerà
(prima o poi) un «adesso», i prestiti dovranno essere rimborsati e il rimborso dei
debiti contratti per eliminare l’attesa dal desiderio e soddisfare immediatamente
i desideri attuali renderà ancora più difficile soddisfare nuovi desideri. Non pensare
al «dopo» significa, come sempre, accumulare problemi. Se smettiamo di preoccuparci
per il futuro lo facciamo a nostro rischio e pericolo. Ci sarà sicuramente un prezzo
pesante da pagare. Presto o tardi scopriremo che lo sgradevole «rinvio della gratificazione»
è stato rimpiazzato da un breve rinvio della punizione, questa sì terribile, per aver
voluto aver fretta. Si può avere il piacere quando si vuole: ma accelerare l’arrivo
del piacere non rende più accessibile il suo godimento. In definitiva, a essere rinviato
è solo il momento in cui ci renderemo conto di questa triste verità.
Per quanto nociva e penosa, questa non era l’unica clausola allegata alla promessa
a caratteri cubitali del «godersela adesso e pagare dopo». Per non ridurre semplicemente
l’effetto delle carte di credito e del credito facile a un profitto una tantum per il prestatore, il debito contratto doveva inevitabilmente essere trasformato
in un’attività redditizia permanente. Non potete rifondere il debito? Innanzitutto,
non occorre che proviate a rifonderlo tutto e subito: l’assenza di debiti non è lo
stato ideale. In secondo luogo, non state a preoccuparvene: a differenza dei malvagi
creditori di una volta, smaniosi di riavere indietro prontamente i loro soldi secondo
scadenze prefissate e non dilazionabili, noi, la nuova razza di creditori moderni
e benevoli, non rivogliamo indietro i nostri soldi; anzi, vi offriamo di prenderne
in prestito altri per ripagare il vecchio debito e tenervi qualche soldo (cioè qualche
debito) in più per pagarvi nuove gioie. Siamo le banche che amano dire di «sì». Le
tue banche amiche. Banche «che sorridono», come dichiarava uno degli slogan pubblicitari
più ingegnosi.
Quello che nessuna pubblicità dichiarava apertamente, lasciando la verità agli oscuri
presentimenti degli stessi debitori, era che le banche creditrici non volevano veramente
la restituzione del denaro prestato. Se i debitori avessero diligentemente ripagato
i prestiti non sarebbero più stati in debito: ma proprio il fatto che siano indebitati(e usino parte del prestito per pagare un interesse mensile) è ciò che la nuova razza
di creditori moderni e benevoli (e tanto ingegnosi) ha voluto (e saputo) trasformare
nella propria principale fonte di profitto continuo. L’incubo di questi creditori
è proprio il cliente che restituisce prontamente il denaro preso in prestito. Chi
rifiuta di spendere soldi che non ha guadagnato e si astiene dal prenderli in prestito
non è di alcuna utilità per i creditori, e non lo è nemmeno chi (spinto dalla prudenza
o da un onore desueto) si affanna per saldare i debiti quando stabilito.
Per garantire i propri profitti e quelli degli azionisti le banche e le società di
carte di credito contano ormai sul «servizio» continuato del debito anziché sul pronto
rimborso dello stesso. Il «debitore ideale» non ripaga mai interamente il proprio
debito. Gli individui che hanno un libretto di risparmio ma non hanno carta di credito
sono visti come una sfida alle abilità di marketing: «terre vergini» che chiedono
a gran voce di essere sfruttate e promettono profitti copiosi. Una volta che costoro
sono stati «messi a coltura» (ossia fatti entrare nel gioco del prestito), non devono
più poter uscire dal gioco e tornare «a maggese». Chi vuole rifondere per intero il
mutuo prima della scadenza dovrà pagare una forte penale, che lo costringerà a restare
in gioco. Fino alla recente crisi del credito, le banche e le società di carte di
credito erano più che disponibili a offrire nuovi prestiti ai debitori insolventi
per coprire gli interessi non pagati sui prestiti precedenti. Recentemente una delle
maggiori società di carte di credito in Gran Bretagna ha fatto scalpore (per poco
tempo, questo è certo) quando ha svelato il gioco, rifiutando di rilasciare nuove
carte di credito a quei clienti che ogni mese saldavano per intero i debiti per non
pagare interessi, così come le stesse banche cercano di pagare meno tasse.
Riassumendo: l’odierna «crisi del credito» non è il risultato del fallimento delle
banche. Al contrario, è il frutto – assolutamente prevedibile anche se in gran parte
imprevisto – del loro straordinario successo. Successo nel trasformare una stragrande
maggioranza di uomini e donne, vecchi e giovani in una razza di debitori. Le banche
hanno ottenuto quello che volevano: una razza di eterni debitori che vive in una condizione
di «indebitamento» che si autoperpetua e che solo chiedendo altri prestiti può realisticamente
(ma temporaneamente) ottenere una sospensione della pena.
Accedere a questa condizione è diventato facile come mai prima d’ora nella storia
dell’umanità; sfuggire a questa condizione non è mai stato tanto difficile. Chiunque
potesse essere trasformato in debitore, ivi compresi milioni di persone che non potevano
e non dovevano essere indotti a chiedere soldi in prestito, è già stato adescato e
spinto a indebitarsi. Come in tutte le precedenti mutazioni del capitalismo, anche
stavolta lo Stato ha dato una mano a creare i nuovi pascoli da sfruttare: è su iniziativa
del presidente Clinton che sono stati introdotti negli Stati Uniti i mutui subprime, garantiti dal governo, offrendo credito per l’acquisto di una casa a chi era privo
di mezzi sufficienti a ripagare il debito, e spingendo così a indebitarsi settori
della popolazione fino a quel momento inaccessibili allo sfruttamento mediato dal
credito. Ma proprio come la scomparsa di persone a piedi nudi rappresenta un guaio
per l’industria calzaturiera, così la scomparsa di persone non indebitate rappresenta
un disastro per l’industria del credito. La famosa previsione di Rosa Luxemburg si
è avverata ancora una volta: di nuovo il capitalismo è arrivato pericolosamente vicino
a un suicidio non voluto, dopo aver esaurito tutte le riserve di terre vergini da
sfruttare.
Negli Stati Uniti l’indebitamento medio di una famiglia negli ultimi otto anni – anni
apparentemente contrassegnati da una prosperità senza precedenti – è cresciuto del
22 per cento. La somma totale degli acquisti fatti con carta di credito e non rimborsati
è cresciuta del 15 per cento. E, cosa forse più pericolosa, è raddoppiato il debito
complessivo degli studenti universitari, la futura élite politica, economica e spirituale
della nazione. Gli studenti sono stati costretti/incoraggiati a vivere a credito,
a spendere soldi che nella migliore delle ipotesi potevano sperare di guadagnare solo
molti anni dopo. L’addestramento all’arte di «vivere indebitati» in via permanente
è entrato a far parte dei programmi scolastici nazionali. A una situazione molto simile
si è arrivati in Gran Bretagna. Qui, nell’agosto dello scorso anno, il totale dei
debiti per consumo non rimborsati ha superato il prodotto interno lordo. Le famiglie
britanniche sono indebitate per un valore superiore a tutto ciò che producono le fabbriche,
le fattorie e gli uffici. Gli altri paesi europei seguono a breve distanza. Il pianeta
dei banchieri sta esaurendo le terre vergini dopo aver sfruttato inesorabilmente le
vaste distese di terre endemicamente sterili.
CRMPensa che gli ultimi avvenimenti in campo economico rappresentino una svolta, il
«momento decisivo» del pensiero politico occidentale? Che i nostri paradigmi politici
(moderni o post-moderni) si siano sgretolati e dissolti per non tornare mai più? Che
sia tempo di seppellire i morti?
ZBCome avrebbe detto Mark Twain, le notizie sulla morte del capitalismo sono alquanto
esagerate... Anche i necrologi sulla fase «creditizia» della storia dell’accumulazione
capitalistica sono prematuri.
Finora la reazione alla «crisi del credito», per quanto impressionante e persino rivoluzionaria
possa apparire nei titoli dei giornali e nelle frasi a effetto dei politici, è stata
del tipo «Datecene ancora», nella vana speranza che le potenzialità di quella particolare
terra vergine al fine di rilanciare i profitti e i consumi non siano ancora del tutto
esaurite: è consistita, cioè, nel tentativo di ricapitalizzare i creditori e rendere
nuovamente degni di credito i loro debitori, affinché il business del dare e ricevere
in prestito, dell’indebitarsi ed essere indebitati, possa tornare alla «normalità».
Il welfare per i ricchi (che non è mai stato messo in discussione nella sua razionalità, né tanto
meno si è proceduto a smantellare, a differenza dal welfare per i poveri) è uscito dalle stanze di servizio in cui, per evitare spiacevoli paragoni,
erano stati temporaneamente relegati i suoi uffici, ed è tornato nei saloni di rappresentanza.
Lo Stato è tornato a mostrare i muscoli come da tempo non faceva, ma lo ha fatto per
poter continuare il gioco che rende tale sfoggio di bicipiti sgradito ma drammaticamente
inevitabile, uno strano gioco che non può tollerare uno Stato che mostri i muscoli,
ma allo stesso tempo non può sopravvivere senza.
Ciò di cui ci si è allegramente (e sconsideratamente) dimenticati in questa occasione
è che la natura della sofferenza umana dipende dal modo di vivere degli esseri umani.
Come per qualsiasi male della società, le radici del dolore che oggi lamentiamo sono
profondamente ancorate al modo artefatto in cui ci viene insegnato a vivere: alla
nostra abitudine, meticolosamente coltivata e ormai profondamente radicata, di correre
a chiedere soldi in prestito ogni volta che c’è un problema da affrontare o una difficoltà
da superare. Vivere a credito crea dipendenza come e forse più di qualsiasi altra
droga, e sicuramente più degli altri tranquillanti in offerta; e se per decenni è
stata abbondantemente somministrata una droga, quando essa non è più disponibile o
diventa difficile da reperire lo choc è inevitabile. La via d’uscita dal trauma che
affligge i tossicodipendenti come gli spacciatori che ora ci viene proposta è quella
apparentemente facile: ripristinare la fornitura (si spera regolare) di droga; tornare
a quella dipendenza che fino a oggi sembrava aiutarci tanto efficacemente a non preoccuparci
dei problemi, e tanto meno delle loro radici.
Arrivare alle radicidel problema che è uscito dal cassetto top secret ed è stato messo sotto i riflettori
dell’opinione pubblica non è (e non può essere) una soluzione istantanea. È però l’unica
soluzione che abbia qualche possibilità di risultare adeguata all’enormità del problema
e di sopravvivere ai tormenti intensi ma relativamente brevi della disassuefazione.
Finora non ci sono molti motivi per pensare che siamo vicini alle radici del problema.
La banca Lloyds Tsb, salvata un passo prima del baratro dalle copiose iniezioni di
«denaro dei contribuenti», ha cominciato subito a fare pressioni sul Tesoro britannico
per destinare parte del pacchetto di salvataggio ai dividendi per gli azionisti; a
dispetto dell’indignazione ufficiale dei portavoce dello Stato, l’istituto di credito
è andato avanti indisturbato a versare gratifiche proprio a coloro che con la loro
smodata avidità avevano trascinato al disastro le banche e i loro clienti. Dagli Stati
Uniti è arrivata la notizia che 70 miliardi di dollari – circa il 10 per cento dei
sussidi che le autorità federali intendono pompare nel sistema bancario americano
– sono già stati usati per versare gratifiche a coloro che hanno portato il sistema
sull’orlo della rovina. Le misure che i governi hanno intrapreso, vogliono intraprendere
o dicono di voler intraprendere, per quanto imponenti, sono tutte finalizzate a «ricapitalizzare»
le banche e a metterle in condizione di tornare a svolgere la loro «normale attività»:
proprio l’attività che è la principale responsabile della crisi attuale. Se i debitori
non sono in grado di pagare direttamente e personalmente gli interessi sulle passate
orge consumistiche, ispirate e gonfiate dalle banche, potranno forse essere indotti/costretti
a farlo attraverso le tasse riscosse dallo Stato.
Non abbiamo ancora cominciato a ragionare seriamente sulla sostenibilità di questa
nostra società alimentata dai consumi e dal credito. Il «ritorno alla normalità» preannuncia
un ritorno ai metodi sbagliati, che restano potenzialmente pericolosi. Queste intenzioni
preoccupano, perché sono il segnale che né le persone che guidano le istituzioni finanziarie
né i nostri governi sono arrivati alla radice del problema nelle loro diagnosi, e
tanto meno nelle loro azioni. Citando Hector Sants, il direttore della Fsa (l’authority finanziaria britannica), che aveva ammesso e «lamentato» l’esistenza di «modelli
di business male attrezzati per sopravvivere allo stress», Simon Jenkins, eccellente
commentatore del «Guardian», lo ha paragonato a «un pilota che protesta perché il
suo aereo non ha niente che non funzioni, a parte i motori». Ma Jenkins non ha perso
le speranze e continua a pensare che, una volta «spazzata via dalla recente isteria
dei profitti finanziari» la cultura dell’«avido è bello», le «componenti non economiche
di quella che genericamente definiamo una vita piacevole assumeranno maggiore importanza»
sia nella nostra filosofia di vita, sia nella strategia politica dei nostri governi.
Ci uniamo alle sue speranze: non siamo ancora al punto di non ritorno, c’è ancora
tempo (anche se poco) per riflettere e cambiare strada, possiamo ancora volgere questo
choc e questo trauma a vantaggio nostro e dei nostri figli.
CRMMentre mettevamo su carta queste conversazioni, nelle settimane seguite allo scoppio
della crisi finanziaria, è sembrato che fosse ormai compiuta, come ha scritto su «The
Nation» la nordamericana Naomi Klein, la definitiva trasformazione dello Stato in
una enorme compagnia di assicurazioni che emette polizze in favore delle banche e
di Wall Street. Ritiene che questa mutazione segni il punto fatidico del crollo di
una gigantesca formazione discorsiva che era riuscita in qualche modo a sopravvivere
ai tempi liquidi?
ZBUna sorta di welfare state per i ricchi (o, più esattamente, una politica statale volta a mobilitare quelle
risorse pubbliche che le imprese private, anche se quotate in borsa, non riescono
a farsi consegnare dal pubblico) non è affatto una novità: la novità che fa scalpore
è costituita soltanto dalla dimensione che ha assunto e dalla pubblicità che lo accompagna,
le quali hanno assunto proporzioni tali da fare scalpore. Secondo Stephen Sliwinski,
del Cato Institute, già nel 2006 il governo federale aveva speso 92 miliardi di dollari
per sovvenzionare colossi dell’industria americana come Boeing, Ibm o General Motors.
Molti anni fa Jürgen Habermas, in un libro intitolato La crisi della razionalità nel capitalismo maturo2, affermò che lo Stato è «capitalista» nella misura in cui la sua funzione primaria,
anzi la sua ragion d’essere, è la «rimercificazione» del capitale e del lavoro. La
sostanza del capitalismo, ricordava Habermas, è l’incontro tra capitale e lavoro.
Lo scopo di questo incontro è una transazione commerciale: il capitale acquista lavoro.
Affinché questa transazione avvenga devono essere soddisfatte due condizioni: il capitale
dev’essere in grado di comprare e il lavoro dev’essere «vendibile», cioè sufficientemente
attraente da farsi acquistare. Il compito principale (la «legittimazione») dello Stato
capitalista è provvedere a che entrambe le condizioni siano soddisfatte. Lo Stato
deve fare dunque due cose. Primo, sovvenzionare il capitale nel caso a quest’ultimo
manchi il denaro necessario per acquistare lavoro. Secondo, garantire che il lavoro
meriti di essere acquistato, cioè che la manodopera sia in grado di sopportare le
fatiche del lavoro di fabbrica, che sia forte e in buona salute, adeguatamente nutrita
e debitamente istruita alle competenze e alle abitudini comportamentali indispensabili
per lavorare nell’industria. Senza l’aiuto amministrato dallo Stato, difficilmente
gli aspiranti datori di lavoro capitalistici potrebbero permettersi tutte queste spese:
e se dovessero sostenerle il costo dell’assunzione di manodopera diventerebbe esorbitante
rispetto ai loro standard.
Habermas scriveva tutto ciò al crepuscolo della società solido-moderna dei produttori,
e interpretava (erroneamente, come poi si è visto) come Legitimationsproblem, crisi di legittimazione dello Stato capitalista, l’evidente incapacità degli Stati
di assolvere ai due compiti necessari alla sopravvivenza di quella società. Ma ciò
che in realtà stava avvenendo era una transizione dalla moderna società «solida» dei
produttori alla moderna società «liquida» dei consumatori. La fonte primaria di accumulazione
capitalistica si trasferiva dall’industria al mercato dei consumi. Per mantenere in
vita il capitalismo non bastava più «rimercificare» il capitale e il lavoro per rendere
possibile la transazione di compravendita del lavoro che ne era il requisito primario,
ma erano urgentemente necessari aiuti statali per consentire al capitale di vendere
merci e ai consumatori di comprarle. Il credito era il congegno magico che si pensava
e si sperava assolvesse a questo doppio compito: e ora possiamo dire che nella fase
liquida della modernità lo Stato è «capitalista» nella misura in cui garantisce la
continuità dell’offerta di credito e della capacità dei consumatori di accedervi.
CRMLei ha vissuto le fasi iniziali della transizione da un’economia basata sul capitale
industriale a un’economia basata sul capitale finanziario, e ne ha fatto uno dei temi
del suo lavoro accademico. E ha vissuto momenti storici straordinari, come il drammatico
scontro tra totalitarismo e liberalismo. Allora, come ora, il mondo sembrava giunto
a un crocevia, sembrava trovarsi di fronte all’apparente «dilemma» tra una «dittatura
dello Stato» e una «dittatura del mercato» (espressione usata per la prima volta da
un uomo di Stato occidentale quando, dopo il crollo di Wall Street, il presidente
francese Nicolas Sarkozy ne ha dichiarato la morte). Era questo un vero dilemma tra
sistemi politici ed economici incompatibili tra loro, o piuttosto un tipico riflesso
del nostro pensiero binario e schizofrenico, dell’incapacità umana di pensare al di
fuori di dicotomie? Oppure era (ed è) un mero riflesso della volontà di potere e del
desiderio di dominio?
ZBQuando gli elefanti litigano, povera l’erba... Nella guerra fra i due pretendenti
alla dittatura, ha finito per essere trascurata, di fatto, la sorte dei poveri, degli
oziosi e di chi per altri motivi è incapace di raggiungere le condizioni della sopravvivenza
fisica e sociale. Ma presentare le due dittature come la principale contrapposizione
e il principale dilemma della società contemporanea è profondamente fuorviante: è
facile prendere le apparenze per realtà e le dichiarazioni per politiche...
Prima di tutto occorre puntualizzare che i due elefanti, lo Stato e il mercato, possono
anche occasionalmente combattersi, ma in un sistema capitalista la loro relazione
normale e ordinaria, o addirittura di routine, è la simbiosi. Pinochet in Cile, Syngman
Rhee in Corea del Sud, Lee Kuan Yew a Singapore, Chiang Kai-shek a Taiwan o gli attuali
governanti della Cina sono stati o sono, in tutto fuorché nel nome, «dittatori di
Stato»: e tuttavia hanno governato o governano una clamorosa espansione e un rapido
aumento del potere dei mercati. Se oggi tutti i paesi citati sono esempi di trionfi
del mercato, ciò si deve alla prolungata «dittatura dello Stato». Ricordiamo anche
che l’accumulazione originaria del capitale conduce immancabilmente a una inedita
polarizzazione delle condizioni di vita, che suscita forte avversione e produce tensioni
sociali potenzialmente esplosive: la classe imprenditoriale e mercantile emergente
ha bisogno che tali tensioni vengano soffocate da dittature di Stato potenti e spietate.
Nel capitalismo la collaborazione tra Stato e mercato è la regola, e il conflitto,
se mai affiora, è l’eccezione. Di regola le politiche dello Stato capitalista, «dittatoriale»
o «democratico», vengono costruite e condotte nell’interesse dei mercati, e non contro
di essi; il loro effetto principale (e voluto, anche se non sempre apertamente dichiarato)
è di avallare/consentire/garantire la sicurezza e la longevità del predominio del
mercato. Il secondo elemento dei due compiti di «rimercificazione» di cui abbiamo
parlato in precedenza, la «rimercificazione del lavoro», non ha fatto eccezione. Per
quanto forti potessero essere le considerazioni morali che spingevano all’introduzione
del welfare state, difficilmente esso sarebbe nato se i padroni delle fabbriche non avessero ritenuto
che prendersi cura dell’«esercito industriale di riserva» (mantenere in buona forma
i riservisti per l’eventualità che venissero richiamati in servizio attivo) era un
buon investimento, potenzialmente redditizio. Se oggi il welfare state si vede tagliare i fondi, cade a pezzi o viene deliberatamente smantellato è perché
le fonti di profitto del capitalismo si sono (o sono state) spostate dallo sfruttamento
della manodopera operaia allo sfruttamento dei consumatori. E perché i poveri, privati
delle risorse necessarie per rispondere alle seduzioni consumistiche dei mercati,
per risultare utili, secondo l’attuale concezione capitalista di «utilità economica»,
hanno bisogno di guadagnare o farsi prestare denaro, e ciò non rientra tra i servizi
che tendono a essere offerti dal welfare state.
CRMDopo lo choc iniziale prodotto dal crollo finanziario globale del settembre 2008,
il primo ministro britannico Gordon Brown è intervenuto per salvare alcuni istituti
bancari, e Washington ne ha seguito l’esempio varando un pacchetto di vari miliardi
di dollari per salvare Wall Street, e di conseguenza le banche nordamericane. Ben
presto anche altri settori dell’economia sono accorsi a tendere la mano chiedendo
sovvenzioni.
Come in una festa per ragazzini in cui i più grandi si gettano nella mischia per afferrare
le caramelle e i dolciumi che piovono dalla pignatta, i banchieri e le grandi corporations si sono avventati sui doni della pignatta in mille pezzi, mentre i piccoli e i timidi
stavano a guardare «i grandi» arraffare a più non posso. Era l’inverno del 2008. I
capi di Stato, ministri dell’ambiente e alti funzionari governativi riuniti in Polonia,
a Poznan´, per la conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici si stavano accanendo per definire
un accordo che tagliasse di un quinto le emissioni di gas serra entro il 20203. Contemporaneamente, a Washington le maggiori aziende automobilistiche – General
Motors, Chrysler e Ford – chiedevano al Senato un provvedimento di salvataggio da
14 miliardi di dollari. Quando si è svolta questa nostra conversazione non sembrava
che il sistema fosse pronto a investire in modo sostanziale nei trasporti pubblici
collettivi e ad abbandonare gradualmente l’industria automobilistica, e nemmeno a
ridurre drasticamente le emissioni di gas serra: anche il dibattito sui biocombustibili
è proseguito con la contrapposizione tra chi considera l’etanolo da cereali una panacea
per l’effetto serra e chi ritiene che i biocarburanti siano peggiori dei loro sostituti,
comportando un maggior uso di combustibile fossile ad alte emissioni di carbonio e
al tempo stesso mettendo a rischio la sicurezza idrica e alimentare4.
Nel secolo scorso, di fronte alla recessione, il presidente Franklin D. Roosevelt
ordinò all’industria automobilistica di produrre carri armati e aeroplani anziché
vetture (qualcuno direbbe che l’industria militare era un modo per «prendere due piccioni
con una fava», per sconfiggere cioè sia il nemico che la recessione). Ma nel nostro
secolo ancora giovane un nuovo fattore ha complicato le cose: il riscaldamento globale.
Viene allora da chiedersi: è possibile, nel nostro secolo, un altro Franklin D. Roosevelt?
Se l’industria dell’auto non è in grado di sopravvivere (o perché non potrà essere
salvata, o perché diventerà il fattore scatenante dell’ultima catastrofe ambientale),
che cosa riserva il futuro ai milioni di famiglie che dipendono da quell’industria
e ai milioni di consumatori di tutto il mondo che dipendono dall’economia che essa
genera? E, infine, se non ci saranno passi avanti sul fronte dei cambiamenti climatici
– con conseguenti crisi idriche e alimentari e altre calamità ambientali (e la sicurezza
idrica è vista come una delle maggiori minacce per la pace nel XXI secolo, come mi
ha detto Luis Echeverria Álvarez, ex presidente del Messico ed ex direttore del Centre
for Economic and Social Studies of the Third World)5 – siamo alle soglie di un’altra guerra mondiale? Si avvicina il momento in cui il
serpente di Rosa Luxemburg divorerà e inghiottirà la propria testa?
ZBUn’eventualità che la metafora del serpente rende pressoché inconcepibile è proprio
la possibilità che il serpente divori la propria testa. Una testa di serpente potrebbe
essere crionizzata (la crionica, come ci spiega Wikipedia, riguarda «la conservazione
a bassa temperatura di uomini e di animali la cui sussistenza non può più essere assicurata
dalla medicina contemporanea, al fine di risuscitarli se possibile in futuro»), nella
speranza di poterla riportare in vita in un momento imprecisato insieme al resto del
corpo (attualmente esistono diversi laboratori improvvisati, creati e generosamente
finanziati dallo Stato, in cui ci si trastulla con queste speranze trasformate in
previsioni e obiettivi progettuali); oppure, la stessa testa potrebbe diventare cibo
per animali saprofagi (in giro se ne incontrano tanti, intenti ad annusare, sbavare,
leccarsi i baffi e affilarsi i denti); potrebbe essere una delle tante macerie da
rimuovere per fare spazio a future costruzioni (i macchinari per la rimozione sono
ancora in mano agli architetti, e i progetti dei futuri edifici sono ancora sui loro
tavoli da disegno); o potrebbe infine diventare una riserva alimentare a lento rilascio
per batteri e (quando i paleontologi la ritroveranno, tra qualche secolo) un serbatoio
di temi di infiniti dibattiti, disquisizioni e controversie, nonché di occasioni di
autopromozione per accademici ambiziosi e celebrità egocentriche. In nessuno di questi
casi la testa si disintegrerà, a meno che non venga aiutata dall’esterno ad annientarsi...
Ciò che invece suggerisce (sia pure indirettamente) la metafora del serpente è che
il decesso/crollo del capitalismo è pensabile come implosione, anziché come esplosione
o distruzione per un colpo proveniente dall’esterno (che, se invece ci fosse, non
sarebbe che il colpo di grazia): che il capitalismo, in altre parole, si esaurirà
per fame, insieme alla riserva di terreni di pascolo disponibili/possibili/immaginabili.
E secondo la legge dei rendimenti decrescenti, ben nota a qualsiasi contadino o minatore,
quando la riserva si avvicina al punto di esaurimento lo sforzo per ottenere un incremento
anche modesto del raccolto utile/utilizzabile/redditizio comporta costi esorbitanti,
che rendono insensato qualsiasi ulteriore sforzo di coltivazione (o estrazione) e
consigliano di abbandonare l’attività prima che essa diventi impossibile.
Sembra che siamo a questo punto: un punto in cui non è più plausibile proseguire sulla
strada seguita fino ad ora, sebbene le nostre guide cerchino con tutte le forze di
«tornare alla normalità». È impossibile dire quanto ciò potrà rivelarsi traumatico.
Giustamente lei indica nell’industria dell’auto un esempio di quella «normalità» cui
è impensabile poter tornare; ma, se così è, fin dove arriverà questa marea, e quanto
devastanti saranno i suoi risultati? Si è calcolato che circa un terzo della popolazione
statunitense vive producendo servizi funzionali allo stile di vita che dipende dall’automobile.
Torna in mente ciò che accadde negli Stati Uniti quando l’agricoltura estensiva, alimentata
dalla prospettiva di facili guadagni, contribuì a ridurre le terre fertili mai sfruttate
prima al cosiddetto dust bowl, a una «conca di polvere», e centinaia di migliaia di famiglie come quella del mezzadro
Tom Joad di Furore, dopo aver abbandonato case e terreni ormai inariditi o esserne state scacciate,
si misero in viaggio in cerca di terra, lavoro e dignità. E infatti lei giustamente
ricorda Franklin Delano Roosevelt e si chiede se potrà esserci, nel XXI secolo, un
altro Franklin D. Roosevelt.
I comandanti militari tendono a pianificare e combattere una nuova guerra in modo
analogo all’ultima che hanno vinto, ma in realtà non sono i soli. È naturale perciò
che lei faccia questa domanda: il New Deal di Roosevelt fu senza dubbio una grande
vittoria, che consentì di salvare il capitalismo dalle conseguenze più atroci delle
sue congenite tendenze suicide. E lo stesso può dirsi delle altre iniziative prese
dopo la guerra nella parte «sviluppata» del mondo per emulare e sviluppare l’idea
di Roosevelt di mettere in campo le forze dello Stato per dare logica e ordine alle
prassi illogiche e caotiche del capitalismo esclusivamente dettate dall’intenzione
di massimizzare i profitti. Sappiamo ormai – siamo subissati di prove – che l’economia
capitalista non è affatto un sistema capace di autoregolarsi o mosso dalla «mano invisibile»
(ma esperta e scaltra) del mercato: essa produce invece una massiccia instabilità
ed è clamorosamente incapace di domarla e controllarla avvalendosi soltanto delle
sue (chiamiamole così) «inclinazioni naturali». Per parlare chiaro e tondo, quell’economia
produce disastri che da sola non riesce a controllare né tanto meno a evitare, né
è in grado di riparare i danni provocati da tali disastri. La capacità dell’economia
capitalista di «autocorreggersi» (come asseriscono alcuni economisti di corte) si
riduce al periodico scoppio di «bolle» (che portano con sé fallimenti a catena e disoccupazione
di massa), con costi immensi per la vita e le prospettive di coloro che dovrebbero
essere i beneficiari dell’intrinseca creatività del capitalismo...
Dal New Deal di Roosevelt a oggi, da questo punto di vista, nulla è cambiato. Ciò
che è cambiato sono le condizioni che avevano consentito di contemplare e attuare
quel «patto»: ne consegue che ogni possibilità di replica suscita un genere di dubbi
con cui Roosevelt e i suoi consiglieri non dovevano fare i conti. Una delle cose che
sono cambiate è che Roosevelt aveva davanti a sé la «sfida keynesiana» di riaccendere,
ricaricare, lubrificare e rimettere in forze l’industria, principale datore di lavoro
e dunque, indirettamente, creatore della domanda che avrebbe tenuto in piedi l’economia
di mercato e avrebbe fatto ripartire la produzione del sovrappiù necessario all’autoriproduzione
capitalistica. La sfida attuale, invece, penetra più in profondità: nei mercati finanziari,
che non creano molti posti di lavoro ma sono un anello indispensabile, e forse decisivo,
della «catena alimentare» di ogni datore di lavoro attuale e potenziale. Qualsiasi
analogia tra rianimare un’industria ridotta allo stremo dal calo della domanda e «ricapitalizzare»
istituti finanziari privi del denaro necessario per finanziare i prestiti appare non
solo superficiale, ma fuorviante. Come sottolineò vent’anni fa Hyman Minsky, i mercati
finanziari sono i principali responsabili della tendenza apparentemente insanabile
del capitalismo a produrre e riprodurre la propria instabilità e vulnerabilità e,
come ha recentemente notato Paul Wooley6, la dimensione esorbitante e assurda raggiunta in anni recenti da agenzie meramente
finanziarie e non produttive è funzione della propensione dei mercati borsistici al
«mordi e fuggi» e all’«effetto inerziale»: propensione che è molto difficile frenare
e impossibile bloccare. Wooley ha paragonato la crescita eccessiva e innaturale del
«settore finanziario» a un tumore che, come di solito fanno i tumori, se non viene
asportato in tempo finisce per distruggere l’organismo che lo ospita. Perciò se lo
Stato scende in campo mobilitando il potenziale dei contribuenti e la propria capacità
di credito sui mercati esteri per rianimare le agenzie finanziarie così come Roosevelt
rianimò le industrie americane che creavano lavoro, non farà che incoraggiare lo stesso
«mordi e fuggi» ed «effetto inerziale» che hanno reso virtualmente inevitabile l’attuale
catastrofe. Appena i creditori si renderanno conto che esiste un cuscinetto di sicurezza
– sotto la specie di uno Stato che accorre in aiuto non appena viene smascherato il
bluff del «vivere a credito» e non appena viene meno improvvisamente il gioco del
«prestare e farsi prestare» – l’unica cosa che è possibile «rianimare» è la voglia
di speculare e di correre rischi sperando in un ritorno finanziario immediato, senza
curarsi granché delle conseguenze e della sostenibilità a lungo termine di quel gioco.
Allora inevitabilmente inizierà a formarsi un’altra bolla. C’è poi da aggiungere che
ciò che vale per i creditori vale anche, fatte le debite proporzioni, per i debitori,
avvinti ai creditori nello stesso ciclo di tentazione-seduzione. Le transazioni di
credito non hanno per oggetto solo le somme di denaro prestate, ma servono anche a
riportare in auge la psicologia e gli stili di vita «mordi e fuggi». La grande bolla,
mentre cresce fino a scoppiare, è circondata da un gran numero di mini-bolle personali
o familiari, destinate a seguirla fino alla perdizione.
Un altro radicale cambiamento rispetto all’epoca del New Deal riguarda la «totalità»
nel cui ambito è ragionevole attendersi che l’economia trovi un equilibrio contabile
che la renda autosufficiente o almeno l’avvicini a una situazione di autosostenibilità.
Qualunque cosa presupponga e stia a indicare l’attuale rinascita di sentimenti tribali
e politiche del tipo «Alle tue tende, Israele» (come quando Gordon Brown ha ripreso
lo slogan British jobs for British people lanciato dal British National Party), quella «totalità» non può più essere racchiusa
nei confini di uno Stato-nazione o di una confederazione di Stati-nazione, ma è ormai
globale. Per quanto i governi cerchino di isolare la propria porzione di globo dalle
tendenze e condizioni di scambio globali, le misure che possono prendere hanno efficacia
di breve durata, mentre a lungo andare i loro effetti rischiano di essere gravemente
controproducenti. Lo «spazio dei flussi» globale, per citare la memorabile definizione
di Manuel Castells, rimane ostinatamente irraggiungibile per istituzioni (come i governi
degli Stati) confinate nello «spazio dei luoghi». Qualsiasi frontiera politica è troppo
porosa per pensare che i provvedimenti presi nel territorio di uno Stato resistano
a flussi di capitale che inevitabilmente tendono a ribaltarne le finalità.
Karl Marx, profeticamente, previde una situazione in cui i capitalisti, pur mossi
esclusivamente dal proprio interesse egoistico, avrebbero finito per accettare che
lo Stato intervenisse imponendo agli imprenditori quei tipi di vincoli che essi individualmente
non possono introdurre finché i loro concorrenti hanno la possibilità di sottrarvisi.
Marx si riferiva al lavoro minorile e alla compressione del salario sotto la soglia
di povertà: politiche che, adottate da ogni capitalista per prevalere sui concorrenti,
a lungo andare avrebbero necessariamente creato problemi e prodotto effetti catastrofici
per i capitalisti nel loro insieme, nel momento in cui si fossero esaurite le riserve
di manodopera e si fosse ridotta o azzerata la capacità di lavoro di operai nutriti,
vestiti, alloggiati e istruiti in modo inadeguato. Queste prassi dannose, e in ultima
analisi suicide, si possono impedire solo collettivamente: a tal fine occorre un intervento
coercitivo e per così dire «servoassistito». Per salvaguardare gli interessi collettivi
del capitalismo, i singoli capitalisti devono essere costretti dalle autorità costituite,
tutti e nello stesso momento, ad accettare dei compromessi rispetto al proprio interesse;
o meglio devono essere obbligati ad abbandonare la definizione del proprio interesse
imposta dalla concorrenza senza regole, alla prendi-più-che-puoi.
Roosevelt seguì il modello previsto quasi un secolo prima da Marx, e lo stesso fecero
gli altri pionieri del welfare, che conobbemolte e varie versioni nazionali. Il «glorioso trentennio» del dopoguerra fu l’epoca
in cui l’effetto combinato del ricordo della depressione prebellica e dell’esperienza
bellica di mobilitazione delle risorse nazionali (quando Roosevelt, come detto, poté
ordinare alle case automobilistiche americane di sospendere tutta la produzione di
vetture private per fabbricare carri armati e cannoni per l’esercito) collocò «oltre
la destra e la sinistra» il tema dell’assicurazione collettiva obbligatoria contro
le conseguenze dell’affarismo individuale.
Ma quello splendido trentennio fu anche l’ultima epoca in cui era possibile prendere
una qualsiasi iniziativa sotto forma di leggi pensate, approvate e imposte nell’ambito
di uno Stato-nazione sovrano. Ben presto emerse una nuova condizione, e il numero
delle variabili contabili uscite (o estratte) dalla sfera posta sotto il controllo
del potere statale (o meglio dell’ambito territoriale della sovranità statale) divenne
troppo grande perché le istituzioni in un solo paese potessero responsabilmente avallare
quella polizza assicurativa contro i capricci e i tiri mancini del fato che opera
attraverso il mercato. E mentre i ricordi si affievolivano e le esperienze venivano
dimenticate, lo «Stato sociale», con la sua fitta rete di vincoli e di regole, perse
il suo consenso interclassista. È rimasta celebre l’insistenza di Margaret Thatcher
sull’idea che una medicina non aiuta a guarire se non è amara. Ma la stessa Thatcher
evitò di aggiungere che le pillole amare da lei somministrate (liberando il capitale
dalle catene e incatenando al tempo stesso, una dopo l’altra, tutte le forze potenzialmente
in grado di moderarne gli eccessi) dovevano essere inghiottite solo da alcuni, per
curare il malessere di altri. E nemmeno disse (per sua ignoranza, favorita e spalleggiata
da falsi profeti e maestri poco lungimiranti) che questo tipo di terapia prima o poi
provoca inevitabilmente disastri che in varia forma ricadono su tutti, e allora le
pillole amare toccheranno a tutti – o a quasi tutti. Il momento è arrivato, il «prima
o poi» è «adesso».
Le pillole che toccheranno a tutti noi rischiano di diventare ancora più amare perché
il frastuono assordante della «crisi del credito» ha quasi soffocato e nascosto altri
allarmi altrettanto o più urgenti. Se i leader che abbiamo eletto vogliono vincere
le elezioni, mostrarsi impegnati a far fronte agli allarmi che provocano più rumore
funziona molto meglio che affrontare altri allarmi, e perciò tende a catturare la
loro attenzione e i loro sforzi. Nel quadro delle previsioni sullo stato delle nostre
questioni collettive pubblicate nel «Guardian» del 27 dicembre 2008, è degno di nota
che, come ha scritto Polly Toynbee, in Gran Bretagna secondo i sondaggi solo un cittadino
su dieci considera il cambiamento del clima come una delle «principali questioni nazionali»,
mentre la stragrande maggioranza degli intervistati indica tra le priorità la criminalità
e l’economia. Ed è probabile, aggiunge Toynbee, che «la crisi distoglierà ulteriormente
l’attenzione pubblica dai cambiamenti climatici», e ancor più influenzerà le priorità
di governo. Madeleine Bunting insiste che per tirarci fuori dall’attuale situazione
serve un «cambiamento di valori» e che stavolta, a differenza dei precedenti episodi
di depressione, esso «dovrà durare più di qualche anno di recessione». Ma «il grande
paradosso», aggiunge, è che la sobrietà (necessaria per curare e risanare il nostro
stile di vita e dare un po’ più di sicurezza al futuro dei nostri figli) «è proprio
ciò da cui cercano di dissuaderci i nostri politici, disperatamente intenti a far
ripartire l’economia»: un’economia, aggiungo, dalla cui forma dipende l’attuale disastro;
un’economia che i politici cercano di farci credere non abbia un’alternativa valida.
Il «welfare state» nell’epoca della globalizzazione economica: ciò che resta del «Panopticon»
di Bentham. Sorvegliare i poveri o aiutarli?
Citlali Rovirosa-MadrazoUna delle tesi avanzate più spesso per spiegare il crollo finanziario globale è che
la regolazione della nostra economia, soprattutto nel settore finanziario e bancario,
era inadeguata. Si è ampiamente ammesso che, con l’imtroduzione di politiche neoliberiste
in tutto il mondo, iniziata negli anni Ottanta (come lei ha ricordato poco fa) con
l’amministrazione Reagan e con il governo di Margaret Thatcher, lo Stato si è «ristretto»;
da quando è scoppiata la crisi, espressioni come «Stato snello», «Stato debole», «Stato
fantasma» e simili echeggiano su tutti i media. In realtà, già molto prima del 2008
lei è stato un pioniere dell’analisi politica dello «Stato assente» (e della «società
assente»), ed è continuamente ritornato sul tema, in particolare con Il disagio della postmodernità (1997) e Liquid Times (2007)1.
Ma ecco il paradosso, che sembra contraddire la tesi della regolazione insufficiente
e dello Stato assente: se guardiamo alle agenzie di quello che alcuni continuano a
chiamare welfare state, esse danno l’illusione di una presenza incontenibile e travolgente, sembrano contenere
organismi solidi e duri come l’acciaio, che producono una regolazione eccessiva. E
in effetti queste agenzie sono molto presenti nel ruolo di regolatori; coloro, ad
esempio, che, in Gran Bretagna o in altri paesi europei, si trovano a dover fare affidamento
sulle istituzioni della sicurezza sociale non sembrano avere molti dubbi sull’«intervento»
dello Stato. Il welfare state appare un meccanismo solido e altamente strutturato per la riproduzione della gerarchia
sociale e di classe. E questo complesso lavoro di ingegneria sociale implica una regolazione
sia macro sia micro che nel sistema della sicurezza sociale, a differenza di quella
che secondo alcuni servirebbe a dare più forza allo Stato nei confronti del settore
finanziario e bancario, è organizzata meticolosamente e fino all’ultimo dettaglio:
in questa struttura nessuno deve essere «pagato». Non si intravede alcuna generosa
e compassionevole «mano invisibile» che accorra in aiuto di chi riceve i «benefici»;
non si prospetta alcun «salvataggio» per chi dipende dai «sussidi di disoccupazione»
o da altri emolumenti della sicurezza sociale: provate a tenere una sola sterlina
più di «ciò che occorre per vivere secondo la legge» (sic) e sarete legalmente perseguiti. La domanda è: si tratta di semplici incongruenze,
giustapposizioni e paradossi? L’«impossibilità dello Stato» è una spia del fallimento
o del successo dello Stato? L’iperregolazione delle agenzie della sicurezza sociale
– che si contrappone alla scarsa regolazione in campo finanziario e bancario – attesta
la natura classista dello Stato e il suo ruolo nella riproduzione delle gerarchie
e delle ineguaglianze sociali, oppure, più semplicemente, ci troviamo di fronte a
uno Stato che «è» ma forse «non esiste» (che un momento si vede e un attimo dopo scompare)?
Zygmunt BaumanIl contesto cui lei si riferisce non è lo «Stato sociale», nome che ho proposto di
dare al welfare state nelle intenzioni e prassi delle origini. Nonostante la continuità organizzativo-burocratica
con lo Stato sociale e l’evidente somiglianza di clientela, quello che lei ha descritto
è, come si suol dire, «tutto un altro paio di maniche».
Lo Stato sociale, così come fu originariamente concepito da Bismarck in Germania o
da Lloyd George in Gran Bretagna, era stato progettato per promuovere gli interessi
vitali della società di produttori/soldati e assicurarne un funzionamento senza problemi.
Quella società misurava la propria forza sul numero di maschi fisicamente abili in
grado di affrontare e reggere le sfide della fabbrica e del campo di battaglia. Anche
quando non erano in servizio attivo (disoccupati o riservisti) essi dovevano essere
pronti a rientrare nei ranghi nell’eventualità che la loro capacità di lavoro o di
combattimento si rendesse necessaria: dovevano essere adeguatamente nutriti, vestiti
e alloggiati, essere in buona salute e vivere in condizioni adatte a conservarla.
In una società di produttori/soldati dedicare risorse pubbliche a sostenere i costi
di tutto ciò era un buon investimento (o meglio un investimento necessario), era un
tema «oltre la destra e la sinistra», approvato quasi universalmente, anche se a malincuore.
Le battaglie dei sindacati per ottenere l’assicurazione statale contro i rigori della
povertà e della disoccupazione e la predicazione e pressione della parte più moralmente
sensibile dell’opinione pubblica non sarebbero servite a nulla se allo «Stato sociale»
non fosse stato riconosciuto, apertamente o tacitamente, un ruolo che consisteva in
quella che a posteriori Jürgen Habermas ha definito la «rimercificazione del capitale
e del lavoro», che assicurava la capacità e volontà del capitale di acquistare lavoro
e l’attrattività del lavoro per i suoi acquirenti, e che era l’attività cruciale dello
Stato, senza cui il capitalismo a lungo andare non sarebbe sopravvissuto.
Ora che ci allontaniamo dall’epoca delle conquiste territoriali e dell’industria di
massa («fordista»), i poveri non sono più considerati riservisti dell’industria e
delle forze armate da tenere in buone condizioni affinché possano essere richiamati
al servizio attivo in qualsiasi momento. Oggi investire nei poveri non è un «investimento
razionale». Essi sono una passività permanente, non un potenziale attivo. Le probabilità
che «rientrino nei ranghi» dell’industria sono scarse e i nuovi eserciti professionali,
piccoli e tirati a lucido, non hanno bisogno di carne da cannone. Il «problema dei
poveri», una volta visto come questione sociale, è stato in gran parte ridefinito
in termini di legge e ordine. È chiara la tendenza a «criminalizzare» la povertà,
come testimonia l’avvento del termine «sottoclasse» al posto di espressioni come classi
«inferiori», «lavoratrici» o «indigenti»: a differenza di queste, il concetto underclass suggerisce l’esistenza di una categoria non solo al di «sotto» delle altre classi,
ma al di fuori del sistema stesso delle classi, ossia della società. Lo Stato non
dedica più le sue attenzioni alla povertà con lo scopo primario e fondamentale di
tenere in buone condizioni i poveri, ma con quello di sorvegliarli e di evitare che
facciano danni o che creino problemi, controllandoli, osservandoli e disciplinandoli.
Le agenzie che si occupano dei poveri e degli oziosi non sono una prosecuzione dello
«Stato sociale»; sono, in tutto salvo il nome, le ultime vestigia del Panopticon di
Jeremy Bentham, o una versione aggiornata degli ospizi che precedettero l’avvento
del welfare state. Sono veicoli di esclusione assai più che di inclusione; strumenti per tenere non
dentro ma fuori chi è povero (e dunque difettoso come consumatore in una società di
consumatori).
Su un punto vorrei essere chiaro: ciò non denota alcuna «schizofrenia dello Stato»,
e nemmeno, come lei ipotizza, una «impossibilità dello Stato». Le politiche dello
Stato moderno, ispirate, oggi come ieri, all’«interesse dell’economia», quale che
sia, sono oggi, come erano ieri, «risposte razionali» adattate alla mutata condizione
della società. Lo «Stato sociale», che nella società dei produttori era di casa, nella
società dei consumatori è diventato un corpo estraneo e un ospite importuno. Non esistono
o quasi forze sociali disposte a sostenere questa idea, e tanto meno a mobilitarsi
per imporla e difenderla. Nella società dei consumatori la cura della sopravvivenza
e del benessere della maggior parte di noi è stata «sussidiarizzata» dallo Stato alle
preoccupazioni, risorse e capacità individuali. Ciò che oggi si definisce erroneamente
welfare state è un meccanismo che si occupa di quella parte residuale di individui incapaci di
assicurarsi la sopravvivenza perché privi di risorse adeguate. È un’agenzia che serve
a censire, separare ed escludere queste persone e a tenerle escluse e isolate ermeticamente
dalla parte «normale» della società. Ciò che questa agenzia gestisce è molto simile
a un ghetto senza mura, a un campo senza filo spinato (ma fitto di torrette d’osservazione!).
CRMIn Il disagio dellapostmodernità e in Vite di scarto2 lei ha preso in esame il fenomeno che ha definito «criminalizzazione della povertà».
Ha acutamente spiegato come il discorso sul welfare sia stato derubricato da cultura dei diritti dei cittadini a cultura della carità,
dell’umiliazione e del disonore3. Ha descritto efficacemente l’effetto che hanno avuto per la nostra vita la deregolazione
dell’economia e la globalizzazione economica; ha inesorabilmente e dolorosamente illustrato
come la «privatizzazione radicale del destino umano si accompagni da vicino alla deregolazione
radicale dell’industria e della finanza»4, e ha analizzato l’aumento del numero di esseri umani che vivono nella privazione.
La domanda è: la deregulation è l’unico problema, oppure l’incendio è aggravato da regole del gioco che cambiano
in continuazione, oscillando in modo pendolare tra regolazione e deregolazione? Le
agenzie che lei ha menzionato, che gestiscono qualcosa di «molto simile a un ghetto
senza mura, a un campo senza filo spinato (ma fitto di torrette d’osservazione!)»,
credo svolgano anche un ruolo nella ri-produzione e nel riciclaggio della povertà
e della gerarchia di classe. A questo punto ho l’impressione che lei, pur avendo idee
provocatorie su queste istituzioni, abbia mantenuto un certo grado di speranza idealistica
nel welfare state delle origini e ci esorti a vedere in quest’ultimo uno «Stato sociale», una «polizza
assicurativa collettiva». Mi sembra di cogliere una certa ambiguità nel modo in cui
lei guarda al welfare state nella sua versione originaria, ricevuta in eredità dalla Gran Bretagna del dopoguerra.
Non so se ciò dipenda da come lei lo vede (dando a intendere, in particolare in The Absence of Society,che non «possiamo lasciarlo andare») o se non voglia segnalare che il welfare state non ha ancora completato la propria transizione alla liquidità. Forse ciò accade
perché, come ho affermato sopra, abbiamo agenzie di sicurezza sociale solide e ferree
che iperregolano, e al tempo stesso «si ritirano» e «rischiano di estinguersi» via
via che subiscono tagli sempre più drastici? Che cosa abbiamo di fronte? Semplici
paradossi, incongruenze o mutazioni incomplete?
ZBL’ha detto in modo eccellente: paradossi, incongruenze o mutazioni incomplete? In
ogni cosa che facciamo (nell’esistenza individuale come nella storia) non partiamo
mai da zero. Il sito su cui costruiamo è sempre ingombro: il passato indugia in quello
stesso «presente» in cui il futuro cerca (a volte intenzionalmente, ma molto spesso
furtivamente e surrettiziamente) di mettere radici. Ogni continuità è zeppa di discontinuità;
nessuna discontinuità («rottura», inversione a U, «nuovo inizio») è priva di residui
e vestigia dello status quo ante. Adorno giustamente avvertiva che quando cerchiamo di rendere i nostri modelli coerenti,
armoniosi, eindeutig, «puri» ed eleganti sul piano logico (come tendiamo a fare, e non possiamo farne
a meno, ogni volta che teorizziamo) attribuiamo alla realtà, senza avvedercene, più
razionalità di quanta effettivamente abbia e possa avere. Per questo qualsiasi modello
teorico è un’utopia (intesa non necessariamente come «società buona», ma certamente
come «non luogo»). I nostri modelli teorici riescono a respirare e a muoversi liberamente
solo nell’habitat degli uffici accademici, delle aule dei seminari e dei convegni
scientifici, e si fermano solo quando si cristallizzano nella stampa o si registrano
in un video. D’altra parte il disordine dei nostri schemi, per quanto appaia sgradevole
e offensivo a una mente logica, a volte è frutto di disordine e sciatteria di pensiero,
ma spesso riproduce in modo equilibrato e fedele il disordine degli oggetti che descriviamo.
Ma torniamo all’oggetto della nostra attenzione: il welfare state (o «Stato sociale») e la sua difficile situazione. Vorrei puntualizzare subito che
l’idea di «Stato sociale» racchiudeva fin dall’inizio una contraddizione che lo rendeva
simile a una quadratura del cerchio. Tale idea mirava a coniugare libertà e sicurezza,
i due valori che sono in pari misura indispensabili a una vita soddisfacente o anche
solo accettabile, ma tra cui esiste notoriamente un reciproco rapporto di «amore-odio»:
ciascuno dei due non può vivere senza l’altro, ma non può neanche vivere pacificamente
e serenamente con l’altro. Come sappiamo, lo «scambio» tra libertà e sicurezza è stato
descritto da Freud. A suo avviso la sicurezza può essere accresciuta solo riducendo
la libertà, e a sua volta diminuisce quando la libertà aumenta. L’idea di Stato sociale
intendeva superare questa regola: ma è possibile?
La nostra era moderna è iniziata con la scoperta della «assenza di Dio». Il carattere
apparentemente casuale del destino (la mancanza cioè di un nesso visibile tra fortuna
e virtù, e tra disgrazia e vizio) fu assunto a prova del fatto che Dio non interviene
attivamente nel mondo che ha creato, ma lascia le faccende umane alle preoccupazioni
degli uomini e ai loro sforzi (erculei e sovrumani). Il vuoto apertosi così ai posti
di controllo del mondo doveva essere riempito dalla società degli uomini che tentava
di sostituire il cieco fato con la «regolazione normativa» e l’insicurezza dell’esistenza
con il governo della legge, e che intendeva assicurare chiunque ne facesse parte contro
i rischi dell’esistenza e le disgrazie individuali. Tale intenzione ha trovato la
sua manifestazione più completa in quell’ordinamento sociale comunemente detto welfare state.
Più di ogni altra cosa, il welfare state (che, ripeto, preferisco chiamare «Stato sociale», spostando l’accento dalla distribuzione
di benefici materiali alle sue motivazioni e finalità condivise) era un’organizzazione
per la convivenza umana che sembra inventata appositamente per evitare la tendenza
attuale a spezzare le reti di legami tra gli uomini e a minare le basi sociali della
solidarietà – tendenza innescata, rafforzata ed esasperata dall’impulso alla «privatizzazione»,
nome in codice della promozione di schemi sostanzialmente anticomunitari e individualizzanti
tipici dello stile consumistico, che pongono gli individui in concorrenza l’uno con
l’altro. Men
...